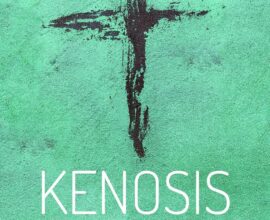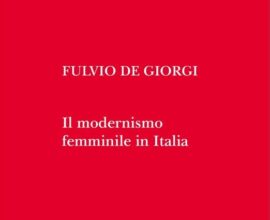IL “DOLORE MINIMO” DEL GENERARE SE STESSA

“Essere come voi non è così facile;
sembra ma non lo è sembra
cosa tanto facile essere con voi ma
cosa tanto facile non è.”
La citazione in limine di Amalia Rosselli introduce significativamente il prezioso libro poetico d’esordio della ventiquattrenne (classe 1994) Giovanna Cristina Vivinetto. La raccolta non ha nulla dell’impressionismo che ci si potrebbe attendere dalla produzione di una poetessa tanto giovane ma ha già forma compiuta di canzoniere che racconta, con sorprendente maturità poetica e umana, la transessualità come una storia di rinascita e individuazione. Il ritmo è lento, l’atmosfera malinconica ma anche, nelle prime due sezioni, mitica e incantata, allusiva a un’esperienza di solitudine mai del tutto narrabile. Il titolo, Dolore minimo, rinvia programmaticamente a una scelta minimalista di reticenza e classica compostezza, in cui la discesa agli inferi che prelude alla seconda nascita è evocata per accenni e la violenza (chimica, chirurgica, psichica, sociale) connaturata alla metamorfosi non è mai gridata. Nascita seconda, connotata dall’anomala identificazione di colei che genera e di colei che viene generata, benché mai narcisisticamente dimentica delle radici e del debito d’origine, consapevole com’è della sua dolente ma accettata e amata parzialità: “Non mi sono mai conosciuta/se non nel dolore bambino/di avvertirmi a un tratto/così divisa. Così tanto/parziale.” L’autogenerazione si compie progressivamente nel transitare dal dato biologico e dalle circostanze della prima nascita alla conquista progressiva di un’identità più profonda, da sempre presente e in attesa pur essendo, al tempo stesso, il frutto di una scelta consapevole ed esistenzialmente costosa, che domanda, per rendersi accessibile e poter riabitare il mondo, un corpo diverso, di figlia, di donna:
“Capimmo così/che se la prima nascita era tutta/casualità, biologia, incertezza – l’altra,/questa, fu scelta, fu attesa, fu penitenza:/fu esporsi al mondo per abolirlo,/pazientemente riabitarlo.”
Il processo di acquisizione del corpo transessuale è percepito e reso come “un ritorno/al feto e alla pancia. Un salto/ all’indietro verso la confusione/acquorea delle forme nel buio/imprecisato della madre.”
Scelta avvertita come ineludibile giacché:
Stare allora nel corpo
era come indugiare in una stanza
in cui non si può più restare.
Comincia così a disegnarsi, dalla prima sezione intitolata “Cespugli d’infanzia”, una parabola integrante in sé l’anamnesi del prima, nonché la ricerca del punto in cui è emersa l’ineluttabile consapevolezza. La conseguente decisione si configura poeticamente come adesione a una verità di natura e come uno scampare alla morte, ma assume anche le cifre vocazionali della malattia che spazza via ogni certezza, ogni appiglio alla tradizione e alla convenzione, mentre inchioda a una croce e toglie la vista:
La malattia giunse d’agosto. Travolse le madonne e gli occhielli,
ruppe gli incroci,
non diede il tempo
per chiudere le finestre.
Mi inchiodò sprovvista di fede
su una croce qualsiasi
della grande scacchiera. Mi scoprì inadatta alla simmetria
delle proporzioni-alla retta
sempre fedele a se stessa.
Imparai così dall’imperfezione
degli alberi nel farmi ramo sottile
e spigoloso per tendere
obliquamente
alla verità della luce.
Il transito è un perdersi. Smarrirsi archetipicamente nel bosco; storia di perdite e scoperte che indicano una continuità ritrovata nella ferita aperta di una più forte discontinuità: l’identità di ciò che si perde e di ciò che si scopre (le mani, la luce, il perdono) è ogni volta parziale ed è l’esito di un travaglio che non cancella la perdita ma la riscatta in un recupero più profondo e maturo. Così le mani perdute sono quelle del “tocco ingenuo/ che si addentrava nelle cose, le scopriva/ con piglio bambino- le plasmava”. Le mani scoperte sono quelle del “tocco adulto che sa/esattamente dove posarsi (…) Mani che sanno aggrapparsi anche/all’esatta consistenza del nulla.” La luce piena e abbacinante del paesaggio siciliano nel quale l’autrice è cresciuta, quella luce che “era tutto”, viene perduta e poi sostituita “dalla luce delle case al tramonto – che si mischia all’ombra,/ la luce setacciata dall’intreccio/ dei rami e quella che si schiarisce/ a fatica dopo un temporale/-dopo un grave malanno.” È la luce nuova e intatta “delle fonti d’acqua/ perenni che nessuno sa”. Il ritrovamento del perdono perduto è un lasciare andare, “adultamente”, il filo rosso dell’infanzia: recisione e separazione che è possibilità di un nuovo incontro con la madre su un superiore piano di verità e consapevolezza e di perdono “tondo e commosso”.
La madre, nella prima sezione del libro, appare investita di rimandi mitici alla Sibilla cumana, o all’indovino androgino Tiresia, che ambiguamente adombra anche quel figlio da subito preconizzato nel mistero del suo singolare destino: “Già dal primo vagito comprese/ che il mio crescere sarebbe stato/ un ribelle scollarsi dalla carne,/ una lotta fratricida tra spirito/ e pelle.” Ma alla madre reale si sostituisce, in un momento cruciale e iniziatico, l’antichissima madre archetipica che si epifanizza sorgendo dagli interstizi dimenticati dell’anima e sembra identificarsi con la voce profonda e proterva della natura, pronunciando parole terribili, materne e paterne insieme, ed elargendo il dono della pietà e dell’accettazione di sé:
Solo ora comprendo
a ventidue anni e un nuovo nome
quanto male avrei fatto
a rinnegare l’antichissima voce
che mi ha fatto salva la vita.
Il percorso poetico prosegue facendosi a tratti interlocutorio, quando la se stessa divenuta madre si rivolge alla sé figlia, dapprima soltanto presagita quasi con ostilità, poi progressivamente accolta, accettata, teneramente amata:
Di tutto quel fondersi violento
capii che darti spazio non fu
annullamento né mutilazione,
non fu rinuncia, non negazione:
fu cederti lievemente il passo,
farmi fiaccola della tua luce.
L’esperienza della dolorosa acquisizione di identità è vissuta anche come la prova e l’esperienza di un amore che si rivela incondizionato “nell’inchiodarti alla tua debolezza”, nella coscienza che:
non serve a niente
dilaniarsi pezzo dopo pezzo il corpo
per renderlo accessibile
se non si riesce a sedersi
con se stessi.
La trasformazione è dunque vissuta sempre nel segno della fragilità, di un limite consapevole di se stesso e del proprio sacrificio, delle ferite e delle “cicatrici che restano e neppure/quelle il corpo dimentica.” E tuttavia: “È come se la natura, liberata,/ vi ballasse ora adagio sopra/ a ricordarci che mai a niente/ si rinuncia per sempre.”
Anche, si declina come un essere tra, un essere in mezzo, un’indefinitezza che cerca tuttavia appunto in quanto tale una propria individuazione e definizione, un proprio e altrui riconoscimento:
Mi spiegarono la differenza
tra uomo e donna – le caratteristiche
elementari del maschio
e della femmina. Non mi rivelarono però
a quel tempo cosa
si trovasse nel mezzo, all’incrocio
imprevisto tra i due sessi.
Crebbi con una dicotomia nelle ossa
nel perenne adattamento all’una
o all’altra identità.
Solo dieci anni dopo compresi
che esattamente nel mezzo
– Indefinita, sfumata, disforica –
c’ero proprio io.
Non è un accidenti dunque in questa pur pacatamente antifrastica e paradossale ricerca di definizione l’insistenza quasi ossessiva sul tema del nome, sul “dolore dei nomi”:
E chi fugge dai nomi sappia
che non si sfugge alla nominazione
perché i nomi legano in nodi
di verità strette da calzare,
costringono in sillabe da pronunciare
a denti stretti. Da far male.
Il nome, nel suo essere retaggio e zavorra come nell’elisione che la successiva rinominazione comporta, è doloroso; ma sorridente scoperta è riceverlo come dono nascosto e casuale, biglietto appallottolato nella tasca di un amante:
Non so come l’avessi proprio tu
quello che in vent’anni andavo cercando.
Perché proprio tu e non un altro
– così caro verso questa carne
che a stento si riconosce –
ma per sbaglio nella tasca destra
dei tuoi pantaloni, prima di andartene,
appallottolato ho trovato il mio nome.
Ed è così buffo sapere che ti apparteneva
prima ancora d’appartenere a me.
Al motivo del nome è legato quello, anch’esso insistito, di una cesura con il mondo dei padri: il proprio e quello della madre. Il nome originario, Giovanni, è lo stesso del nonno materno. Con la morte di Giovanni e la nascita di Giovanna è il padre della madre a morire simbolicamente una seconda volta.
Nelle ultime sezioni la poesia di Giovanna Cristina Vivinetto acquista un’intonazione e un ritmo via via più prosastici e un registro più quotidiano e referenziale. La metamorfosi del corpo è ormai compiuta. Resta da raccontare il lutto, definitivo quanto non del tutto convinto e forse mai pienamente consumabile, di Giovanni:
Non esisti più Giovanni,
perché non basta una lama di sole
a riportarti nel pulviscolo vorticoso.
Non esisti mi convinco tamburellando
Sulle guance le dita. Quelle stesse dita
che un tempo furono le tue.
Ma il “dolore minimo”, la sua ricorrenza e persistenza, è soprattutto quello che si annida e conficca nelle deficienze, nelle omissioni e nei lapsus dell’empatia, dell’accettazione, del riconoscimento. Negli ordinari fallimenti dell’amore:
Quando lui avanti cammina
– mentre prima andavate insieme –
senza assecondare il tuo passo,
non cercando la tua mano con la sua.
Quando lui cammina avanti da solo
c’è un dolore minimo
che si è conficcato tra voi.
Il dolore è anche quello “non comune”, che lega e insieme distanzia, nelle sue differenti radici e motivazioni, i membri della famiglia. È il non comune dolore della madre che “Ricorda d’aver avuto un figlio,/ e anche il treno su cui è salito in agosto per costruirsi un futuro./ Alla stazione di Siracusa l’ha visto/ tornare il suo figlio maschio, dopo anni./ Era lì davanti a lei ma non era più maschio./ Una femmina, una giovane donna..(…) Che dolore, che dolore non comune, pensava,/non averti data alla luce, figlia mia,/ quando bisognava.” È il dolore non comune del padre: “Com’è possibile/accorgersi dopo diciannove anni/che quel figlio maschio non era:/quali errori, quali nemesi/dei padri l’avevano colpito?” Quello, misconosciuto, del fratello che preferisce tentare di eluderlo rifugiandosi in un inespresso rifiuto, anteponendo il sentire sociale a verità più profonde.
È, soprattutto, il dolore non comune della figlia:
Guardatela bene: è appena nata
ma da nessuno è stata generata.
Nessun padre l’ha voluta, nessuna
madre con dolore l’ha partorita.
É venuta
al mondo con la vivida certezza
di splendere sola nella diversità.
Non chiede perciò dolori comuni.
La ferita da cui è nata è ancora aperta:
non curatela, dice, sono vent’anni
che aspetto di farmi entrare
la luce. Guardatele il corpo:
un dolore non comune
riluce.
Dolore non comune e al tempo stesso universalmente umano, quello che coincide con una conclusiva e adulta perdita di consolazione; perdita che peraltro sembra essere al tempo stesso anche viatico del coraggio oltre la “grande paura” e inizio di una vita nuova nel mondo condiviso con gli altri, dove il “dolore minimo”, ma anche la salvezza, è in una propria, ultima, irriducibile, non confortabile solitudine:
E ora che ho imparato ad amarti,
tu, sofferta mia consolazione, tu ora
hai deciso di non esserci più.
Ora che una grande paura mi prende.
Ora che so di dover andare sola.
Simonetta Giovannini