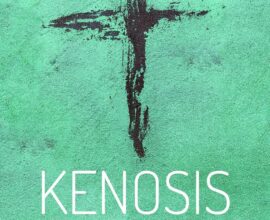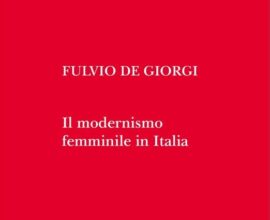LA LEGGE DELLA PAROLA CHE SALVA
Assonanze e radici bibliche nella psicoanalisi
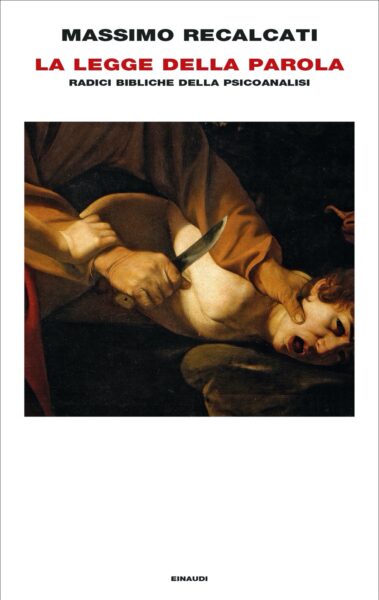
Massimo Recalcati negli anni scorsi aveva già diretto la sua attenzione verso singoli episodi del Vangelo (La notte del Getsemani) e della Bibbia (Il gesto di Caino e Il grido di Giobbe). Ora con il bel saggio La Legge della parola (Einaudi, 2022, pagg. XIV – 386, euro 21) riordina e organizza le precedenti tesi embrionali in un disegno organico più vasto e unitario. Come ha opportunamente sottolineato il filosofo Roberto Esposito, “non si tratta di un’interpretazione psicoanalitica della Bibbia e neanche di una declinazione religiosa della psicoanalisi. Ma di un incontro di linguaggi diversi, che tali restano, reso possibile da un presupposto comune: esiste una legge non al servizio della morte – della colpa e del castigo -, ma destinata a generare nuova vita. Si tratta della legge della parola. Essa chiede all’uomo di non volersi fare Dio, di ammettere la propria finitezza, di riconoscere la tensione che attraversa la sua esperienza, umanizzandola.”. È di evidenza comune il fatto che sia al centro della psicoanalisi – come Freud e Lacan confermano – sia al centro del culto religioso domenicale ci sia l’esperienza della parola.
Seguendo questa sorta di filo rosso, il libro pone a tema nove episodi fondamentali della Bibbia, che conviene seguire nel dettaglio, a partire dalla Creazione. Recalcati osserva subito che “la potenza dell’atto divino della creazione coincide con quella della sua parola”. E cita a sostegno il suo maestro Lacan che nel Seminario XVI afferma: il Dio biblico “parla (…) si tratta di un Dio che si definisce per il suo rapporto con la parola, che è un Dio che parla”. La parola di Dio, quindi, dà vita all’essere del mondo, dà ordine all’informe. Non è senza significato il fatto che la prima volontà di Dio nel Genesi sia contenuta nella frase “Sia la luce!” né ricordare che il significato etimologico della parola Dio, dal sanscrito dewos da cui il greco Zeus e il latino Deus, sia, appunto, “il luminoso”, “luce”. L’autore identifica in questo il potere creatore della parola, cioè “luce che illumina in modo inedito le cose” ovvero, in altre parole, la condizione perché il non essere venga all’essere. Ma mette in guardia opportunamente Recalcati: il linguaggio non è come un vestito aderente alle cose e non ci sono prima le cose e poi le parole che le nominano ma è piuttosto la nominazione delle cose che le fa esistere.
Se quello della parola è il “primo taglio” introdotto nell’esistenza umana, il “secondo taglio” consiste, secondo il nostro autore, nella “divisione biblica del soggetto” cioè in uno scarto originario: “da una parte la sua immanenza, il legame dell’umano con la terra, dall’altra la sua trascendenza, la spinta dell’umano verso l’Altro”. Anche qui giova ricordare – come del resto tutti sanno – che uomo deriva da “homo”, cioè da “humus”, terra e che Adamo, il mitico primo uomo, deve il suo nome da “adam”, cioè zolla, terra e “adamah” è la polvere. Questo per rammentare che l’uomo è costituito ontologicamente da una radicale mancanza d’essere – come non cessavano di ricordare sia Sartre sia Lacan – e circoscritto in una invalicabile finitudine terrena. L’uomo, quindi, non può pretendere di essere il sovrano della terra né di essere tutto ma deve concepirsi – umilmente, appunto – come suo ospite provvisorio.
Pagine intense e vibranti sono dedicate al tema della differenza sessuale, sovvertendo la visione tradizionale che vorrebbe la donna subordinata all’uomo, semplice proiezione ideologica dell’impianto patriarcale della società ebraica. La visione oleografica e fuorviante che identifica Eva come “scaturita” da una costola di Adamo viene confutata e rovesciata. Secondo l’autore, “il mito della costola perduta è il mito d’origine del desiderio umano: ricercare nell’altro la parte più irraggiungibile di me stesso”.
L’Autore invita, anche, a non chiudere gli occhi sulla verità della natura originaria dell’odio e della violenza, come già affermava Freud. Recalcati osserva che il primo atto dell’uomo fuori dall’Eden è quello della violenza fratricida. La vicenda di Caino sta ad indicare che la rivalità con l’altro viene prima dell’amore per il prossimo e che le relazioni in origine non sono armoniche ed empatiche. Sarà successivamente Gesù nei Vangeli a porre al centro della vita cristiana il comandamento dell’amore
Nella vicenda del diluvio universale Recalcati interpreta la metafora di una “furia manipolatrice [che] ha ridotto la terra a mera risorsa da sfruttare. Anziché essere l’orizzonte del nostro abitare comune, la terra viene saccheggiata dalla violenza ecocida dell’uomo. Siamo al fondamento del narcisismo antropocentrico”. (p.96). In altri termini, l’atteggiamento tracotante dell’uomo nei confronti della natura è quella del padrone e non dell’ospite provvisorio.
Nel commento al Cantico Recalcati raggiunge vertici di felicità espressiva e di affascinante profondità. Questo capolavoro assoluto della letteratura di ogni tempo “mostra la gioia della vita, lo splendore delle creature, l’erotismo che accompagna l’incontro dei corpi” (p.324). La bellezza del Cantico consiste nell’esaltazione del corpo, attraversato dalla vibrazione d’amore, che “in quanto erotico è già in se stesso spirituale” (p.319). Al centro è la figura dell’Altro “come meta del desiderio e segnale della sua impossibilità”. Tuttavia, avverte l’Autore, il tutto dell’amore non è a disposizione di nessun amante, non può diventare una proprietà e, pertanto, esso è segnato dall’erranza.
L’Autore dedica altre belle e dense pagine al delirio dei babelici, al sacrificio di Isacco e alla figura di Giacobbe, sempre seguendo il filo rosso della legge della Parola. È quella legge che, capovolgendo la logica umana dell’odio e della violenza, si profila sempre più come la legge divina dell’amore. Nella tensione di sviluppare questi temi, Recalcati ha preannunciato di dedicare un secondo libro a rintracciare assonanze e radici della psicoanalisi nei Vangeli, libro che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi. In viva attesa del nuovo saggio, mi auguro che questo studio autorevole di uno dei maggiori pensatori italiani – “La Legge della parola” – possa avere ampia diffusione, essendo convinto di aver letto e approfondito non un libro estemporaneo ma un saggio destinato a durare.
Paolo Quintavalla
Massimo Recalcati, La Legge della parola, Radici bibliche della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2022, pagg. XIV – 386.
Nota: Su alcuni passaggi della recensione si può leggere una Scheda di approfondimento