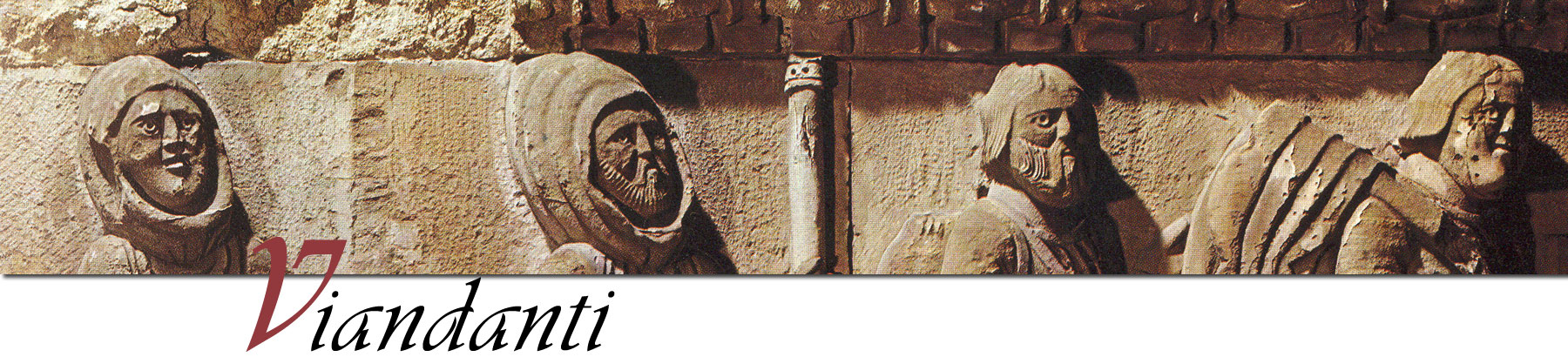ESSERE, DIVENTARE VIANDANTI
IL CONTENDERE DELL’UOMO CON DIO
Marco Bertè
Nel cammino verso la nostra Assemblea soci, che si terrà il 30 novembre, stiamo pubblicando a puntate le riflessioni, o meglio la lunga meditazione sull’essere viandanti, che Marco Bertè, uno dei soci fondatori, ci ha donato con questa dedica: “Una meditazione dedicata agli amici dell’Associazione Viandanti, con il piacere di ricordare un’idea e un’amicizia”. Una preparazione remota della quale ringraziamo molto Marco. [V]
** ** **
Il primo versetto di Genesi 22 recita: “Dio mise alla prova Abramo”. In che cosa consiste la prova? Nel rinunciare a tutto? Nel rimanere sospesi, riproponendosi ancora e sempre l’impossibile alternativa di ogni vivere, tra l’andare verso di sé o l’andare verso altro o altri? Nel camminare verso Dio rinunciando a camminare verso di sé? Oppure nel dubitare di quello stesso Dio sul quale è stata riposta la più alta forma di fede ed ogni speranza? O nel provare a contendere con Dio?
Forse un po’ tutto questo. Forse la prova consiste nel dubitare di Dio e nel contendere con Lui, nel misurarsi con l’Assoluto, nel tentare l’inconcepibile. Dio ha messo alla prova Abramo, ingiungendogli di sacrificare il figlio, – e Abramo mette alla prova Dio. È quello che risulta dalle parole con cui Abramo risponde ad Isacco che lo interroga: Dio si procurerà l’agnello, cioè lo procurerà a se stesso. Il senso più profondo di Genesi 22 è il contendere dell’uomo con Dio e di Dio con l’uomo.
La lotta di Giacobbe
Il contendere con Dio assume una forma chiara ed esplicita nella lotta di Giacobbe con “un uomo” (o un angelo, o Dio stesso?) sulla riva del fiume Jabbock. Per la verità, prima di questo frangente, Giacobbe non ha nulla né della grandezza e della fede di Abramo né del coraggio di Isacco. Mostra piuttosto furberia nell’architettare inganni e sotterfugi e paura nel darsi alla fuga.
Pretende dal fratello Esaù la cessione dei diritti del primogenito in cambio d’un piatto di lenticchie ed inganna il padre Isacco, ormai vecchio e cieco, fingendosi Esaù e carpendogli la benedizione, garanzia del conferimento della primogenitura. Al che il fratello, una volta scoperto l’inganno, lo insegue furibondo, deciso ad ucciderlo. E Giacobbe, dominato da una paura mortale, fugge fino a rifugiarsi in Carran, da Labano, fratello di sua madre.
Inizia così il suo cammino da viandante sempre in fuga. Rimane a lungo in Carran, prestando la sua opera, costretto da Labano, da cui è a sua volta ingannato. Architetta allora nuovi sotterfugi per organizzare il ritorno e prendere finalmente possesso del potere garantito dalla benedizione paterna. Si avvia, fuggendo anche da Labano, di nascosto, e ancora dominato dalla paura del fratello, che si sta muovendo in armi contro di lui
Giunto sulla riva dello Jabbock, oltre il quale iniziavano i territori di Esaù, Giacobbe si ferma, manda avanti persone e beni con cui era arrivato ed attende pieno di angoscia, ancora dominato dalla paura del fratello.
«Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: “Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora”. Giacobbe rispose: “Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!”. Gli domandò: “Come ti chiami?”. Rispose: “Giacobbe”. Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!”. Giacobbe allora gli chiese: “Svelami il tuo nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome?”. E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: “Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva”. Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca» (Gen 32, 23-32).
Dall’andamento della lotta e dal dialogo dei due contendenti si capisce che ciò che è in gioco non è il sopravvento dell’uno o dell’altro. Giacobbe mira ad ottenere la benedizione, l’aiuto divino. Dio mira a trasformare Giacobbe, a renderlo all’altezza della sua missione. Ma Giacobbe vorrebbe di più, vorrebbe addirittura poter disporre di Dio, non lascia andare colui con cui sta lottando. E Dio gli cambia il nome, lo chiama Israele: dunque, lo trasforma. E quando Giacobbe chiede a Dio quale sia il suo nome (per poterne disporre), Dio si rifiuta, si mantiene nel suo mistero e però lo benedice. Attraverso la lotta Giacobbe viene dunque trasformato: una trasformazione che gli consente di andare incontro al fratello, di riconciliarsi con lui e di porsi alla guida del popolo di Israele.
Una lotta che trasforma
Ci sono, in questo racconto, dei motivi importanti, presenti in Genesi 22. Anzitutto il dubbio su Dio: ma è proprio Dio questo essere che lotta con Giacobbe e non riesce a vincerlo e nemmeno riesce a liberarsi dalla sua stretta? E se lo è, che Dio è questo, che lotta con l’uomo e nel contempo lo benedice e si ritrae nel mistero, intento a sempre di nuovo velarsi e svelarsi, ri-velarsi nascondersi e manifestarsi?
Il secondo motivo, evidentemente, è quello della lotta, della contesa. Com’è possibile che l’uomo possa contendere con Dio? E non solamente sfidandolo – il “Dio si procurerà l’agnello” di Genesi 22 – ma in una vera e propria lotta, in un confronto si direbbe ad armi pari? E se, com’è giusto ritenere, questa lotta ha solo un valore simbolico, è simbolo di che cosa? Di una lotta spirituale? Della difficoltà di credere? o di che altro?
Ed infine vi è in questo racconto un terzo motivo: la trasformazione dell’uomo. Abramo è trasformato dalla salita al monte Moria e dalla prospettiva di sacrificare il figlio: e riottiene non solo Isacco, ma tutto quello che gli era stato promesso e che sembrava perduto e può rimettersi in cammino, ascoltando la voce che lo chiama, andando verso la terra promessa e la discendenza innumerevole. E così Giacobbe: è trasformato dalla lotta con l’essere divino, dall’avere combattuto con Dio e con gli uomini ed avere vinto. E grazie a ciò può conciliarsi con il fratello e guidare il suo popolo, Israele. E può godere nuovamente d’ogni bene.
La logica del Satan
Il tema della lotta con Dio ritorna in tutta la sua drammaticità nella figura di Giobbe. Il Libro di Giobbe è una meditazione sul dolore umano e soprattutto sul mistero di Dio.
Dio ha stabilito una legge che l’uomo deve osservare. Se la osserva, se è fedele, il Signore lo premia. Se non la osserva, se non è fedele, il Signore lo punisce. Sta in questo il principio retributivo. La fedeltà è retribuita con un premio, l’infedeltà con una pena.
La situazione di Giobbe, com’è presentata all’inizio del libro, rispecchia fedelmente tale principio. Egli era uomo “integro e retto, timorato di Dio ed alieno dal male” (1,1; 1,8; 2,3). Era dunque fedele. Ed era ricco di figli e di beni. Aveva sette figli e tre figlie e possedeva settemila pecore, tremila cammelli, mille buoi e cinquecento asine. La sua fedeltà era retribuita con la sua ricchezza.
Le cose sono però destinate a mutare radicalmente. Avviene infatti che il Satan, uno spirito provocatore, si presenta al cospetto del Signore e gli rinfaccia che Giobbe è timorato di Dio perché lui, il Signore, lo gratifica di ogni bene. Se fosse colpito da mali e dolori non sarebbe più timorato di Dio. Ed ottiene di poter mettere alla prova Giobbe.
Suo intento è perseguitarlo fino ad indurlo a rinnegare il Signore. Il suo ragionamento si fonda su un ribaltamento del principio retributivo. Per il principio retributivo il male consegue all’infedeltà; per il Satan è vero l’inverso, l’infedeltà, il rinnegamento di Dio consegue ai mali e dolori sofferti: si rinnega Dio perché ci colpisce con mali e dolori insopportabili. È una scommessa. Il Satan scommette che Giobbe finirà per rinnegare il Signore e questi scommette che gli rimarrà fedele, a qualunque prova verrà sottoposto.
Dapprima il Satan priva Giobbe dei figli e dei beni e poi, fallito questo primo tentativo, lo colpisce con una dolorosissima ulcerazione che lo ricopre da capo a piedi. Ma Giobbe non cede.
Già da queste prime battute risulta chiaro che solo Dio e il Satan (oltre naturalmente all’autore e al lettore) sanno della scommessa fatta in cielo e che gli altri personaggi (Giobbe, la moglie e gli “amici” che entreranno presto in scena) non ne sanno nulla. Comunque, nonostante i mali e i dolori con cui il Satan lo colpisce, siano così insopportabili, Giobbe non cede. Non rinnega Dio ed arriva a dire che dobbiamo accettare da Dio anche i mali. (v. 1,2; 2,10)
La prova tuttavia continua. E diviene anche più bruciante, si inasprisce per una domanda che diventa un vero e proprio tormento: perché proprio a me accadono queste cose? perché si riversano su di me, che sono timorato e alieno dal male? perché Dio mi perseguita? perché il giusto è chiamato a soffrire, mentre il malvagio può godere della vita?
Domande più che legittime, se si considera che Giobbe nulla sa della scommessa fatta in cielo e che crede fermamente nel principio di retribuzione. Domande che denunciano come incomprensibile ed ingiusta la sua sorte. Il tormento è reso anche più acuto dalla incomprensione della moglie e dei cosiddetti “amici”.
La logica degli amici di Giobbe
Questi – Elifaz, Bildad e Tzofar – appena vengono a sapere cosa è accaduto a Giobbe, accorrono, sulle prime nemmeno lo riconoscono, si accoccolano vicino a lui, soffrono con lui.
Giobbe risponde agli interventi dei singoli amici e, quando questi si zittiscono perché a corto di argomenti, egli si diffonde in un lungo intervento che riprende ed amplia i temi già toccati. È allora che subentra Elihu, più giovane dei tre amici e indispettito verso di loro. Il suo atteggiamento è forse più amichevole, anche se sembra accusare Giobbe di ripudiare Dio, e comunque riconosce che la sofferenza del giusto può essere intesa come una prova da affrontare per meritare la salvezza.
Certo, vi sono fra i discorsi degli amici delle accentuazioni diverse, ma non vi è dubbio che essi, compreso Elihu, accusino Giobbe di peccato. Se soffri tanto, dicono, se Dio ti colpisce così duramente, per forza devi essere colpevole di qualcosa, tu o i tuoi figli, per forza devi aver peccato e gravemente, anche se non te ne rendi conto.
Il loro ragionamento si fonda sul principio retributivo, anche se interpretato in modo scorretto. Se è vero, pensano, che ad ogni colpa consegue una pena, è evidente che, se c’è una pena, all’origine deve esserci una colpa. In realtà, possiamo osservare, non si può escludere che il male possa avere anche altre origini. Ma essi non esitano ad incolparlo. Tu patisci un male e dunque una pena e dunque hai una colpa. Non ti resta che pentirti e chiedere aiuto al Signore.
Il rifiuto di Giobbe
Ma Giobbe non può, non vuole accettare questo argomentare. Lo contesta e soffre anche per questa incomprensione degli amici (e della moglie). Egli maledice il giorno in cui è nato, rimpiange di non esser morto appena uscito dal ventre materno, maledice le ginocchia che l’hanno accolto ed i seni che gli sono stati offerti e, rivolto a Dio, chiede: “Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Sarei morto e nessun occhio mi avrebbe mai visto! Sarei come uno che non è mai esistito; dal ventre sarei stato portato alla tomba!” (10, 18-19). Ed ancora, lamentando la sua condizione: “Dov’è dunque la mia speranza? Il mio bene chi lo vedrà?” (17,15). E rivolgendosi direttamente agli “amici”. “Istruitemi e allora io tacerò, fatemi capire in che cosa ho sbagliato” (6, 24).
Egli infatti è ben consapevole di essere integro e retto, timorato di Dio ed alieno dal male e sa bene che non può essergli applicato il principio di retribuzione perché, dice, “non ho rinnegato i decreti del Santo” (6, 10), per cui la persecuzione di cui soffre è incomprensibile ed ingiusta. “Ricredetevi: – soggiunge – non siate ingiusti! Ricredetevi: io sono nel giusto!” (6,29). E riprende gli stessi concetti verso la fine dei suoi interventi. “Lontano da me darvi ragione; fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità! Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere, la mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni” (27, 5-6).
Il silenzio di Dio
E però il suo lamento è rivolto sì ai mali e ai dolori, all’incomprensione della moglie e degli amici, ma progressivamente si rivolge sempre più a Dio, per chiederGli ragione, per parlare con Lui, per incontrarLo e conoscerLo meglio. Giacchè alla fine la prova più difficile da accettare ed affrontare è il silenzio di Dio, è il mistero di un Dio che sfugge ad ogni tentativo di comprensione.
Si profila così e viene ripresa, e in termini radicali, quella lotta con Dio che abbiamo potuto cogliere in Abramo e in Giacobbe. La protesta di innocenza, il bisogno di contendere, la voglia di sapere rivolti agli amici si ripetono ed accentuano nei confronti di Dio. Non prima, peraltro, di riconoscere che non è possibile, pur desiderandolo, confrontarsi con Lui e contrapporGlisi in giudizio.
Com’è possibile all’uomo, così debole e fragile, opporsi a Chi ha conoscenza, saggezza, potenza infinite? Eppure Giobbe non rinuncia a lottare. Ed a rivolgersi a Dio per sapere, per difendersi. “Non condannarmi, fammi sapere di cosa mi accusi! È forse bene per te opprimermi, disprezzare l’opera delle ue mani? (10, 2-3).
E mentre protesta la sua innocenza, sbotta nell’amara constatazione che ai malvagi toccano lunga vita e beni in abbondanza, mentre a lui, timorato di Dio ed alieno dal male, toccano privazioni e sofferenze. È un motivo, questo, ampiamente presente. Sul suo prolungamento vi è quella che possiamo considerare l’invettiva contro Dio più aspra. La troviamo verso la metà del libro. “Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Ecco, grido: “Violenza!”, ma non ho risposta, chiedo aiuto, ma non c’è giustizia!” (19, 6-7). Ecco il tormento che più angustia Giobbe e sta al centro del suo dramma.
Non vi è dubbio che sia Dio stesso a mettere Giobbe alla prova. La scommessa nei cieli e la figura del Satan infatti ben presto si eclissano. Non sono ricordati nemmeno alla fine. Vi è continuità con le prove affrontate da Abramo e da Giacobbe. Solo che nel caso dei due patriarchi il cosiddetto sacrificio di Isacco e la lotta con l’angelo sono episodi isolati, puntuali, mentre i tormenti di Giobbe abbracciano quasi un’intera vita e si acuiscono progressivamente. E possono ben rappresentare le condizioni dell’umano soffrire. E così, probabilmente, sono intesi dal viandante che li rivive.
La prova cui Giobbe è costretto dall’intervento divino è tutt’altro che puntuale e provoca in lui reazioni diverse e crescenti. Dapprima accetta le privazioni e sofferenze subite, poi, di fronte all’ambiguo atteggiamento degli amici, maledice il giorno della nascita protestando la sua innocenza, e continua lamentando la situazione in cui è precipitato e addirittura si rivolta contro Dio, fino a incolparlo di ingiustizia. Sembrerebbe quest’ultimo il momento più alto della sua ribellione. Ma, a ben vedere, il lamento più alto di Giobbe è per il silenzio di Dio, per il rifiuto divino di ascoltarlo, incontrarlo, dialogare con lui.
Inattingibile ma misericordioso
Da notare questo passaggio: gli “amici” vorrebbero costringere Giobbe ad accogliere l’atteggiamento di Dio, mentre Giobbe vorrebbe costringere Dio a manifestarsi, accoglierlo, parlare con lui. Come viene spesso notato, gli “amici” gli parlano di Dio, mentre lui vuol parlare con Dio. Ebbene, è proprio a questo punto che Dio si manifesta, risponde a Giobbe dalla bufera, dispiegando e mostrando tutta la sua grandezza, la sua potenza, il suo mistero.
A leggere i lunghi, severi discorsi di Dio si può essere indotti a credere che Egli voglia esibire l’altezza, larghezza e profondità del suo mistero esaltando la sua potenza e il dominio che ha sulla natura e sui viventi, fino a schiacciare l’uomo. In realtà col suo infinito domandare, cui Giobbe non sa né può rispondere, vuol mostrare la vastità e complessità del creato, che si sottraggono alle capacità umane di conoscenza ed intervento, e con ciò vuol ridimensionare radicalmente, di fronte a questa vastità e complessità, l’importanza della persona e della situazione di Giobbe e, dunque, delle sue sofferenze e delle sue pretese. Sì, poiché Giobbe tende a porsi al centro d’ogni cosa e d’ogni evento ed a preoccuparsi solo del suo Io, della sua vicenda, delle sue privazioni, delle condizioni intollerabili in cui si trova.
D’altra parte però Dio, pur mantenendosi nella sua radicale alterità, ha una grande attenzione per tutti gli esseri, dai più piccoli ai più grandi, dai più miti ai terrificanti, accoglie e segue tutti quasi commuovendosi del miracolo che ognuno è, prendendosene cura e mai dimenticandosene. Mostra così di essere non tanto l’Assoluto trascendente e inattingibile, ma il Signore misericordioso che può perciò disporsi ad accogliere tra le braccia anche lui, anche il povero Giobbe.
La rinuncia a contendere con Dio
E inizia così, finalmente, il dialogo lungamente e disperatamente richiesto – anzi: preteso! – da Giobbe. E all’invito del Signore, “cingiti i fianchi come un prode: ti interrogherò e tu mi istruirai!” (38,3 e 40,7) fa eco Giobbe: “ascoltami e io parlerò, io t’interrogherò e tu mi istruirai! Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto” (42, 4-5).
Con il dialogo avviato finisce la sofferenza di Giobbe e si apre il suo animo agli altri e all’Altro. Ottiene, moltiplicato, quel che aveva perduto. E, com’è avvenuto per Abramo e per Giacobbe, si trasforma, rinuncia a contendere con Dio e prega per gli amici, accoglie e aiuta gli uomini, ritrova il suo Signore. E per il suo Signore torna ad essere – anzi, ora è veramente e pienamente – l’uomo integro e retto, timorato di Dio ed alieno dal male.
L’epilogo sta tutto nella maledizione di Dio per i cosiddetti “amici”. Una maledizione ch’egli motiva due volte “perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe” (più convincente la traduzione di Amos Luzzatto: “perché non avete parlato volti a me con sincerità come il mio servo Giobbe”). Perché? possiamo chiederci. In che senso Giobbe, contrariamente agli “amici” ha parlato rivolto a Dio con sincerità? Perché, come abbiamo già ricordato, gli “amici” hanno parlato di Dio, mentre Giobbe ha parlato con Dio. E per poter parlare con Dio ha dovuto attraversare una prova difficile e dolorosa. E come Abramo e Giacobbe, si trasforma, diventa uomo nuovo.
E’ difficile non pensare che quel Dio che ha messo alla prova Abramo e che ha lottato con Giacobbe e che alla fine ha restituito ad Abramo il figlio Isacco e la sua missione ed ha dato a Giacobbe il coraggio di affrontare il fratello e porsi alla guida del suo popolo, – è difficile non pensare che è quello stesso Dio colui che ha sì ridotto Giobbe ad una larva di uomo, privandolo di tutto e distruggendolo con sofferenze inaudite, ma poi, alla fine, lo ha accolto in seno, risarcito dei mali e dei dolori sofferti, inondato di beni ben più ricchi di quelli perduti e rinnovato nelle profondità del suo essere.
Marco Bertè
Socio fondatore di Viandanti e membro del gruppo “Oggi la Chiesa” (Parma) che aderisce alla Rete dei Viandanti.
[Parte terza]
Parte prima: Essere, diventare viandanti. Camminare verso dove?
Parte seconda: Essere, diventare viandanti. Ulisse e Abramo
– – Nota – – – –
Questo editoriale è tratto da un testo più ampio intitolato, Essere, diventare viandanti. Verso dove? La versione integrale, in cartaceo, verrà consegnata ai partecipanti della prossima Assemblea dei soci di “Viandanti” (Parma, 30 novembre 2024).
[Pubblicato il 22.9.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: https://www.meisterdrucke.it/]