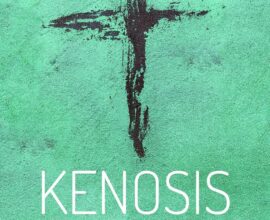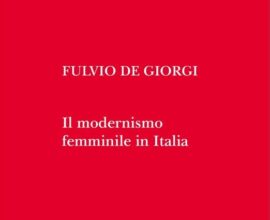INTRECCI TRA POLITICA E TEOLOGIA ALLE RADICI DELL’OCCIDENTE
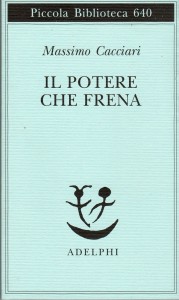
Lette le prime tre, quattro pagine de “Il potere che frena” (Adelphi) di Massimo Cacciari si è già dentro ad un dispositivo teoretico perfetto: se lo si accetta integralmente, se si ritiene utile ripercorrere il senso teologico della storia occidentale a partire dal misterioso concetto di katechon (ciò che o colui che frena, trattiene) presente nella Seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo (2, 6 -7), e quindi nel solco della tradizione cristiana e occidentale, da San Paolo e Agostino a Carl Schmitt, allora quello che proseguendo ci si trova a leggere è un saggio breve, ma complesso, affascinante, denso di senso.
Paolo, o chi per lui della sua cerchia dato che della paternità di questa epistola non si è sicuri, usa tale concetto accennandone appena e presupponendo che gli interlocutori sappiano a cosa si riferisce: la fine è già decisa, appena prima del Giudizio finale, s’imporrà nel mondo il regno dell’Anticristo e la lotta, la lotta perché ciò avvenga, è già in corso. A frenare l’imporsi dell’anomia anticristica (mysterium iniquitatis) è il katechon: l’impero? la chiesa? il potere politico o le strutture attraverso le quali si esercita? Che cosa è esattamente il katechon? E soprattutto – dato appunto che la fine dei tempi è decisa – cosa può essere oggi il katechon? Ci possono essere delle figure katechontiche riconoscibili o almeno percepibili nei loro effetti nella realtà attuale? Cacciari risponde a queste e a molte altre domande che nascono dall’analisi di questo concetto e lo fa a partire dal problema primo della teologia politica: ovvero la possibilità stessa di un rapporto, dinamico e insopprimibile, tra queste due sfere dell’esperienza umana e massimamente in un contesto religioso caratterizzato da una concezione trinitaria di Dio.
Il percorso seguito da Cacciari si dispiega quindi tracciando un territorio vasto che va dal rapporto tra questo concetto e la sostanza storica dell’impero romano prima e della Chiesa poi alla differenza e/o relazione tra epoche ed “evo”, da un excursus sul celebre passo di Marco 12, 17 (date a Cesare quel che è di Cesare) alla riflessione agostiniana sulle “due città” e al celeberrimo personaggio dostevskijano del grande inquisitore, per concludere concependo la nostra come “l’età di Epimeteo”. In quest’ultimo snodo il tono, se possibile, s’innalza ulteriormente: assistiamo all’indebolirsi di qualsiasi forma di potere politico “prometeico”, che abbia cioè la forza catecontica di proiettare e sostanziare in avanti la sua azione, e possiamo contemplare la rivincita del fratello sciocco di Prometeo, ovvero di Epimeteo “colui che vede dopo” e continua ad aprire il vaso di Pandora. «Quello di Epimeteo sarà piuttosto l’Evo dell’Insecuritas e delle crisi permanenti – spiega il filosofo –. Teologicamente, esso può rappresentare soltanto l’ultimo spasmo del tempo prima della Decisione; politicamente, la sua durata è imprevedibile, come sempre più imprevedibili si fanno i suoi momenti, mano a mano che il suo impeto indebolisce, fino a demolirli, gli ordinamenti catecontici».
Paolo Randazzo (da Europa Quotidiano, 10 maggio 2013