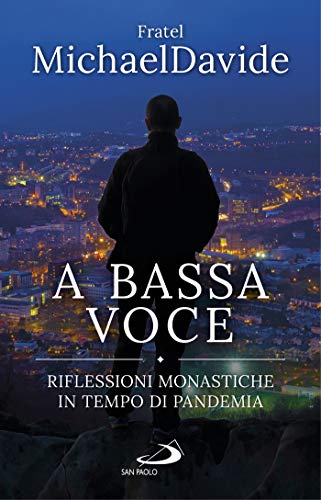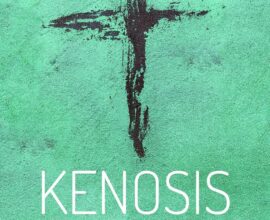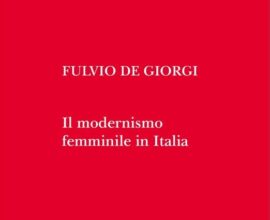A BASSA VOCE. EUCARESTIA E SERVIZIO
Umanità – humus – umiltà: da questa triade semantica prendono le mosse i pensieri di un monaco “atipico”, MichaelDavide Semeraro, prolifico scrittore e apprezzato conferenziere, che in un piccolo libro (edito dalla San Paolo e disponibile anche in e-book) condivide le riflessioni che ha maturato in questa quarantena e che offre all’attenzione di credenti e non credenti. Oltre a ripercorrere vissuti, esperienze, situazioni dei due mesi di clausura sperimentati obbligatoriamente da gran parte dell’umanità, pone interrogativi per il prossimo futuro e suggerisce un “compito a casa” utile per il domani nostro e della casa comune.
Umanità – humus – umiltà: il virus ci ha messi di fronte alla fragilità, alla vulnerabilità, all’insicurezza della nostra condizione umana e a una rinnovata consapevolezza della mortalità, di quell’humus «da cui siamo stati tratti e verso cui siamo chiamati a ritornare», e che «dovrebbe generare sempre l’humilitas». Abbandonare ambizioni di potenza, di successo, di visibilità, rinunciare ad abitudini consumistiche e performative, per accettare umilmente restrizioni che preservano la salute di tutti e obbligano a stare dentro limiti (di relazioni, di spazi, di movimento) che appaiono frammenti insufficienti, «può diventare l’occasione per cogliere l’essenziale e tenersi pronti a tutto».
La vita monastica, dentro o fuori le mura della clausura, si caratterizza perché preferisce la profondità alla superficialità, l’unità interiore alla molteplicità degli stimoli esteriori, la semplicità del quotidiano alla varietà delle esperienze “mondane”. Semeraro cita e porta ad esempio Etty Hillesum, la quale «senza perdere nulla delle personali inquietudini e della ribellione davanti alla sofferenza e al male», imparò ad «accettare le proprie pause», la lentezza e la custodia dell’interiorità per “restare umana” in un contesto di annientamento e disumanizzazione quale furono i campi di sterminio nazisti. Anche se potrebbe apparire azzardato ed eccessivo ricorrere a un modello come questo per incoraggiarci a vivere pienamente questo tempo di isolamento da contagio, il monaco “sa” che ogni sfida richiede l’impiego di tutte le forze, di tutte le energie, di tutte le intenzioni di cui è capace. E sa che ogni giorno può essere una sfida che richiede vigile e umile attenzione.
Riflettendo nel segno dell’appartenenza alla Chiesa, l’autore afferma che la situazione particolare che si è vissuta ha permesso «ai credenti di sperimentare una libertà profetica nel vivere il proprio sacerdozio battesimale». Ora che siamo nella “fase due” si parla di messe su prenotazione, di chiese a numero chiuso, di “diritto” di ogni cristiano alle celebrazioni e ai sacramenti, di organizzazione per l’accesso ai riti, dimenticando la «dimensione domestica » che la preghiera, la liturgia, la celebrazione hanno sperimentato durante la “fase uno”. Sembrano perdere di valore e di importanza riflessioni come quelle del monaco e teologo Gislain Lafont: «Il sacramento dell’Eucarestia non sembra al primo posto nell’economia della fede. Ciò di cui si tratta per l’umanità è rendere a Dio un sacrificio spirituale che consiste interamente nella pratica della carità: verso Dio, verso se stesso, verso il prossimo», nonché dello scrittore Emmanuel Carrère, espresse dopo aver fatto visita a una comunità dell’Arca: «Penso che le cose sarebbero potute andare diversamente: che il sacramento centrale del cristianesimo avrebbe potuto essere la lavanda dei piedi anziché l’Eucarestia».
Semeraro si spinge a offrire queste riflessioni che a molti parrebbero inaccettabili, per quella radicalità di pensiero che porta il monaco a non fermarsi di fronte alle provocazioni dei “segni dei tempi”, ma ad accoglierle non come scomode e inopportune disgrazie ma come occasioni preziose per rinnovare il modo in cui «essere discepoli del Vangelo» e «lo stesso rapporto con l’Eucarestia» che potrebbe ridefinirsi «nella linea di una sacramentalità più esistenziale e non semplicemente rituale». Scrive MichaelDavide: «Non ci resta che vivere e soffrire sia la privazione dei molti, che il ministero dei pochi, i quali devono ancora più vigilare sul rischio di trasformarlo in un privilegio».
È questo tempo di lutti, di sofferenza, di solitudine nel vivere e nel morire a interpellarci e a esigere «un sussulto di dignità: siamo tutti malati di umanità!», come esclama il monaco Semeraro, ricucendo ciò che è strettamente umano con ciò che lo supera attraverso «il cuore del cuore della rivelazione» cristiana che è la compassione. Eucarestia e lavanda dei piedi, celebrazione e servizio non sono contrapposti ma i due volti della stessa Chiesa. E la domanda «Siamo sicuri che basta pregare?», che proviene da un monaco e che si rivolge a quanti e quante hanno scelto la vita contemplativa, ottiene certamente risposta affermativa: «Sì, basta pregare», ma non può «confondersi con la semplice ritualità». Qual è allora il reale significato del monachesimo?, si domanda l’autore riprendendo l’interrogativo di Thomas Merton. Domanda che oggi forse, dopo la clausura collettiva del coronavirus, può avere sfiorato le menti di molti. La preghiera incessante, l’intercessione per chi soffre e per le sofferenze del mondo intero, la continuità della preghiera liturgica sono sufficienti a “riempire” la vocazione dei monaci e delle monache a vivere «un ideale monastico integrale»? Se la vita stessa dei monaci e delle monache è tutta tesa a farsi preghiera, tempio, liturgia, quale postura e quali scelte sono richieste loro in un tempo come la pandemia? «Anche come monaci e monache dovremo misurarci con la fine di un mondo e la sfida di dare il nostro contributo a riprendere il cammino in modo più saggio, più sano e più santo. […] La speranza è che l’intensificazione della preghiera e della separazione dal mondo […] possano rendere la nostra vita monastica evangelicamente adeguata e umanamente affidabile ». E infine aggiunge, con umile umanesimo, una dichiarazione di debolezza che suona preghiera: «Sono il primo ad avere tanta paura di non riuscire a capire e, soprattutto, di non farcela a essere realmente disponibile all’appello della storia attraverso cui Dio continua a parlare e chiede di essere ascoltato».
Redazione Oreundici
MicaelDavide Semeraro, A bassa voce: Riflessioni monastiche in tempo di pandemia, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (MI) 2020, pp. 58
Questa recensione è stata pubblicata dalla rivista “Oreundici” (n. 6/2020, pp. 6-9), che aderisce alla Rete dei Viandanti.