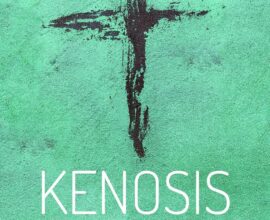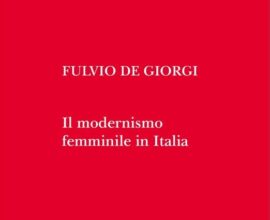CERCARE DIO ATTRAVERSO IL DESIDERIO
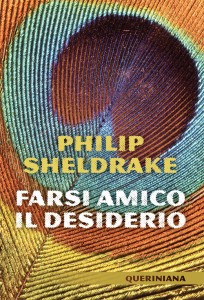
Nel libro, giunto alla terza edizione, Philip Sheldrake cerca di definire i lineamenti di una spiritualità del desiderio, nella consapevolezza che questa dimensione, intimamente legata all’eros e alla sua qualità di dedizione mirata e passionale, è stata per lo più considerata con sospetto nella tradizione cristiana, che le ha sempre contrapposto agape, inteso come forma di amore più elevato e disinteressato, a somiglianza dell’amore divino. Ma la separazione radicale di agape da eros conduce, rileva l’autore, verso una forma di cosiddetto amore impersonale e in fondo ben protetta, giacché non ci coinvolge veramente. In fondo, nessuno di noi vorrebbe essere oggetto dell’amore universale di qualcuno. Appartiene infatti alla natura dell’amore il suo avere come oggetto l’unicità, l’ipseità dell’altro.
“L’insegnamento della chiesa cristiana ha mirato a porre una forte enfasi sulle fonti esterne dell’autorità in contrasto con i nostri desideri personali. Il desiderio sembrava incoraggiare il giudizio privato e incontrollabile. Seguire i desideri appariva come una mancanza di obbedienza alle norme della chiesa a vantaggio della propria volontà. Il dovere, la fedeltà alle aspettative degli altri o l’abnegazione nel senso quasi letterale di negare la propria personalità e i propri gusti divennero troppo facilmente i criteri per il progresso spirituale.”
Aver diviso agape da eros e dalla forza del desiderio che a eros è connessa ha condotto a mistificazioni e distorsioni nell’ambito della vita spirituale, dal momento che nei desideri si identificano le “esperienze più sincere di noi stessi, in tutta la nostra complessità e profondità, quando ci mettiamo in relazione con le persone e le cose intorno a noi”. Sostituire l’ideale alla realtà incarnata del desiderio e rimpiazzare quest’ultimo con la fredda ragione è inumano e inaccessibile. Il sospetto secolare nei confronti del desiderio si spiega d’altronde con la sua potenza, che contiene sempre un certo margine di rischio. Ma l’evitamento del rischio comporta la rinuncia a prendere in considerazione nella vita spirituale “il lato rischioso, ribelle ed esuberante di Dio che ci invita a una libertà analogamente rischiosa e alla disponibilità a immergerci in situazioni, impegni e relazioni.” In altre parole, è la rinuncia a una sana e profonda teologia dello Spirito Santo che soffia dove vuole e che è tanto vulnerabile quanto potente. L’attenzione al desiderio riguarda il coltivare in noi stessi quella capacità di partecipazione appassionata e rischiosa che ci rende peraltro vulnerabili come vulnerabile e vulnerato è stato Gesù.
Non è un caso che il fil rouge del desiderio attraversi nei secoli l’esperienza dei grandi mistici, che hanno riconosciuto e declinato in diverse varianti la forza positiva e straordinaria del desiderio, con il suo carattere anche sensuale e sessuale, contrapposto a una vita spirituale intesa principalmente come asettica/ascetica rinuncia alle cose e astensione dalle passioni. Da alcuni padri della Chiesa, passando per Hadewijch di Anversa, Bonaventura, Eckarth, Caterina da Siena, Giuliana di Norwich, Teresa d’Avila, Giovanni della Croce, Ignazio di Lojola, fino a Edith Stein e a Etty Hillesum, il tema del desiderio è stato al centro dell’esperienza mistica e spirituale.
Naturalmente il fondamento di una spiritualità che recuperi il tema del desiderio come suo cuore vivificante non può che essere la Scrittura, dove l’amore di Dio e per Dio è descritto spesso con le figure e le metafore dello struggimento appassionato.
Il seguito del libro è incentrato sul discernimento spirituale dei desideri, che in ognuno di noi sono molteplici e spesso conflittuali e la cui intensità spesso non coincide con la loro profondità.
La ricerca spirituale dev’essere dunque mirata a individuare quei desideri autentici che provengono dal nostro io essenziale piuttosto che dalla superficie delle nostre personalità o dalle nostre reazioni immediate a situazioni e esperienze. A questo livello le domande “Chi sono io?” e “Cosa voglio?” si equivalgono profondamente. L’autore ricorda che nei suoi Esercizi Ignazio di Lojola invitava, prima di ogni momento di preghiera, a chiedere a Dio nostro Signore quello che voglio e desidero. Ma questo è solo il punto di partenza nello svelamento graduale di ciò che ci coinvolge più appassionatamente e profondamente. “Il significato di tutto questo è che più sinceramente cerchiamo di identificare i nostri desideri autentici, più possiamo identificare chi siamo veramente. “Possiamo pensare ai nostri desideri autentici come a una sorta di orientamento vocazionale. Essi ci guidano verso ciò che siamo chiamati a diventare, a vivere e a fare. Se i nostri desideri rivelano chi siamo, allora l’importanza di occuparsene sta in parte nel fatto che ci aiuta a riconoscere il nostro vero io dietro le maschere che indossiamo. Allo stesso tempo ci aiuta a diventare ciò che Dio desidera che siamo, espresso nel processo della nostra stessa creazione.”
“Più sinceri sono i nostri desideri, più influiscono sulla nostra identità e anche sulla realtà di Dio al centro di noi stessi. (…) Di conseguenza i nostri desideri più profondi, in una certa misura, ci spingono oltre il nostro egocentrismo fino al dono di se stessi. In altre parole, questi desideri non riguardano solo noi stessi ma la crescita del regno di Dio. Riflettono i desideri stessi di Dio, la brama di Dio per il mondo e per ciascuno di noi in particolare. In questo senso i desideri autentici hanno una dimensione sociale o collettiva.”
Nel desiderio si mostra dunque una sorta di paradosso. I desideri profondi rivelano qualcosa di essenzialmente personale. Tuttavia, al contempo, più profondamente entriamo in noi stessi, più è certo che questi desideri trascendano qualsiasi tentazione di individualismo. Più profondamente entriamo in noi stessi, più sperimentiamo desideri che sono sia specificamente nostri, sia specificamente dati da Dio.
La spiritualità del desiderio richiede dunque la capacità e la pratica dell’autoascolto profondo. Occorre vivere e abitare il desiderio, viaggiando verso le sue profondità per trovare, nella sua più profonda radice, la chiamata che Dio rivolge a ciascuno.
Simonetta Giovannini