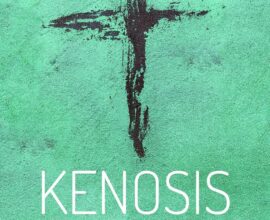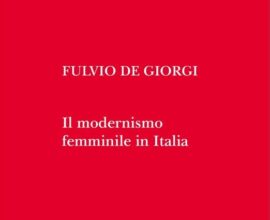DIACONE:DALLA DIACONIA DI FATTO AL DIACONATO FEMMINILE
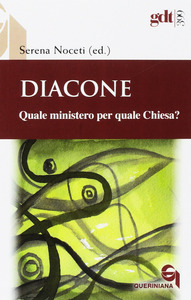
Il volume curato da Serena Noceti, che raccoglie i variegati interventi di teologhe e teologi sul tema, si propone di contribuire al dibattito apertosi dopo la decisione di papa Francesco, nel 2016, di costituire una Commissione di studio sul diaconato femminile.
Il libro colloca la domanda sulla possibilità di accesso delle donne al ministero ordinato nel più vasto orizzonte della questione del rapporto tra modelli ecclesiali, modelli ecclesiologici, teologia del ministero ordinato, pluralità di figure ministeriali, secondo la prospettiva interpretativa del Vaticano II.
Pur nella varietà degli approcci al tema, gli interventi rimarcano la necessità che il ricorso alla storia voluto da papa Francesco (che ha incaricato l’apposita commissione pontificia di indagare sul ministero delle donne diacono nella Chiesa apostolica) sia equilibrato dalla preoccupazione pastorale, dove il criterio non sia semplicemente un ripetere il passato o ristabilirne le norme, ma quello funzionale del servizio al popolo di Dio.
Ecclesiologia e teologia del ministero ordinato sono intese qui come “due variabili correlate” (C. Militello).
La prospettiva è quella, conciliare, della Chiesa intesa come popolo di Dio, ovvero, per riproporre le parole di Yves Congar citate in un contributo, considerata come la comunità strutturata istituita da Gesù, una comunità “interamente santa, sacerdotale, profetica, missionaria, apostolica, con, al suo interno, dei ministeri: alcuni liberamente suscitati dallo Spirito, altri collegati mediante l’imposizione delle mani all’istituzione e alla missione dei Dodici.” S’impone dunque la necessità di una riflessione sul ministero diaconale e sulla possibilità di un rinnovato accesso delle donne ad esso che parta dalla Chiesa, non in maniera astratta e a-temporale, ma in maniera concreta e contestuale. E non in una prospettiva Cristo-monistica ma valorizzando anche l’opera dello Spirito Santo che distribuisce i suoi doni nella Chiesa. Come ci ricorda Gilles Routhier, quanto ci indica il Nuovo Testamento è che la chiesa si è avvalsa di una certa libertà nella definizione della figura dei ministeri. Libertà non assoluta ma delimitata da almeno due segnalatori, due criteri: il discernimento dell’opera dello Spirito e dei doni da Lui provenienti da un lato, e dall’altro l’attenzione ai bisogni del popolo di Dio nelle circostanze attuali. Il ricordo del passato è quindi insufficiente per delineare la figura di un ministero diaconale che potremmo riconoscere a donne cristiane oggi. Alla considerazione delle circostanze temporali e delle esigenze che pongono va accostata l’attenzione alle circostanze di luogo e la dipendenza “dai processi di inculturazione della fede nei diversi continenti e soprattutto dalle modalità di interpretare la soggettualità delle donne nelle differenti aree culturali.” (S. Noceti)
“Un mutato ruolo delle donne nelle società occidentali, il riconoscimento della loro piena soggettualità ecclesiale nella visione del Vaticano II, una prassi ecclesiale post-conciliare che vede le donne coinvolte in rapporto al Noi della comunità”, disegna nuovi scenari pastorali che permettono e sollecitano la domanda sull’ordinazione diaconale delle donne. Ci sarebbe dunque per le donne “la possibilità di esprimere il Noi ecclesiale, nel promuovere l’autenticità delle relazioni d’amore e la diaconia del corpo ecclesiale in forma pubblica, come medium ministeriale di edificazione della chiesa.”
Come ricorda infatti Cettina Militello nel suo contributo, non è certo la supplenza liturgico-pastorale dovuta alla crescente carenza di presbiteri la specificità del diacono, “deputato invece a significare la carità della chiesa locale nella direzione duplice dell’intercomunione (…) e del farsi carico di bisogni.” Funzioni spesso già diffusamente esercitate dalle donne nelle chiese di diverse aree del mondo.
Il volume indaga il percorso conciliare che ha inaspettatamente condotto al ripristino del diaconato come grado autonomo e permanente del ministero ordinato; esamina i fattori che hanno storicamente condotto, dopo i primi secoli di vita della chiesa, all’esclusione delle donne dal ministero ordinato. Argomento fondante l’esclusione è, ci ricorda Andrea Grillo, la distinzione operata da san Tommaso tra ius divinum e ius ecclesiasticum. Ma se si guarda alla sua argomentazione, si nota che egli intende come ex necessitate sacramenti un’argomentazione non cristologica, ecclesiologica o pneumatologica, ma solo la semplicistica assunzione teorica di quello che oggi riconosciamo come il pregiudizio sociale della strutturale inferiorità della donna rispetto all’uomo.
Interventi successivi indagano la fisionomia della diaconia nel Nuovo Testamento da Gesù alle chiese di Efeso (Marinella Perroni, Pius Ramon Tragan), la questione ermeneutica della lettura della tradizione (Simonelli) e delle fonti storiche (Scimmi), le attestazioni patristiche (Laiti), il confronto ecumenico sul tema (Berlis).
L’imperativo condiviso sembra quello di restituire il ministero alla sua significazione immediata, la diakonia, il servizio e alla sua origine pneumatica dalla “ricchezza esuberante dello Spirito che i suoi doni elargisce come e dove vuole.” Il richiamo è a una “sinodalità che chiama in causa l’intero popolo di Dio come soggetto autentico e plenario di discernimento “profetico”. L’autorità nel discernimento può permettere oggi alla chiesa di superare quella rigidità che spesso nasce dalla paura e dal pregiudizio, o da un’autoreferenzialità ecclesiale che disconosce i segni dei tempi e il soffio dello Spirito.
Sarebbe paradossale, osserva Andrea Grillo, che “restassimo troppo a lungo legati a una Ordinis tristitia nel campo del ministero ordinato.”
Simonetta Giovannini
____________
Nel volume i contributi sono di: Angela Berlis, Andrea Grillo, Giuseppe Laiti, Cettina Militello, Serena Noceti, Marinella Perroni, Gilles Routhier, Moira Scimmi, Cristina Simonelli, Pius-Ramon Tragan.