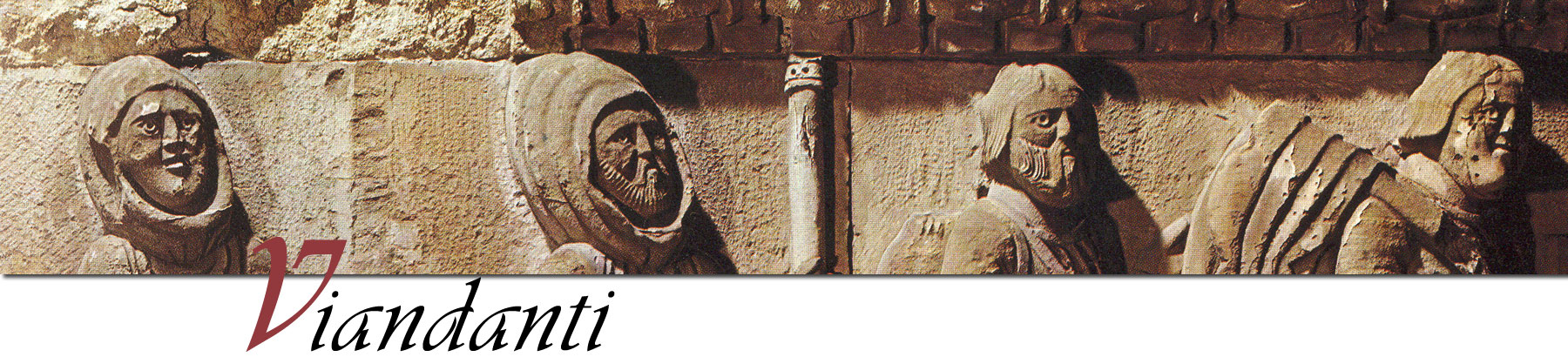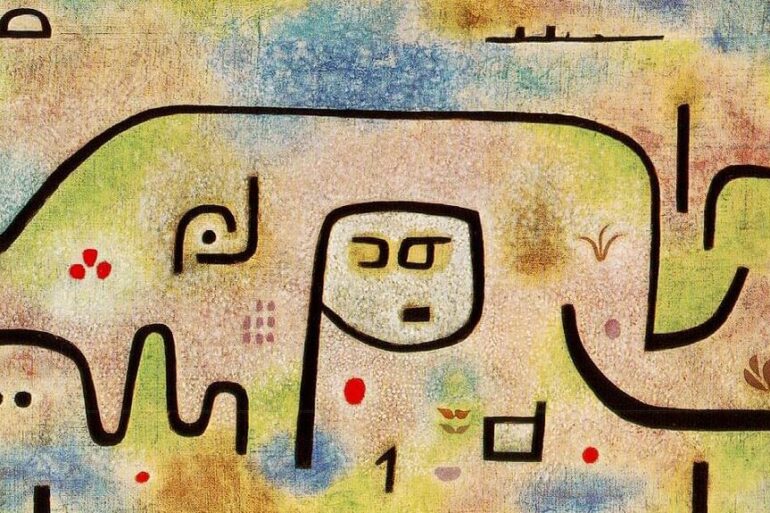ESSERE, DIVENTARE VIANDANTI
VERSO L’ALTERITA’?
Marco Bertè
Nel cammino verso la nostra Assemblea soci, che si terrà il 30 novembre, stiamo pubblicando a puntate le riflessioni, o meglio la lunga meditazione sull’essere viandanti, che Marco Bertè, uno dei soci fondatori, ci ha donato con questa dedica: “Una meditazione dedicata agli amici dell’Associazione Viandanti, con il piacere di ricordare un’idea e un’amicizia”. Una preparazione remota della quale ringraziamo molto Marco. [V]
** ** **
Verso dove cammina il viandante? Verso una qualche alterità che ci chiama e verso cui è misteriosamente attratto? O, senza rendersene conto, verso sé stesso, verso le profondità dell’Io? Ecco il nodo da sciogliere. I due poli, sé e altro da sé, rimangono vincolati l’uno all’altro, implicandosi vicendevolmente. Non è possibile optare per l’uno o per l’altro. Non c’è, non si dà l’uno senza l’altro. Non c’è sé senza altro da sé come non c’è altro da sé senza sé. Si direbbe che al viandante è posto o proposto qualcosa di ulteriore, qualcosa che sta al di là o più in profondità di questo nodo e che si manifesta come un enigma o come un territorio ancora da esplorare.
Il richiamo dell’Alterità
La compresenza e reciprocità di sé e altro da sé diventano consapevoli e generano il formarsi e trasformarsi continui del proprio mondo e di se stessi, anche se tutto rimane ancora piuttosto anonimo. E si impone la necessità di figure meglio caratterizzate. Ecco allora “verso l’alterità?”, non a caso in forma interrogativa. Si affacciano le forme totalizzanti del vivere e del processo educativo e quelle più vibranti, spesso tragiche, dell’itineranza dei migranti stranieri.
Se le prime confermano e a volte acuiscono la compresenza e reciprocità di sé e altro da sé, nelle seconde sembra campeggiare uno dei poli, quello dell’alterità, anche se solo in termini problematici. Ecco la ragione della forma interrogativa. La quale sembra poi sciogliersi e far luogo non al dominio dell’uno o dell’altro polo, ma alla presenza alternativa dell’uno o dell’altro. È ciò che avviene con le figure di Ulisse ed Abramo, il primo intento a tornare a sé, il secondo intento a rivolgersi decisamente ad una alterità che lo chiama ed esige obbedienza.
Quando nuovamente Dio chiama Abramo e gli ingiunge di andare al monte Moria a sacrificare il figlio, allora veramente il richiamo dell’alterità sta tutto e solamente dalla parte di Abramo. C’è in lui una Dedizione assoluta.
Le forme del contendere
Tocchiamo con mano lo scontro con Dio, il contendere del credente con il suo Signore. La forma del contendere forse più aspra si ha con Giobbe quando Dio, a motivo, sembrerebbe, d’una incredibile scommessa col Satan, colpisce l’uomo con privazioni e sofferenze inenarrabili, fino a farne una larva vivente, e, ancor peggio, alla fine chiudendosi in un silenzio insopportabile. Ma poi, resistendo Giobbe ad ogni ingiuria, gli restituisce tutto, e lo accoglie nuovamente, trasformato e benedetto, nel proprio seno.
E c’è, forse, un contendere di Gesù con il Padre, un contendere meno oppositivo ma più drammatico, nell’orto del Getsemani e nella passione. La posta in gioco e l’esito finale è la salvezza dell’uomo, raggiunta assumendone la condizione, fino alla croce. “Proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Eb 2,17-18).
Vi è un contendere che assume, da parte del Figlio, la forma dell’umiliazione e dell’obbedienza estrema. “Pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome” (Fil 2,5-9).
Pericolo e minaccia, risorsa e dono
Ma che cosa è il contendere? Che cosa può significare la contesa fra uomini e dei, fra l’uomo e Dio, fra Adamo e Cristo? E, ancor prima, quando c’è contesa fra uomo e uomo?
Deve essere chiaro, anzitutto, che c’è contesa solo quando i contendenti sono l’uno contro l’altro, anzi, l’uno di fronte all’altro. È difficile parlare di una vera e propria contesa quando i contendenti si ignorano, si oppongono senza confrontarsi. C’è contesa fra uomo e uomo se e quando sono, l’uno per l’altro, pericolo e risorsa, minaccia e dono, ove è importante che ci sia una “e” e non una “o”, che ci siano, cioè, entrambi i poli e non solamente uno dei due.
Non è facile rappresentarsi e ancor più vivere questa situazione, di essere, ad un tempo, l’uno per l’altro, pericolo e risorsa, minaccia e dono. Ed ancor più difficile quando ad uno dei due poli sta non un uomo ma Dio stesso. Eppure proprio questo è il caso della “legatura” di Isacco, della lotta di Giacobbe, del soffrire di Giobbe ed anche, benché con diversa accentuazione, dell’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani.
Dio è senza dubbio pericolo e minaccia per Abramo, per Giacobbe, per Giobbe, in quanto in guise diverse ne mette a repentaglio la vita stessa. Ma è altresì vero che alla fine Dio è anche, per Abramo, per Giacobbe, per Giobbe, risorsa e dono che li salva, benedice e ricopre di beni. E lo sono perché la loro resistenza, il loro coraggio di sfidare Dio stesso, di lottare con Lui, consentono a questi di esercitare la sua misericordia.
Un altro approccio sembra imporsi a proposito di Gesù nell’orto del Getsemani. In questo caso le cose sono diverse, se non altro perché ci troviamo di fronte ad un contrasto in cui i lati sembrano ambedue occupati da Dio stesso.
Ma è proprio così? Non è possibile contemplare nel Gesù sofferente di Nazareth la presenza del Padre? Non è possibile pensare ad un Dio sofferente? Se assumiamo questo punto di vista, non è forse inevitabile vedere l’umanità di Gesù e la divinità del Padre essere l’una per l’altra pericolo e minaccia, risorsa e dono?
Pericolo e minaccia del Padre per il Figlio perchè, non escludendo l’opposizione degli uomini, non può escludere la morte in croce? Ma anche risorsa e dono in quanto la salvezza degli uomini è tutta nella resurrezione del Figlio? E pericolo e minaccia del Figlio per il Padre perchè, umiliandosi ed accettando l’obbedienza più difficile, trascina il Padre nello scandalo della croce, ma anche risorsa e dono in quanto, offrendo con la croce la salvezza dell’uomo e degli uomini, fa risplendere la misericordia del Padre.
L’esigenza di riconoscersi
Ma è naturale chiedersi: come è possibile rendere compatibili il pericolo e la risorsa, la minaccia e il dono? Non stiamo giocando con le parole? Forse un loro accordo è possibile se si valuta con attenzione il tipo di contesa che si genera con la “legatura” di Isacco, la lotta di Giacobbe, la tragedia di Giobbe. In esse, come si è già notato, non è in gioco il sopravvento dell’uno o dell’altro dei due contendenti, ma il reciproco riconoscimento.
In generale, quando due contendenti si confrontano ponendosi in gioco, ognuno considera l’altro in relazione a sé e sé in relazione all’altro. E lo fa, almeno inizialmente, come un tentativo. Tenta, cioè, di provocare l’altro e in tal modo riesce ad accertare le caratteristiche e le capacità di reazione dell’altro e di sé.
Nasce così un dialogo che assume i contorni, ad un tempo, della reciprocità e del contrasto, della amicizia e della lotta. L’uno si misura con l’altro per essere riconosciuto e per riconoscerlo: i due rimangono in tensione, conservando entrambi la propria identità, impegnati ognuno ad essere e diventare se stesso attraverso l’altro e grazie all’altro. Probabilmente è in essa, in questa tensione, in questo reciproco misurarsi, in questo tenere, ad un tempo, a sé e all’altro da sé, che sta il baricentro dell’essere e del fare del viandante. E’ in essa che sta il modo di contendere che gli è peculiare.
Dalla reciprocità al dialogo
Questa oscillazione fra il sé e l’altro da sé possiamo notarla a cominciare dalla cosiddetta filosofia del dialogo – sia ebraica [1] , o cristiana [2] o di ascendenza fenomenologica ed ermeneutica [3] – che ha giustamente insistito su questa relazione.
Per Buber, ad esempio, come sostiene soprattutto nel suo piccolo grande capolavoro, Io e Tu, la relazione Io-Tu, quella relazione di cui si intesse il dialogo e per cui “divento Io nel Tu”, è fondamentale. L’Io non sorge, non si costituisce in rapporto a se stesso, riflessivamente, come interiorità. Ma in rapporto all’altro da sé, in rapporto all’evidenza dell’altro.
Buber, a differenza di Lévinas, concepisce la relazione come reciprocità. La relazione Io-Tu è porsi di fronte all’altro con la totalità del proprio essere, stare nella pura presenza, esclusività, dare e ricevere il tu, legame reciproco ed operare reciproco, reciprocità. La relazione è reciprocità. Questa qualificazione è irrinunciabile per Buber. Senza reciprocità non c’è relazione. «Non si cerchi di svigorire il significato della relazione: relazione è reciprocità». «I nostri allievi ci formano, le nostre opere ci costruiscono».
Non è così per Levinas, che pure manifesta una profonda convergenza col pensiero di Buber. Su questo punto egli prende decisamente le distanze da Buber. «L’Io-Tu comporta di colpo, […] senza ricorso ad alcuna legge universale, un’obbligazione. Essa è inseparabile, secondo il suo senso proprio, sia dalla valorizzazione dell’altro come altro nel Tu, sia da una costrizione al servizio nell’Io, valore del Tu, diaconia dell’Io – profondità semantiche della “parola fondamentale”, profondità etiche. Nella Relazione – contrariamente alla “reciprocità” sulla quale, senza dubbio a torto, insiste Buber – ci sarebbe una disparità, una dissimmetria. Senza possibilità di scampo, come se fosse stato eletto per questo, come se fosse così insostituibile e unico, l’Io come Io è servitore del Tu nel Dialogo» (Il dialogo. Coscienza di sé e prossimità del prossimo). Costrizione al servizio, valore del Tu, diaconia dell’Io.
Un dialogo a tre
Sennonché, se pensiamo ad Abramo, alla sua dedizione assoluta a Dio, fino ad abbandonare Isacco, la moglie, i servi, è inevitabile chiedersi: come è possibile che la dedizione all’altro – sia pure l’assolutamente Altro – comporti l’abbandono di altri? “Non posso rispondere – scrive Derrida in Donare la morte – alla chiamata, alla richiesta, all’obbligo, e neppure all’amore di un altro senza sacrificargli l’altro altro, gli altri altri […] Tutto accade come se non si potesse essere responsabili allo stesso tempo davanti all’altro e davanti agli altri, davanti agli altri dell’altro”.
Detto diversamente, secondo la formula di Levinas: Se l’Io è servitore del Tu, totalmente esposto all’altro, suo ostaggio, che ne è degli altri? Se l’orizzonte dell’Io è interamente occupato dall’altro, dove stanno gli altri? È il problema del terzo, terzo rispetto all’Io e al Tu.
A questo punto ci troviamo non più con due termini – Io e Tu, sé e altro da sé – ma con tre: Io, Tu e l’altro. Buber ne considera due, l’Io e il Tu, tra cui si realizza una perfetta reciprocità. Ma secondo Levinas non può esservi reciprocità nel dialogo: campeggia il Tu e l’Io è interamente a suo servizio. Ma sopraggiunge Derrida ed avverte: attenzione!, ambedue queste forme del dialogo comportano sempre e comunque l’abbandono del terzo. Si impone, allora, un dialogo a tre, un dialogo che non può e non deve escludere nessuno. La dedizione all’altro non può mai comportare l’abbandono di altri. Sorge così il tema della giustizia, della comunità, della politica nel suo più ampio senso. Come dire: la diaconia verso il Tu è necessariamente diaconia verso altri. Una congiunzione difficile ma irrinunciabile di due imperativi che possono confliggere.
Come può risultare, ad esempio, nella cosiddetta “legatura” di Isacco. È proprio in questo episodio che si può cogliere il tentativo di rispettare ambedue i corollari. Da una parte la dedizione di Abramo al Tu divino è spinta fino al punto di accettare la prova e di accingersi a sacrificare il figlio.
È la sua grande fede, il credere che alla fine Dio non può che mantenere le promesse, che gli fa accettare questa prova. Da un’altra parte non può abbandonare il figlio (il terzo! Ci sono l’Io, Abramo; il Tu, Dio; e c’è il terzo, Isacco) perciò si ribella, lo sfida a procurarsi l’agnello per il sacrificio. Ed è ancora la fede, la sua grande fede che lo spinge a sfidare il suo Signore.
Una fede nutrita da tanti dubbi sullo stesso essere divino, una fede che lo porta a contendere con Dio, a misurarsi con la Sapienza e Potenza infinite. Una fede che abbraccia ad un tempo il Dio cui ci si affida e l’Io che si affida e che ricostruisce a livelli sempre più alti – almeno quanto alla percezione che ne possiamo avere – la implicazione originaria di Sé e altro da Sé. Ove è chiaro che l’altro da sé non è né può essere solo un tu, per assoluto che sia (amico, amante, Dio stesso), ma il mondo intero, il mondo dei viventi, anzi, di tutti gli esseri.
Con questa consapevolezza il viandante ancora una volta riprende il cammino. E si accinge a diventare – ora finalmente, ora sul serio – un viandante autentico, perennemente in cammino verso mondi inesplorati.
Marco Bertè
Socio fondatore di Viandanti e membro del gruppo “Oggi la Chiesa” (Parma) che aderisce alla Rete dei Viandanti.
[Parte quinta]
[1] Da Rosenzweig a Buber, ad Ebner, a Levinas e Derrida.
[2] Da Marcel a Guardini, a Pareyson.
[3] Da Husserl ed Heidegger a Ricoeur e Gadamer.
Essere, diventare viandanti
Parte prima: Camminare verso dove?
Parte seconda: Ulisse e Abramo
Parte terza: Il contendere dell’uomo con Dio
Parte quarta: L’itineranza e la lotta di Gesù
– – Nota – – – –
Questo editoriale è tratto da un testo più ampio intitolato, Essere, diventare viandanti. Verso dove? La versione integrale, in cartaceo, verrà consegnata ai partecipanti della prossima Assemblea dei soci di “Viandanti” (Parma, 30 novembre 2024).
[Pubblicato il 14.11.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: www.paulklee.net]