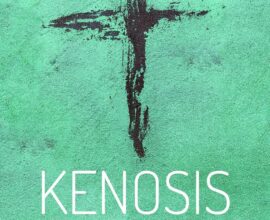GESÙ DI NAZARET. ANCORA DOMANDE SULL’IDENTITÀ
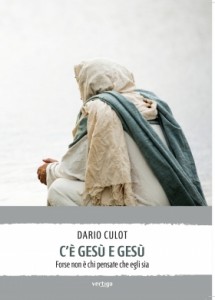
L’autore del saggio tende far risuonare di nuovo, nella cultura occidentale contemporanea, la domanda sull’identità di Gesù di Nazaret; lo fa rimanendo un uomo credente e servendosi di numerosi testi, articoli, studi, conferenze, tutti pubblicati tra il 1965 e il 2017, a cui le corpose note rimandano con puntualità e ampiezza.
Egli, lungo tutto il testo, non dimentica di notare come il gap tra i dogmi e le dottrine, sedimentatesi nel tempo in campo cristiano, e la forma di pensiero e razionalità, che si è strutturata a partire dalla modernità, non possa più essere ignorato e vada piuttosto attraversato da parte credente, nel tentativo di trascrivere sul secondo versante ciò che non può (più) vivere di sola autorità, che richieda obbedienza cieca.
A ben vedere un tale sforzo di revisione e messa in discussione di sé è compiuto nel testo solo sul versante del credente, chiamato ad abbandonare la staticità della sicurezza, mentre non è esplicitata la consapevolezza di una, altrettanto necessaria, problematizzazione e rigorizzazione di una forma di ragione che si nutra di dubbio puro, più che metodico.
Come esprime bene il titolo, l’obiettivo perseguito in ogni capitolo è decostruire la figura di Gesù Cristo così come è stata veicolata dalla tradizione religiosa giunta fino a noi, che ne ha tenuto sotto sequestro l’umanità, la concretezza della vita, l’insuperabile fattualità storica per esaltarne una cristallina divinità, separata da ogni contaminazione terrestre, e che, in tal modo, sarebbe stata costretta a costruire un impianto teologico formale per rendere coerente il postulato della divinità di questo uomo con le esigenze del monoteismo ebraico e della riflessione metafisica nel tempo in cui diventa onnicomprensiva.
L’intento decostruttivo, sebbene del tutto orientato a restituire libertà di pensiero e di adesione credente nonché rilevanza a ciò che è storico e contingente sia nella vicenda di Gesù che nelle vie di salvezza dischiuse per gli umani e da loro percorribili nel tempo, informa di sé tutta l’opera, così che risulta depotenziato l’elemento costruttivo di indagine sull’identità positiva dell’uomo Gesù, che il ritorno alle origini, attraverso lettura e interpretazione delle fonti, avrebbe potuto propiziare.
Come annunciato nell’introduzione, i nove passaggi ampi e strutturati in cui il testo è articolato tengono una linea di negazione. A proposito dell’osservazione per cui nelle fonti evangeliche «Gesù non è mai chiamato Dio», né ha detto di sé di esserlo, si struttura l’esposizione sulla realtà della sua esistenza storica, che tiene quando le si applichino i medesimi criteri della ricerca storiografica, mentre alla verifica empirica sfugge la risurrezione di Gesù che, in ogni caso, è avvenuta oltre l’arco temporale della sua vita terrena, ossia dopo la sua morte fisica; per l’autore ciò non implica che si debba negare l’esperienza del Gesù risorto da parte dei suoi discepoli, vissuta da loro come il ristabilimento personale e intimo di un contatto che la morte aveva spezzato e fattivamente testimoniata con la loro vita (capitolo 1).
L’ultimo capitolo torna su questo nodo ottenendo l’effetto di consegna della riflessione al lettore e lasciandolo, tuttavia, con una strumentazione ancora grezza nelle mani, tesa tra non corrispondenza della risurrezione con l’esperienza empirica umana, non ultimatività della morte in croce per Gesù, possibile passaggio a una dimensione altra di vita, critica a un linguaggio troppo positivista e contestuale mancanza di un registro eloquente che sappia proporre alla forma mentis contemporanea tutto e solo ciò che corrisponde al momento fondativo racchiuso nell’esperienza fatta con e di Gesù.
Se il filone appena illustrato, tutto impegnato nel recupero dell’umanità di Gesù a discapito del suo riconoscimento divino, muove anche i capitoli 2 e 8, che tematizzano rispettivamente l’autoconsapevolezza di Gesù e i suoi miracoli, un secondo tratto che percorre lo scritto è senza dubbio costituito dalla necessità dell’autore di smontare ogni cristallizzazione identitaria o, meglio, definitoria della cifra cristica così come si è fatta strada lungo i secoli a partire dalla recezione e dall’interpretazione a-storica che l’autore, come peraltro altri studiosi, attribuisce a Paolo di Tarso (capitolo 3), passando attraverso le prime formule cristologiche che propiziano una ritrascrizione tutta dall’alto del singolarissimo vissuto gesuano (capitolo 4), che giunge fino al «concetto difficile» della Trinità (capitoli 5 e 6), senza ignorare la saldatura della dimensione spirituale con quella temporale iniziata nel IV secolo, con la regolarizzazione del cristianesimo all’interno della compagine dell’Impero.
Un terzo movimento si intreccia con i precedenti dentro le pagine: nell’introduzione è enunciato, in modo accattivante, come assenza di ogni intenzione censoria interna alla vita di Gesù, che abbia fatto prevalere una posizione condannando l’altra. Lungo il testo diventa elemento critico fatto valere ogni volta che la scelta di una posizione, in occasione di qualche passaggio relativo alla storia della Chiesa, ha annullato il secondo elemento o le altre pluralità in gioco.
Il capitolo 7 ne diventa una concretizzazione applicata alla celebrazione eucaristica, che si presenta, nella contemporaneità e a motivo delle separazioni storiche, come sacramento di divisione che esclude altri cristiani, ma esclude anche i peccatori, i dubbiosi, chi non è considerato in linea con la dottrina.
Il tema della riduzione a uno, che riassorbe tutte le possibili differenze, a volte accentuando dimensioni non presenti nell’ermeneutica di una prima recezione – è l’esempio, ampiamente percorso, dei nuclei teologici dell’espiazione/sacrificio, della redenzione/riscatto, della necessaria soddisfazione divina, della via sacerdotale… – presenta un secondo risvolto che va diritto a colpire la forma istituzionale, ecclesiastica in specie, nella sua pretesa di decidere e distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, la verità e l’errore, quando non l’eresia. Su tale nodo di credibilità istituzionale l’autore torna in numerosi passi e parlando dei più diversi passaggi storici, addirittura annotando con acribia ogni volta che, al tempo di Gesù, la sua figura e i suoi atti sono stati travisati da una recezione e interpretazione errate, poiché riconducibili alle maglie predeterminate di un costrutto di matrice religiosa ritenuto insuperabile o perché fatte discendere, senza alcuna mediazione, dalla dimensione divina.
Da ultimo, preme mettere in evidenza come intenzione dominante del saggio sia agganciare di nuovo la vita dei credenti cristiani ai nuclei di fede sostenuti (e, verrebbe da dire, viceversa), così che a una dottrina perfettamente enunciata e proclamata secondo criteri di magisteriale ortodossia non corrisponda un vissuto difforme, lontano dalla fraternità richiesta dal Vangelo, quando non uno svuotamento, per riduzione a formula, di una realtà divina che è sempre al di là delle parole che la percezione umana riesce a trovare per dire ciò che la trascende, senza la necessità di chiudersi in un silenzio apofatico e senza la puntigliosità di una concettualizzazione che non sia in grado di lasciare alcunché al mistero, all’eccedente, al non dicibile.
Paola Biavardi
Dario Culot, C’è Gesù e Gesù. Forse non è chi pensate che egli sia, Vertigo, Roma 2017, pp. 572.