“IL POPOLO È LA CHIESA”:
LA COMUNITÀ COME SOGGETTO PASTORALE
Cesare Baldi
La nozione di “popolo di Dio” per esprimere la realtà ecclesiale si è imposta nella chiesa cattolica durante l’ultimo concilio ecumenico e papa Francesco la riafferma con insistenza, ma non ci sembra ancora sufficientemente approfondita a livello teologico, scarsamente assimilata a livello pastorale e sostanzialmente disconosciuta a livello giuridico.
Prendere coscienza di una nuova identità
La costituzione dogmatica Lumen gentium la propone come concetto determinante per descrivere la Chiesa stessa; dopo aver presentato nel primo capitolo il mistero della realtà ecclesiale, essa dedica il secondo proprio alla nozione di popolo, come concetto chiave per esprimere il disegno universale di salvezza: «Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo» (LG 9).
È nostra convinzione che una pastorale del popolo di Dio sia possibile e realizzabile, ma domandi un certo numero di cambiamenti nell’attuale prassi ecclesiale, tali da permettere l’effettiva assunzione della cosiddetta “ecclesiologia di comunione”, emersa proprio nell’ultimo concilio e riaffermata a più riprese da papi e sinodi come «idea centrale e fondamentale dei documenti del concilio»[1].
Tale visione teologica si concentra appunto sul passaggio da una Chiesa, identificata come “società perfetta” gerarchicamente ordinata, a una “Chiesa-comunità”, segno e strumento di comunione con Dio e di unità del genere umano (cf. LG 1).
Ora, per compiere tale mutamento di paradigma, occorre che l’intero popolo di Dio prenda coscienza della nuova identità, la faccia propria e la indossi, la abiti.
Perché questo avvenga, crediamo necessarie almeno tre condizioni: la prima è che ci si riconosca come un popolo di fratelli e sorelle, secondo la nota frase evangelica che ci invita a considerarci tali e non chiamare nessuno di noi “padre” (cf. Mt 23, 9); la seconda è che si assuma una coscienza collettiva, fondata sulla struttura comunitaria sinodale del nostro “fare chiesa”, dobbiamo cioè imparare a sentire ciò che siamo, un’aggregazione di identità disperse diventate “popolo” (cf. 1Pt 2, 10); la terza è che si superi la prospettiva consumistica che inquina le relazioni interne del nostro popolo, per fondarle invece su rapporti di solidarietà e libera partecipazione, pienamente coscienti di condividere tutti la stessa eredità (cf. Ef 3, 6).
Tre indicazioni, che emergono facilmente nel sentire comune dei fedeli e persino nelle conversazioni che si ascoltano in sacrestia.
Una frase sintomatica
“Padre, vorrei far celebrare una messa per il giorno tale, quanto le devo?” In questa semplice frase, apparentemente innocua e pronunciata con naturalezza, si cela il motivo dell’attuale declino della Chiesa cattolica e riemergono proprio le tre condizioni appena elencate, ma in forma negativa, cioè come ostacoli alla realizzazione di una pastorale del popolo di Dio.
Il primo si scorge già nel titolo con cui il (o la) fedele si rivolge al sacerdote: “padre”. Si tratta di un’espressione che ascoltiamo spesso in lingue e latitudini disparate e che pronunciamo senza badare all’incongruenza con il testo del vangelo, in cui Gesù dice espressamente: «non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9).
Nonostante si tratti qui di un imperativo, dunque di un comando, è invalso nei secoli l’uso del titolo di “padre”, come deroga all’ingiunzione evangelica, a favore di una deferente forma di rispetto per la figura sacerdotale; resta però sottesa, ed è questo in particolare che ci preoccupa, la visione di una chiesa in cui sono ben distinti i “padri” dai “figli”, i sacerdoti dai fedeli, il clero dal “popolo”, inteso come massa da guidare e governare.
Come può una visione di chiesa che non solo divide i padri dai figli, ma i padri tra loro (distinguendo tre gradi del sacerdozio: diaconato, presbiterato ed episcopato) e pure i figli tra loro (separando i “più consacrati”, cioè i religiosi, dai laici), corrispondere ancora pienamente all’enunciato di Gesù: «voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)? Dalla fraternità evangelica si è passati alla strutturazione gerarchica attraverso un processo preciso che tenteremo di identificare e che impedisce di riconoscersi parte di uno stesso popolo.
Dettaglio “irrilevante”?
Il secondo segnale contenuto nella frase emblematica citata sopra, sta nel verbo “far celebrare”. Invece di considerare la celebrazione come un’azione collettiva comunitaria, l’espressione tradisce una visione in cui a celebrare sia il sacerdote, quello a cui ci si rivolge e a cui si è tenuti a pagare il servizio.
Dovrebbe risultare ovvio che una messa non si “fa celebrare” da qualcuno, ma si “celebra” insieme a qualcuno, perché – ci insegna papa Bergoglio – «è la Chiesa, Corpo di Cristo, il soggetto celebrante, non il singolo sacerdote»[2]. Eppure, ovvio non è, anzi nel linguaggio corrente sembra proprio il contrario e si accetta questa confusione dottrinale come un’imprecisione, una sorta di semplice errore espressivo.
La mancanza di una coscienza di popolo si fonda proprio da una parte su questa carenza di chiarezza dottrinale dei fedeli, messa in luce dalle recenti indagini sociologiche sul mondo cattolico [3], e dall’altra su un altrettanto preoccupante carenza formativa di quel clero che dovrebbe illuminare, sostenere e confermare i fedeli, condividendone il destino di popolo. La divisione tra chi officia e chi presenzia, attori e pubblico, sacerdoti e fedeli, costituisce così il secondo carattere nodale che impedisce una pastorale di popolo e lo sviluppo conseguente di una coscienza comune.
Clienti e fornitori
Il terzo segnale problematico, contenuto nella domanda per far celebrare una messa, è quello con cui il (o la) fedele conclude la sua richiesta al sacerdote: “quanto le devo?”. Anche in questo caso, l’espressione può sembrarci normale, perché rimanda ad un’offerta che “normalmente” si abbina a tale richiesta. Se però non ci accontentassimo di tale normalità e analizzassimo più a fondo le radici di tale espressione, scopriremmo almeno due aspetti problematici. Uno di ordine canonico dottrinale, sul rapporto tra il sacramento (la messa) e l’intenzione della persona che lo richiede; l’altro di ordine sociologico pastorale, sul processo di monetizzazione o commercializzazione del sacro.
Tale processo è tanto più insito nella nostra società dei consumi, per cui la Chiesa, nella persona del sacerdote, viene colta come istituzione di servizio, al pari di un ospedale, una palestra o un centro commerciale, a cui si domanda un’attività in cambio di un’erogazione in denaro: quanto le devo?
Ogni volta che pronunciamo questa frase, rivestiamo più o meno consciamente il ruolo di clienti, che si rapportano con un fornitore. In chiesa però tale rapporto non è solo fuorviante, è addirittura scandaloso.
Il ministro ordinato non è il fornitore del sacro come il panettiere ci fornisce il pane. Separato dal resto del popolo, il clero diventa vittima della logica binaria di cliente-fornitore propria dell’attuale mentalità consumistica che lo emargina tra i fornitori di beni effimeri, di cui si può facilmente fare a meno.
Le tre funzioni pastorali
Stratificazione, dispersione e marginalizzazione: ecco i tre elementi oscuri nascosti nella frase apparentemente innocua, evocata sopra. Costituiscono tre gravi ostacoli da superare, se vogliamo mettere in atto una pastorale del popolo di Dio. Essi investono direttamente i pilastri dell’agire ecclesiale, i tre compiti pastorali che papa Ratzinger sottolinea come inseparabili espressioni della natura ecclesiale: l’annuncio della Parola di Dio (martyria), la celebrazione dei sacramenti (leiturgia) e il servizio della carità (diakonia)[4].
Il servizio della carità rimanda alla funzione regale (munus regendi), che è letta solitamente come ufficio di governo, invece di concretizzare l’invito evangelico a raccogliere e custodire il gregge nella carità, dato che manca nel codice di diritto canonico un libro specifico sull’esercizio di questa funzione (come esiste invece per le altre due).
L’ufficio sacerdotale (munus sanctificandi) si esercita nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti, che non sono affatto ad appannaggio esclusivo del clero, eppure separiamo i fedeli dai “celebranti” e la loro partecipazione alla liturgia non è indispensabile (cf. can. 837, § 2).
L’annuncio della Parola di Dio, infine, rimanda alla funzione profetica, che invece di essere vissuta in modo comunitario e sinodale, viene interpretata come funzione di insegnamento (munus docendi), separando l’unico popolo di Dio in due parti distinte, l’una che insegna l’altra che impara, anche se tutti insieme possediamo l’infallibilità “in credendo”.
Insomma, sono ancora molti e poco visibili i dettagli che tradiscono una prospettiva societaria, divisiva e gerarchica, da un’ottica comunitaria, inclusiva ed egualitaria. In effetti è la Parola di Dio che ci obbliga ad uscire dal torpore culturale anestetizzante del supermercato consumistico globale, per richiamarci al nostro destino di popolo, unito dall’amore divino per amore dell’umano.
Cesare Baldi
Presbitero della diocesi di Novara. Direttore dell’Istituto di pastorale dell’Università Cattolica di Lione.
Esce in questi giorni il suo volume: Il popolo è la Chiesa. La comunità soggetto pastorale delle funzioni regale, sacerdotale e profetica (prefazione di Giannino Piana), Paoline, Milano 2024.
– – Note – – – – – –
[1] Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 34 (Enciclica sull’eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa), che rinvia a sua volta al Sinodo dei vescovi del 1985.
[2] Francesco, Desiderium desideravi, 36 (Lettera apostolica sulla formazione liturgica del popolo di Dio).
[3] Si veda a questo proposito l’indagine di F. Garelli, Gente di poca fede: il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio, Il Mulino, Bologna 2020. O in particolare, sul tema della mancanza di chiarezza dottrinale, di O. Roy, La santa ignoranza. Religioni senza cultura, Feltrinelli, Milano 2017.
[4] Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, 25 (Enciclica sull’amore cristiano).
[Pubblicato l’ 1.10.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: arteworld.it]

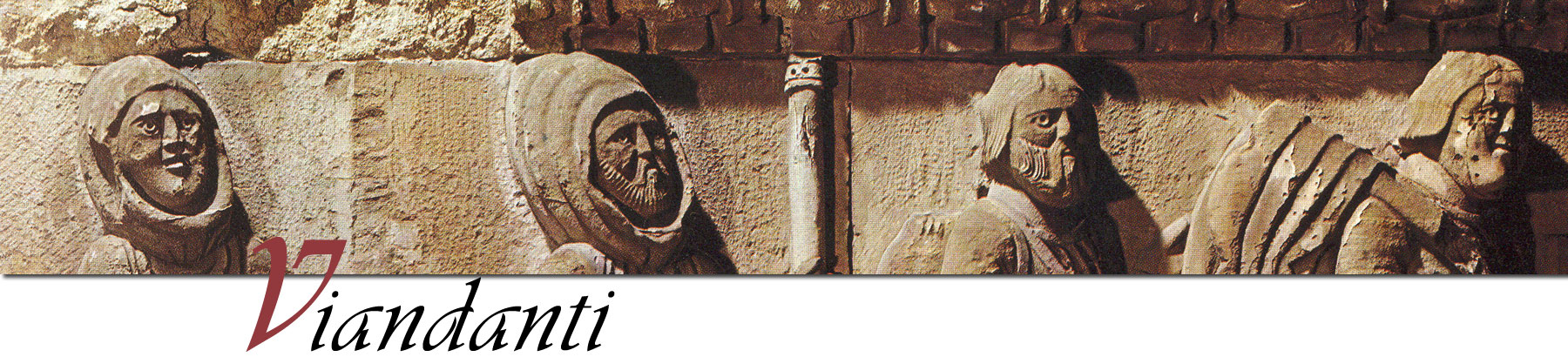




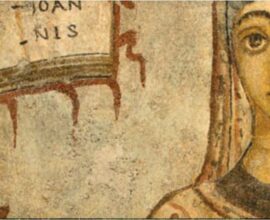

Ma la cosa più scandalosa è che con una messa si possa pensare di modificare qualsiasi decisione di Dio.
Grazie, non mi sento isolato in questo commento! e c’è molto da dire ancora sulla chiesa come popolo, come questo sinodo sta per tradire sia il concilio che “Evangelium Gaudium” di
Francesco che chiarisce bene nel capitolo terzo come siamo soggetti, non sudditi! La chiesa attuale dopo più di 50 anni dal concilio si sente compresa né più né meno che nella concezione del Vaticano I. Si preferisce non scontentare clero e vescovi schiacciando tutto il resto di un popolo piuttosto che abbandonare la concezione della sacralità separata. Non si parla poi di come si concepisce l’intera umanità e l’intero creato: realtà da conquista come se non fossimo tutti avvolti dall’amore del mistero di Dio e che quindi si debba imparare da tutti ascoltando le critiche e le domande che vengono rivolte. Non si sa più come dire queste cose per poter essere ascoltati!