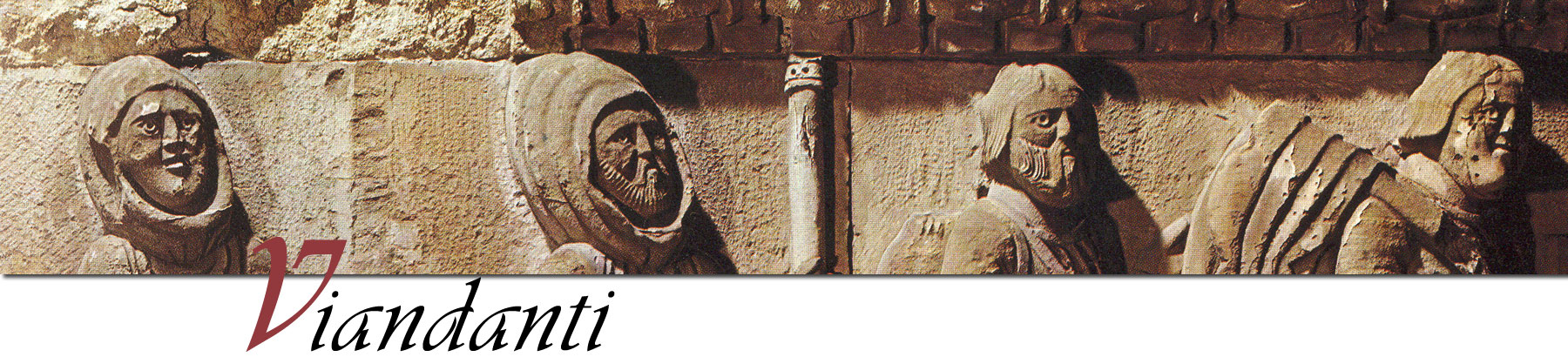IN RICORDO DI CARLO CARLEVARIS PRIMO PRETE OPERAIO
di Andrea Lebra

Lo scorso 2 luglio, a 92 anni, è deceduto Carlo Carlevaris; nella ricorrenza del trigesimo vogliamo ricordare la sua testimonianza di prete operaio attraverso lo scritto di un amico, apparso su www.settimananews.it l’11 luglio. Sempre su settimana news si può trovare un profilo biografico di Lorenzo Prezzi (Carlo Carlevaris: la tuta e la stola).
Ringraziamo la direzione di settimananews per la gentile concessione.
*** *** ***
«Non si può più affermare che la religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste solo per preparare le anime per il cielo. Sappiamo che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su questa terra, benché siano chiamati alla pienezza eterna, perché egli ha creato tutte le cose “perché possiamo goderne” (1Tm 6,17), perché tutti possano goderne. Ne deriva che la conversione cristiana esige di riconsiderare specialmente tutto ciò che concerne l’ordine sociale e il conseguimento del bene comune».
«Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti siamo fratelli. Sebbene il giusto ordine della società e dello Stato sia il compito principale della politica, la Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Tutti i cristiani, anche i pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore».
Sono due citazioni di papa Francesco, contenute nel capitolo quarto dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium dedicato alla «dimensione sociale dell’evangelizzazione».[1]
Mi sono tornate alla mente mercoledì della scorsa settimana, 4 luglio 2018, mentre a Torino, nella chiesa grande della Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, partecipavo ai funerali di Carlo Carlevaris, uno dei primi preti operai italiani deceduto a 92 anni all’alba del 2 luglio.
Esse esprimono molto bene quella che, a mio giudizio, è stata la caratteristica fondamentale della vita del presbitero Carlo Carlevaris.
L’avevo conosciuto alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, nel momento in cui, dopo l’adolescenza, devi decidere sul che fare della tua vita. Aveva da poco maturato la scelta di lavorare come addetto alle pulizie in una fabbrica metalmeccanica del torinese. L’ho frequentato ininterrottamente fino alla morte: per dieci anni, partecipando assiduamente all’eucarestia che presiedeva ogni giovedì sera nella sua mansarda di Via Belfiore 12 a Torino; per altri quarant’anni sporadicamente, ma sempre con grande spirito di amicizia e senso di gratitudine.
Uno come loro
Ai miei occhi, Carlo è stato e rimane fondamentalmente un «uomo di Dio», cioè una persona che, vivendo del dialogo con Dio in quanto abitato dalla sua Parola, era in grado di testimoniarne l’esperienza vivificante nella sua vita facendo vedere in concreto come essa possa esplicitarsi in termini di gioia di vivere, di serenità interiore, di pungolo al bene, di fiducia nella vita, di apertura e sensibilità di cuore, di dedizione disinteressata alla causa della giustizia e della solidarietà, di umanità profonda e, soprattutto, in termini di autenticità di vita. Ove per autenticità s’intende la coerenza tra l’interno e l’esterno, la corrispondenza dell’apparire con l’essere, la capacità di esprimere ciò che effettivamente si sente e si vive.
Anche alla scuola della spiritualità di Charles de Foucauld, aveva maturato la decisione di condividere fino in fondo la condizione operaia fondamentalmente per cinque motivi:
- perché il prete, come ogni persona battezzata, deve fare la «scelta preferenziale dei poveri»;[2]
- perché negli anni ’60 i poveri a Torino erano gli operai;[3]
- perché, come prete, non gli bastava essere «a fianco» dei poveri e degli operai, ma voleva essere «come loro», come i poveri e come gli operai;
- perché la causa dei poveri e la realtà del mondo operaio, in gran parte refrattario alle «cose» di Chiesa, doveva più incisivamente interrogare, sotto il profilo pastorale, l’intera comunità ecclesiale;
- perché nella situazione «calda» della fine degli anni ’60 la testimonianza cristiana della carità andava pensata in grande e coniugata con l’istanza della giustizia sociale.
La «scelta preferenziale dei poveri» si è tradotta, per don Carlo, anche in preziosi progetti di sviluppo a favore di Paesi africani e dell’America Latina. In particolare, a testimonianza della sua volontà di spendersi per il riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano, vanno ricordati i viaggi annuali compiuti, talvolta in situazioni di reale pericolo, in Eritrea e in Brasile, utilizzando, finché è rimasto operaio, il periodo annuale di ferie.
«Quale Dio» nel ministero di Carlevaris
Penso che nei confronti degli uomini e delle donne della post-modernità, spesso indifferenti sotto il profilo della religiosità, la credibilità del prete in quanto «uomo di Dio» si giochi soprattutto in relazione alla questione di «quale Dio» egli testimoni o annunci o, più in profondità, di «quale Dio» egli viva.
Quale Dio, dunque, il presbitero Carlo Carlevaris ha cercato, vissuto, testimoniato, annunciato?
Per Carlo essere in relazione esperienziale con Dio ha significato in particolare essere in relazione con Gesù Cristo. «Uomo di Dio» ha significato per lui essere indissolubilmente anche a servizio di Gesù Cristo e «apostolo del Vangelo» (Rm1,1) da proclamare «a ogni creatura» (Mc 16,15), alla maniera di Gesù di Nazaret «mandato ad annunciare l’evangelo del regno di Dio anche alle altre città» (Lc 4,43). Cioè a portare a tutti – anche a chi non va in chiesa, o vi va raramente, o non vi va più, agli indifferenti, ai contrari, ai lontani – il Vangelo del regno di Dio, a comunicarlo con la parola e la testimonianza della vita come salvezza integrale dell’essere umano.
Carlo ha aiutato tantissime persone a riscoprire quanto la parola di Dio sia un «lieto annuncio» anche per gli uomini e le donne d’oggi, cioè una parola in grado di illuminarne e farne fiorire l’esistenza, liberandola da tutto ciò che ne impedisce l’umanizzazione in tutte le sue dimensioni. Sull’esempio di Gesù, sua preoccupazione costante è sempre stata quella di disambiguare l’immagine arcaico-sacrale di Dio, eliminandone la faccia numinosa tremenda e violenta e annunciandone con gioia l’esclusiva faccia di amore, di benevolenza e di misericordia per tutti, in particolare per i poveri e gli oppressi.
Alla luce del principio della «gerarchia delle verità», il suo modo di annunciare il Vangelo si concentrava sui contenuti essenziali, più belli, più grandi, più attraenti e, allo stesso tempo, più necessari e più in grado di scaldare il cuore. Quante volte l’ho sentito dire che da giovane prete il depositum fidei gli riempiva uno zaino intero, mentre avanti negli anni, a contatto con la vita della gente e della classe operaia, gli stava tutto, essenziale e vivo, in un taschino della tuta da lavoro!
Credibile perché pienamente umano
Le eucarestie che ogni settimana, al giovedì sera, presiedeva nella sua mansarda di via Belfiore 12 a Torino[4] erano occasione per radunare persone di ogni estrazione sociale e di ogni nazionalità (“i miei parrocchiani”, era solito definirle) attorno alla Parola di Dio, letta, meditata, pregata e condivisa sempre alla luce degli avvenimenti successi nel corso della settimana[5].
Dal «gruppo del giovedì sera» – o, meglio ancora, da chi varcava assiduamente o sporadicamente la «porta aperta» di casa sua – Carlo era riconosciuto come «pastore», investito come tale di autorità. «Autorità» deriva da augeo, da cui anche auctor, «autore», chi ha la capacità di far spuntare qualcosa di nuovo e di vitale da un terreno fertile, chi porta all’esistenza, chi fa sbocciare e crescere le potenzialità degli individui, chi apre nuovi orizzonti di senso e di impegno. Il tutto alla maniera di Gesù, le cui parole e la cui prassi schiudevano nuovi orizzonti su Dio e sull’essere umano, trasformavano le persone, le facevano rinascere e fiorire, generando discepoli e discepole capaci di parlare e di agire come lui.
Sull’esempio di Gesù Cristo che – come afferma la lettera agli Ebrei – per diventare degno di fede nelle cose che riguardano Dio e per espiare i peccati del popolo si è reso «in tutto simile ai fratelli» (Eb 2,17), Carlo ha saputo immergersi nell’umano fino a tal punto di comprensione e simpatia, da vibrare all’unisono con le angosce e le sofferenze, le gioie e le speranze degli uomini e delle donne di oggi.
Se non è umano e pienamente umano, il prete non è credibile quando parla di Dio e annuncia il Vangelo. Se non è umano, pienamente umano, il prete corre il rischio di veicolare e mediare la figura di un dio disumano e repressivo dell’umano, che non può che apparire falsa, ingannatrice, idolatrica e quindi per nulla credibile e convincente, soprattutto oggi.
Che tipo di ricchezza in umanità ha saputo vivere il prete operaio Carlo Carlevaris che gli ha permesso di svolgere, in modo credibile, la sua funzione di mediazione del Vangelo di Cristo con gli uomini e le donne dell’odierna epoca secolarizzata?
Una ricchezza di umanità acquisita con la pratica di alcune virtù fondamentali, quali l’onestà, la sincerità, l’affidabilità, la schiettezza, il senso della giustizia e della legalità, il porsi con disinteresse al servizio del bene comune, la capacità di entrare in rapporti sani e cordiali con tutti, con rispetto e comprensione, e quindi con la grande dote di saper creare – anche in contesti conflittuali – comunione e non divisione tra le persone.
Una ricchezza di umanità manifestata nella vita di Gesù di Nazaret, quale ci è narrata nei Vangeli, come la compassione, e la cura per ogni sofferenza, la libertà da ogni norma o consuetudine in contrasto con il bene dell’essere umano, l’accoglienza rispettosa di ogni persona, il profondo e intimo rapporto con Dio alimentato da una robusta spiritualità e da un’intensa preghiera personale.
La Chiesa, non solo di Torino, gli deve molto
Nell’omelia pronunciata in occasione dei funerali, l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha dichiarato che «la Chiesa di Torino deve molto a don Carlo perché, con le sue scelte anche controcorrente, l’ha stimolata a uscire fuori da una sudditanza dal potere economico e politico del suo tempo e ha contribuito a rinnovarla e a renderla più fedele al Vangelo e all’uomo».
Si può e si deve, tuttavia, affermare che la testimonianza di vita di Carlevaris sia quanto mai di stimolo anche per la Chiesa tutta di oggi, così come è sognata da papa Francesco. E questo, per almeno cinque motivi:
- con la scelta di incontrare le persone là dove vivono, lavorano e faticano, Carlo Carlevaris, sempre pronto a «sporcarsi le mani» nell’accogliere, includere e avvicinare tutti,[6] ha contribuito a declericalizzare la figura del prete, liberandola da un’aura di sacralità e di potere che poco ha a che fare con il ministero ordinato;[7]
- immergendosi pienamente nella condizione operaia, Carlo Carlevaris ci ricorda che, nella prospettiva cristiana, «essere santi non significa lustrarsi gli occhi in una presunta estasi» e contemplare il volto di Cristo significa saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi, cioè nei poveri e in coloro che fanno fatica a vivere;[8]
- impegnandosi concretamente per la tutela dei diritti degli operai e la dignità della povera gente, Carlo Carlevaris ci esorta a diffidare di quelle due «ideologie che mutilano il cuore del Vangelo», quella che separa la preghiera, l’amore di Dio, la lettura del Vangelo dalla passione e dall’efficacia della dedizione al prossimo e quella di diffidare dell’impegno sociale considerandolo come «qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista» o relativizzandolo «come se ci fossero altre cose più importanti»;[9]
- nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo, Carlo Carlevaris ha saputo coinvolgere e rendere corresponsabili uomini e donne del popolo di Dio, profondamente convinto che «ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni»;[10]
- alla «scuola» di Carlo Carlevaris abbiamo imparato che «ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo» e che la mancanza di solidarietà nei confronti del povero «influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio».[11]
In un articolo pubblicato sul settimanale torinese La Voce del Popolo nel 2007, così don Carlo tentava un bilancio dei suoi, allora, ottant’anni: «Non ho consigli da dare. Cerco ancora di imparare a vivere questa stagione, l’ultima della vita, in fedeltà alla scelta iniziale: stare tra la gente, lottare con chi lotta, difendere e servire i poveri. A dirla tutta sono contento di vivere questi ultimi anni nella soffitta di San Salvario con i neri, i musulmani e le prostitute all’angolo che mi salutano con un sorriso. C’è ancora qualcosa da fare. Auguro a tutti la scoperta dei poveri, dei deboli, degli ultimi».
Ha scritto Marta Margotti[12] sul sito di Famiglia cristiana il 4 luglio 2018: «Nelle stanze del Cottolengo, dove l’avventura sacerdotale di Carlo Carlevaris era iniziata quasi settant’anni fa, si è chiuso idealmente il cerchio della sua esistenza: prete del Novecento e cristiano del futuro, Carlevaris è vissuto senza tradire e senza tradirsi, con fatica, ma anche con la passione testarda per ogni persona che ha incontrato, fedele sino alla fine al Vangelo e alla classe operaia».
Andrea Libera
Note – – – – – – – – – –
[1] Rispettivamente, la prima al n. 182 e la seconda al n. 183 di EG.
[2] Scelta che il card. Michele Pellegrino indicò come priorità per la Chiesa torinese nella lettera pastorale del 9 dicembre 1971 Camminare insieme, alla cui stesura contribuirono in modo determinante Carlo Carlevaris e il gruppo di laici e preti che a lui facevano riferimento.
[3] In un’intervista rilasciata a Paolo Lambruschi e pubblicata sul quotidiano della CEI Avvenire del 25 aprile 2008, alla domanda “Hanno un futuro i preti operai?”, don Carlo rispose: «Non credo. Sono rimasti in pochi. E il mondo del lavoro è completamente cambiato. Dico sempre che, non avendo figli, i sacerdoti non possono trasmettere il mestiere per via ereditaria. Sono altri tempi. Oggi io stesso mi dedicherei ad altro. Per stare con i poveri oggi vivrei con gli immigrati».
[4] Sembra utile puntualizzare che la casa di Via Belfiore non era di sua proprietà. La mansarda era in affitto. Don Carlo era orgoglioso di averla in uso, di pagarne l’affitto come ogni persona normale, di dover pensare a tutto ciò che una casa comporta: bollette, pulizia, lavare e stirare, fare la spesa, cucinare ecc. Anche sotto tale profilo ha voluto vivere «come loro», cioè come la maggioranza di compagni di lavoro che vivevano in case di affitto… senza le comodità fornite da una casa parrocchiale o da un convitto. La cappella dove presiedeva la celebrazione dell’eucaristia non era fornita né di altare né di ambone: un semplice tavolo attorno al quale i suoi “parrocchiani” leggevano la Parola, pregavano e celebravano le lodi al Signore. L’ambone (o il pulpito) da lui preferito era la fabbrica, in compagnia dei compagni di lavoro.
[5] Secondo il collaudato metodo della Joc (Jeunesse ouvrière chrétienne), «vedere, giudicare, agire».
[6] Cf. Francesco, omelia in occasione dei Giubileo dei sacerdoti (Giubileo straordinario della misericordia), 3 giugno 2016.
[7] In un’intervista rilasciata nel 2013 a Marta Margotti (Università degi Studi di Torino) e a Giuseppina Vitale (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) e pubblicata su Micromega del 15 maggio 2013 don Carlo ebbe ad affermare: «Nell’ambiente più stretto dei preti sono sempre stato un rompiscatole. A me non è mai piaciuto cercare d’insegnare agli altri come prestare il loro servizio; la critica che spesso rivolgevo loro era di esser lontani dalla gente proprio per il modo di intendere il sacerdozio come separati dagli altri».
[8] L’espressione è di papa Francesco. Cf. Gaudete ed exsultate n. 96.
[9] Cf. ancora Gaudete ed exsultate, rispettivamente nn. 100 e 101.
[10] Cf., di papa Francesco, Evangelii gaudium n. 120.
[11] Cf. Evangelii gaudium n. 187.
[12] Docente di storia contemporanea al Dipartimento di studi storici dell’Università di Torino ed esperta in storia del cristianesimo in Italia e in Francia nell’Ottocento e nel Novecento.