INTELLIGENZA ARTIFICIALE
STRUMENTO AFFASCINANTE E TREMENDO
Francesco
Vescovo di Roma
L’IA si sta dimostrando una delle sfide più complesse del cambiamento d’epoca che ci avviamo ad attraversare. Il discorso che il papa ha pronunciato il 14 giungo 2024 alla sessione del G7 sull’Intelligenza artificiale, di cui riproponiamo qui di seguito un’ampia parte, è indubbiamente un riferimento importante per il richiamo dell’attenzione di tutti alla posta in gioco.
I titoletti sono della redazione, i tagli sono segnalati in parentesi, mentre le note mantengono la numerazione del testo integrale.
[…] Parlare di tecnologia è parlare di cosa significhi essere umani e quindi di quella nostra unica condizione tra libertà e responsabilità, cioè vuol dire parlare di etica. Quando i nostri antenati, infatti, affilarono delle pietre di selce per costruire dei coltelli, li usarono sia per tagliare il pellame per i vestiti sia per uccidersi gli uni gli altri. […]
Mentre l’uso di un utensile semplice (come il coltello) è sotto il controllo dell’essere umano che lo utilizza e solo da quest’ultimo dipende un suo buon uso, l’intelligenza artificiale, invece, può adattarsi autonomamente al compito che le viene assegnato e, se progettata con questa modalità, operare scelte indipendenti dall’essere umano per raggiungere l’obiettivo prefissato [7].
Decidere: un compito dell’essere umano
Conviene sempre ricordare che la macchina può, in alcune forme e con questi nuovi mezzi, produrre delle scelte algoritmiche. Ciò che la macchina fa è una scelta tecnica tra più possibilità e si basa o su criteri ben definiti o su inferenze statistiche. L’essere umano, invece, non solo sceglie, ma in cuor suo è capace di decidere. La decisione è un elemento che potremmo definire maggiormente strategico di una scelta e richiede una valutazione pratica.
A volte, spesso nel difficile compito del governare, siamo chiamati a decidere con conseguenze anche su molte persone. Da sempre la riflessione umana parla a tale proposito di saggezza, la phronesis della filosofia greca e almeno in parte la sapienza della Sacra Scrittura.
Di fronte ai prodigi delle macchine, che sembrano saper scegliere in maniera indipendente, dobbiamo aver ben chiaro che all’essere umano deve sempre rimanere la decisione, anche con i toni drammatici e urgenti con cui a volte questa si presenta nella nostra vita.
Condanneremmo l’umanità a un futuro senza speranza, se sottraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita condannandole a dipendere dalle scelte delle macchine.
Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo significativo dell’essere umano sul processo di scelta dei programmi di intelligenza artificiale: ne va della stessa dignità umana.
Proprio su questo tema permettetemi di insistere: in un dramma come quello dei conflitti armati è urgente ripensare lo sviluppo e l’utilizzo di dispositivi come le cosiddette “armi letali autonome” per bandirne l’uso, cominciando già da un impegno fattivo e concreto per introdurre un sempre maggiore e significativo controllo umano. Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano. […]
Il sottile meccanismo dell’IA
Nella sua essenza l’intelligenza artificiale è un utensile disegnato per la risoluzione di un problema e funziona per mezzo di un concatenamento logico di operazioni algebriche, effettuato su categorie di dati, che sono raffrontati per scoprire delle correlazioni, migliorandone il valore statistico, grazie a un processo di auto-apprendimento, basato sulla ricerca di ulteriori dati e sull’auto-modifica delle sue procedure di calcolo.
L’intelligenza artificiale è così disegnata per risolvere dei problemi specifici, ma per coloro che la utilizzano è spesso irresistibile la tentazione di trarre, a partire dalle soluzioni puntuali che essa propone, delle deduzioni generali, persino di ordine antropologico.
Un buon esempio è l’uso dei programmi disegnati per aiutare i magistrati nelle decisioni relative alla concessione dei domiciliari a detenuti che stanno scontando una pena in un istituto carcerario. In questo caso, si chiede all’intelligenza artificiale di prevedere la probabilità di recidiva del crimine commesso da parte di un condannato a partire da categorie prefissate (tipo di reato, comportamento in prigione, valutazione psicologiche ed altro), permettendo all’intelligenza artificiale di avere accesso a categorie di dati inerenti alla vita privata del detenuto (origine etnica, livello educativo, linea di credito ed altro). L’uso di una tale metodologia – che rischia a volte di delegare de facto a una macchina l’ultima parola sul destino di una persona – può portare con sé implicitamente il riferimento ai pregiudizi insiti alle categorie di dati utilizzati dall’intelligenza artificiale.
L’essere classificato in un certo gruppo etnico o, più prosaicamente, l’aver commesso anni prima un’infrazione minore (il non avere pagato, per esempio, una multa per una sosta vietata), influenzerà, infatti, la decisione circa la concessione dei domiciliari. Al contrario, l’essere umano è sempre in evoluzione ed è capace di sorprendere con le sue azioni, cosa di cui la macchina non può tenere conto. […]
Sofisticate o meno che siano, la qualità delle risposte che i programmi di intelligenza artificiale forniscono dipendono in ultima istanza dai dati che essi usano e come da questi ultimi vengono strutturati.
IA “generativa” o “rafforzativa”?
Mi permetto di segnalare, infine, un ultimo ambito in cui emerge chiaramente la complessità del meccanismo della cosiddetta intelligenza artificiale generativa (Generative Artificial Intelligence). […] Molti di noi sono rimasti colpiti dalle applicazioni facilmente disponibili online per comporre un testo o produrre un’immagine su qualsiasi tema o soggetto. Particolarmente attratti da questa prospettiva sono gli studenti che, quando devono preparare degli elaborati, ne fanno un uso sproporzionato.
Questi alunni, che spesso sono molto più preparati e abituati all’uso dell’intelligenza artificiale dei loro professori, dimenticano, tuttavia, che la cosiddetta intelligenza artificiale generativa, in senso stretto, non è propriamente “generativa”. Quest’ultima, in verità, cerca nei big data delle informazioni e le confeziona nello stile che le è stato richiesto. Non sviluppa concetti o analisi nuove. Ripete quelle che trova, dando loro una forma accattivante. E più trova ripetuta una nozione o una ipotesi, più la considera legittima e valida. Più che “generativa, essa è quindi “rafforzativa, nel senso che riordina i contenuti esistenti, contribuendo a consolidarli, spesso senza controllare se contengano errori o preconcetti.
In questo modo, non solo si corre il rischio di legittimare delle fake news e di irrobustire il vantaggio di una cultura dominante, ma di minare altresì il processo educativo in nuce. L’educazione che dovrebbe fornire agli studenti la possibilità di una riflessione autentica rischia di ridursi a una ripetizione di nozioni, che verranno sempre di più valutate come inoppugnabili, semplicemente in ragione della loro continua riproposizione [11].
Rimettere al centro la dignità della persona
A quanto già detto va ora aggiunta un’osservazione più generale. La stagione di innovazione tecnologica che stiamo attraversando, infatti, si accompagna a una particolare e inedita congiuntura sociale: sui grandi temi del vivere sociale si riesce con sempre minore facilità a trovare intese. Anche in comunità caratterizzate da una certa continuità culturale, si creano spesso accesi dibattiti e confronti che rendono difficile produrre riflessioni e soluzioni politiche condivise, volte a cercare ciò che è bene e giusto. Oltre la complessità di legittime visioni che caratterizzano la famiglia umana, emerge un fattore che sembra accomunare queste diverse istanze.
Si registra come uno smarrimento o quantomeno un’eclissi del senso dell’umano e un’apparente insignificanza del concetto di dignità umana [12]. Sembra che si stia perdendo il valore e il profondo significato di una delle categorie fondamentali dell’Occidente: la categoria di persona umana. Ed è così che in questa stagione in cui i programmi di intelligenza artificiale interrogano l’essere umano e il suo agire, proprio la debolezza dell’ethos connesso alla percezione del valore e della dignità della persona umana rischia di essere il più grande vulnus nell’implementazione e nello sviluppo di questi sistemi.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nessuna innovazione è neutrale. La tecnologia nasce per uno scopo e, nel suo impatto con la società umana, rappresenta sempre una forma di ordine nelle relazioni sociali e una disposizione di potere, che abilita qualcuno a compiere azioni e impedisce ad altri di compierne altre. […]
Questo vale anche per i programmi di intelligenza artificiale. Affinché questi ultimi siano strumenti per la costruzione del bene e di un domani migliore, debbono essere sempre ordinati al bene di ogni essere umano. Devono avere un’ispirazione etica.
La decisione etica, infatti, è quella che tiene conto non solo degli esiti di un’azione, ma anche dei valori in gioco e dei doveri che da questi valori derivano. […] Per questa ragione è nata la Rome Call: nel termine “algoretica” si condensano una serie di principi che si dimostrano essere una piattaforma globale e plurale in grado di trovare il supporto di culture, religioni, organizzazioni internazionali e grandi aziende protagoniste di questo sviluppo.
L’urgenza dell’azione politica
Non possiamo, quindi, nascondere il rischio concreto, poiché insito nel suo meccanismo fondamentale, che l’intelligenza artificiale limiti la visione del mondo a realtà esprimibili in numeri e racchiuse in categorie preconfezionate, estromettendo l’apporto di altre forme di verità e imponendo modelli antropologici, socioeconomici e culturali uniformi. Il paradigma tecnologico incarnato dall’intelligenza artificiale rischia allora di fare spazio a un paradigma ben più pericoloso, che ho già identificato con il nome di “paradigma tecnocratico” [15].
Non possiamo permettere a uno strumento così potente e così indispensabile come l’intelligenza artificiale di rinforzare un tale paradigma, ma anzi, dobbiamo fare dell’intelligenza artificiale un baluardo proprio contro la sua espansione.
Ed è proprio qui che è urgente l’azione politica, come ricorda l’Enciclica Fratelli tutti. Certamente «per molti la politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a indebolirla, a sostituirla con l’economia o a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica?» [16].
La nostra risposta a queste ultime domande è: no! La politica serve! Voglio ribadire in questa occasione che «davanti a tante forme di politica meschine e tese all’interesse immediato […] la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione e ancora di più in un progetto comune per l’umanità presente e futura» [17]. […]
Come ho già detto altrove, «la società mondiale ha gravi carenze strutturali che non si risolvono con rattoppi o soluzioni veloci meramente occasionali. Ci sono cose che devono essere cambiate con reimpostazioni di fondo e trasformazioni importanti. Solo una sana politica potrebbe averne la guida, coinvolgendo i più diversi settori e i più vari saperi. In tal modo, un’economia integrata in un progetto politico, sociale, culturale e popolare che tenda al bene comune può “aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo” (Laudato si’, 191)» [18].
Questo è proprio il caso dell’intelligenza artificiale. Spetta ad ognuno farne buon uso e spetta alla politica creare le condizioni perché un tale buon uso sia possibile e fruttuoso.
— Note ——
[7] Cfr Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2024, 3.
[11] Cfr ivi, 3 e 7.
[12] Cfr Dicastero per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Dignitas infinita circa la dignità umana (2 aprile 2024).
[15] Per una più ampia esposizione, rimando alla mia Lettera Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune del 24 maggio 2015.
[16] Lettera enc. Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia sociale (3 ottobre 2020), 176.
[17] Ivi, 178.
[18] Ivi, 179.
[Pubblicato il 26.6.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: coe.int]



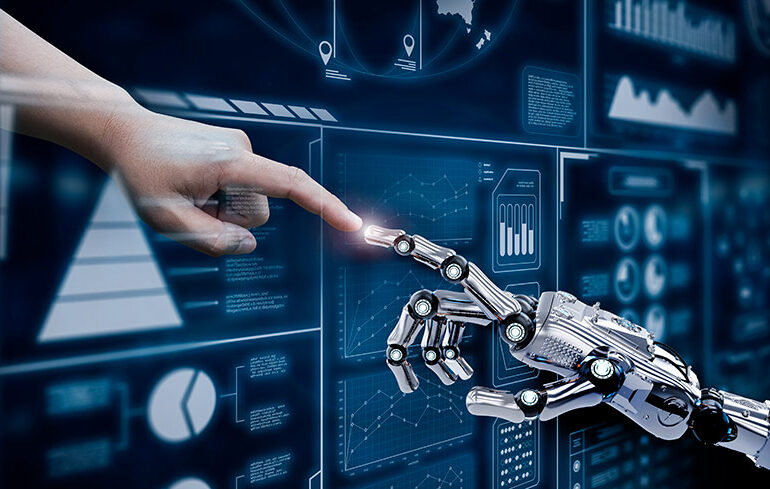



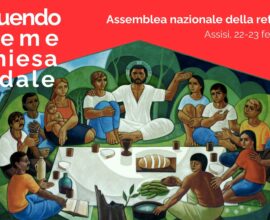
PAROLE CHIARE, DEFINITIVE, ANCHE PER I NON CREDENTI