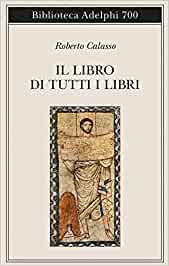LA BIBBIA SECONDO CALASSO
Recensire Roberto Calasso e il suo “Libro di tutti i libri” è davvero un’impresa. Farlo in meno di 10.000 battute sarebbe partita da lasciar perdere se non fosse che di questa lettura bisogna parlare, per svariati motivi, non ultimo quello che Calasso muove dalla convinzione che l’ebraismo sia una componente fondamentale dell’identità occidentale. E sull’identità, per quanto ha di aperto e di inclusivo, oggi è giusto, necessario puntare l’attenzione.
Quelle che seguono non possono essere che poche e frettolose osservazioni che si propongono di suscitare curiosità e voglia di confrontarsi con questo lavoro, il decimo che Calasso propone sul mondo della religiosità. Questa sua puntigliosa e insistita esplorazione iniziata nel 1983 (sembra un secolo fa!) con La Rovina di Kasch (un viaggio attraverso il mare della Storia) al quale fa seguito il famoso Le nozze di Cadmo e Armonia, (dove narra come un romanzo la mitologia greca), si dipana per altri sette lavori, tutti densi e poderosi, fino ad arrivare a questa “Bibbia secondo Calasso”, come è stata definita da qualcuno.
Si tratta di oltre 500 pagine dense di narrazioni e di osservazioni storiche, antropologiche e teologiche e psicologiche e ancora archeologiche, proposte con uno stile gradevole, comprensibile sempre (a parte qualche preziosismo lessicale), emozionante in più di un passaggio. Senza comunque mai tralasciare il rigore. Uno dei tanti pregi di quest’opera è infatti la precisa, essenziale indicazione delle fonti (più di 60 pagine di secche segnalazioni di titolo del testo (biblico o altro), numero di capitolo, paragrafo da cui il passo è tratto).
Per venire ai contenuti, parto dall’exergo che, come spesso accade ed è così anche in questo caso, è un’utile indicazione del taglio che l’autore intende dare al suo lavoro:
“Così, libro dopo libro, il libro di tutti i libri potrebbe mostrarci che ci è stato dato perché tentiamo di entrarvi come in un secondo mondo e li ci smarriamo, ci illuminiamo e ci perfezioniamo.” Goethe.
Dunque un libro, tanti libri, come un percorso che vale la pena di intraprendere ben sapendo che comunque ci smarriremo ma ugualmente ne saremo illuminati e ne usciremo perfezionati. Rivelatrice dunque questa citazione che fotografa felicemente l’atteggiamento mentale ed emotivo con il quale Calasso lavora attorno a questo “libro dei libri” (non sarà sfuggito che il titolo del suo lavoro è preso di sana pianta da Goethe).
Calasso dunque entra in questo mondo raccontandolo a sua volta. E commentandolo.
Ecco, nel commento, in questa attività a cui non siamo più abituati oggi, sta, a mio avviso, una delle principali peculiarità di questo lavoro. Un approccio più vicino all’attitudine medioevale che al nostro procedere illuministico che ci porta a interpretare, a spiegare più che a penetrare un testo. Mi spiego. Noi oggi fatichiamo a metterci davanti a un testo e lasciarlo che lieviti sotto i nostri occhi e dentro il nostro cuore: a lasciare che faccia emergere tutto quello che ha dentro ascoltandolo, osservandolo con attenzione e rispetto vero, senza spaventarci delle sue oscurità, delle contraddizioni, delle ripetizioni, lasciando che ci porti dove chiede lui e non dove vogliamo o vorremmo noi. Senza sentirci in nessun modo obbligati a capire, a far rientrare quello che ci rappresenta in un contesto consolidato, a tirare conclusioni, a indicare soluzioni. Senza cercare una coerenza a tutti i costi, voler trovare un senso ad ogni riga e passaggio e parola. Piuttosto individuando rimandi, concordanze, accettando illuminazioni, debolezze, oscurità, analogie. Calasso non smette di evidenziare come la Bibbia proponga e metta accanto uno all’altro fatti, accadimenti, persone senza dare spiegazioni, senza cercare una sequenza logica, senza evidenziare rapporti di causa-effetto. Il modo di vedere la vita e il mondo di cui è espressione questo variegato e per certi versi strano insieme di libri non è logico (almeno secondo le regole della nostra logica), meglio non si sviluppa secondo le regole di ragionamento e le modalità di indagine e di comprensione tipiche del nostro modo di guardare la realtà. Del resto, il testo biblico è costantemente elusivo oltre che omissivo (Iahvè spesso è in collera e altrettanto spesso i motivi di questa collera come i motivi delle sue scelte non vengono indicati: perché la sua preferenza cade su Abramo prima e poi su Mosè e ancora su Davide e via elencando?). Succede spesso perciò che un accenno, una frase, un particolare apparentemente non necessari nell’economia di un racconto diventino poi rivelatori, quasi la pietra angolare su cui costruire un nuovo discorso in un contesto più ampio e in un insieme di riferimenti e di significati da individuare di volta in volta. Ma per fare questo occorre un’estrema attenzione e pazienza, perché magari si tratta di legami da cercare in altri libri o in realtà diverse che però parlano la stessa “lingua” e a un medesimo contesto culturale. È questo un metodo che fa parlare la storia e non parla della storia, che porta a stare dentro a un flusso, a un “percorso” (come lo chiama Goethe) preciso che è culturale e allo stesso tempo esistenziale, al quale ci si accosta per capirlo non per usarlo.
Anche Calasso non ha tesi da dimostrare, non cerca una coerenza narrativa o teorica, procede per spunti apparentemente scollegati che poi nel procedere della narrazione acquistano una loro coerenza e unità. Se interviene lo fa spesso con secche annotazioni, vere perle preziose per chi legge. Qualche esempio:
«Che il libero arbitrio sussista, nessuno può affermarlo con certezza. Ma chiunque può testimoniare di possedere la sensazione del libero arbitrio».
«A nessuno le teorie di Freud si applicano meglio che a Freud stesso. Prima di essere scienza la psicoanalisi è autobiografia».
La peculiarità della Bibbia «è appunto questa: non rassicurare».
Sul Dio biblico osserva acutamente che l’autore del Genesi ce lo rappresenta come il più grande nemico di idoli, un Dio che proibisce e punisce severamente ogni tentativo di rappresentare il divino, e però poi, quando è impegnato a creare l’uomo, lo plasma a sua immagine e somiglianza. Incoerenza del Creatore che si riflette subito sulla sua creatura. Poteva l’uomo, proprio per il suo essere simile al proprio creatore, non essere indotto a produrre nuovi idoli, in una sequenza inarrestabile, data la potenza della spinta iniziale in quella direzione?
Ci sono parole/concetti su cui Calasso torna periodicamente e costituiscono come tanti fili che guidano lui e noi dentro il labirinto del mondo biblico, parole come (tanto per citarne alcune tra le tante) elezione, sacrificio, legittimità, stirpe. E proprio a riguardo di quest’ultimo principio ordinatore della narrazione biblica voglio sottolineare questa osservazione che, forse discutibile in sé, è comunque un chiaro indice dell’approccio di Calasso alla materia che osserva. Alla stirpe di Abramo e poi a quella di Davide, e non agli atti dei singoli, Dio affida la sua permanenza nel mondo. Iahvè cioè agisce nella storia talvolta attraverso, talvolta nonostante, i singoli ma la sua fedeltà è sempre alla stirpe, non all’individuo. Cosi che il comandamento «non uccidere» all’inizio sembra fare riferimento non tanto al valore della vita umana (ci vorranno secoli per giungere a tanto) quanto al fatto che l’omicidio come tale annulla un’intera possibile discendenza.
Anche nei passaggi più prettamente simbolici come la creazione, l’idolatria, il culto rituale e profetico, l’eletto e l’elezione, il tempio eretto e distrutto ecc. Calasso evita il discorso teologico dell’«ispirazione», ossia sull’incrocio tra Parola trascendente e parole storiche. Il suo occhio “laico” osserva come il testo biblico, la più sacra delle storie mai raccontate, si svolga spesso nel sangue e nello sterminio, dove il bene e il male non compaiono quasi mai nella loro ingombrante opposizione, tutta moderna, e dove il Principio di tutte le cose sta al di là del bene e del male e, quasi indifferente, fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi.
Indimenticabili le osservazioni che troviamo sul Cantico dei cantici che l’autore vede come “una scheggia conficcata in uno strato geologico chimicamente estraneo. […] Non presenta mai un gesto di ossequio o devozione a potenze superiori. Ancor più ignora ogni cenno di rifiuto. È autosufficiente […] insinua la possibilità di fare a meno di ogni significato ulteriore.». Come è possibile che un simile libro sia stato ammesso nel canone biblico, in quel poderoso insieme di libri dove Dio è l’inizio e la fine e la causa di tutto? Interrogativo che Calasso pone appena e lo dimentica subito. Per lui questa scheggia c’è, conficcata ben dentro, e per lui tanto basta: la sua attenzione si concentra su cosa costituisca questa scheggia così concreta, umana, fisica e nello stesso tempo così misteriosa (“Parla per aneddoti cifrati, non spiega mai nulla”), su cosa questa presenza produca. A lui interessa farla parlare, individuare quante più cose possibile era in grado di dire a chi la leggeva allora e quante cose ha continuato a dire nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri, fino a noi che magari, rispetto ai nostri antenati di Giudea, in tema di erotismo ci sentiamo più “esperti” e più liberi di loro. Forse che si, forse che no.
Interessante e inaspettata l’attenzione che Calasso riserva a Freud, l’unica figura non biblica a cui dedica un intero capitolo. Ritenendolo indispensabile per comprendere i rapporti tra la cultura ebraica e l’identità occidentale, analizza con puntigliosità critica il celebre saggio del padre della psicoanalisi su Mosè e la religione ebraica. Del resto già prima di questo capitolo ci aveva offerto una delle sue sintesi improvvise, preziose: Giuseppe, in Egitto, era un maestro nell’interpretazione dei sogni e perciò divenne il consigliere di Faraone; un altro ebreo in esilio, Daniele, interpretava i sogni di Nabuccodonosor; nel 1899 un terzo ebreo della diaspora, Sigmund Freud, scrisse a Vienna il suo libro più noto, L’interpretazione dei sogni.
Non voglio finire senza almeno un cenno al ritratto intenso e a volte commovente che fa di Abramo, il padre di “quelli che andarono via”, quello da cui ebbero inizio “la separazione e il viaggio: due tratti che avrebbero distinto per sempre i figli di Israele.” Una fitta serie di deduzioni e osservazioni dalla storia di questo padre così come raccontata dalla Bibbia ne fa davvero il capostipite, allora e per sempre, di un popolo sconfinato, il primo dei tanti che andarono e vanno via, “destinati” al distacco. Dei molti innamorati della condizione di esodo.
Giuseppe Bovo
Roberto Calasso, Il libro di tutti i libri, Adelphi, Milano 2019, pp. 555
Questa recensione è stata pubblicata dalla rivista “Esodo” (n. 3/2020, pp. 58-61), che aderisce alla Rete dei Viandanti.