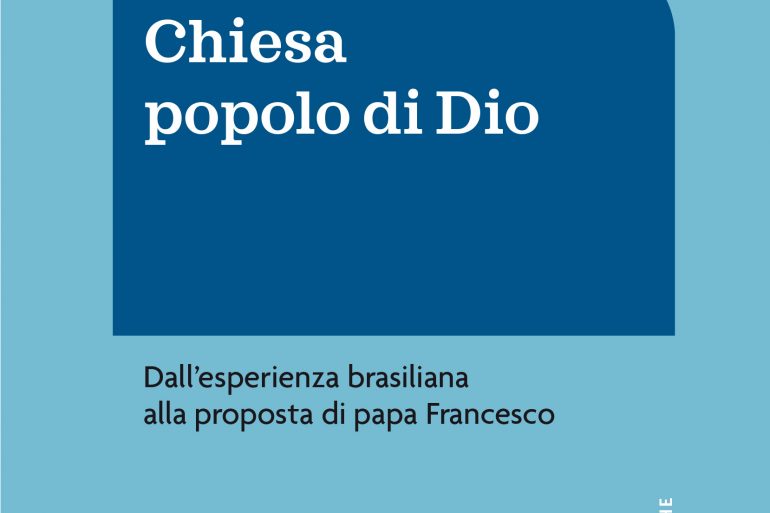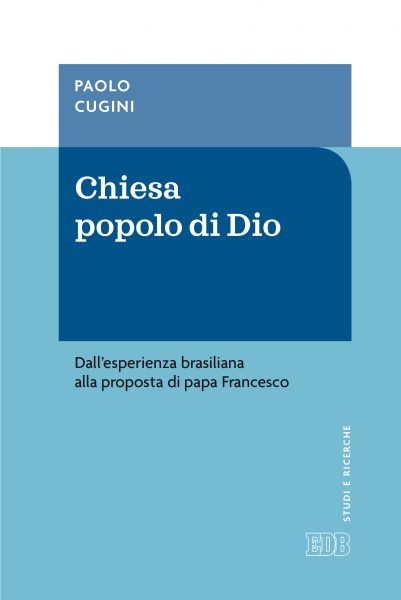LA CHIESA DI FRANCESCO
Il tema trattato nel libro di Paolo Cugini, “Chiesa popolo di Dio. Dall’esperienza brasiliana alla proposta di papa Francesco” può sembrare a prima vista “lontano” a un cattolico italiano – sacerdote, laico o accademico – perché troppo lontana è l’esperienza delle comunità ecclesiali di base (CEB) brasiliane rispetto alle parrocchie della nostra penisola. Eppure, è un testo che merita davvero di essere letto – a tutti i livelli: è un testo accademico, ma di piacevole lettura. In quanto segue vorrei persuadere il lettore in tal senso, elencando una serie di ragioni che, in buona misura, rispecchiano le parti del titolo.
Per riassaporare la portata innovativa
Il libro offre una puntuale sintesi della teologia della Chiesa come popolo di Dio (capp. 1, 2 e 3 della parte II) – tema centrale della Lumen Gentium – dalle sue radici bibliche all’elaborazione conciliare, al dibattito ecclesiologico post-conciliare. Per chi ha dimenticato questa teologia nel cassetto – o l’ha volutamente seppellita nel cimitero degli intralci teologici – è fondamentale riscoprirla e riassaporarne la portata innovativa. In una fase della nostra Chiesa in cui le spinte anti-conciliari si sono fatte più forti e sfacciate, un recupero (una difesa?) delle profetiche intuizioni dei padri conciliari è una boccata d’ossigeno offerta al lettore.
Come giustamente sottolinea Cugini, l’immagine della Chiesa popolo di Dio è spesso depotenziata nei manuali di ecclesiologia, almeno nelle implicazioni “scomode” che essa porta con sé. Recuperarla non significa esaltarla tout court: il libro aiuta a capire perché una certa radicalizzazione del modello “Chiesa popolo di Dio” avvenuta nel contesto della teologia della liberazione abbia poi portato la Chiesa di Roma ad intervenire – sempre nei documenti ufficiali – sostituendola col modello di “Chiesa come comunione”, in un gioco di reciproche incomprensioni dovute a una certa fase storica. I tempi sono però maturi – e questo libro ne è un emblema – per una rinnovata attenzione al tema e alla sua fecondità.
La nozione di popolo
Riflettere sulla nozione biblica ed ecclesiale di popolo, inoltre, nell’età dei populismi, è operazione indispensabile. Tale nozione, infatti, Cugini lo fa emergere molto bene, indica molti aspetti: 1) ogni popolo è sintesi di popoli: una nozione astratta del primo è un’illusione; 2) “popolo” non è contrario a “élite”: il popolo è sintesi dei membri “semplici” e delle loro “guide”.
Il popolo di Dio che è la Chiesa è tutti i suoi membri: laici e clerici, coloro che hanno funzioni educative, direttive e organizzative. Una Chiesa come popolo di Dio non è una chiesa destrutturata, bensì un organismo che vive il rapporto tra le sue componenti nel pieno rispetto e sostegno reciproco.
Cugini mostra in che modo Papa Francesco intenda la nozione di popolo, acquisendo e proponendo una teologia del popolo. Certo, la nozione di popolo è per sua natura piuttosto vaga (l’esistenza di un popolo e di quel popolo rischia sempre di doversi appoggiare alla mitologia), eppure ha, in teologia, una valenza specifica, che Cugini fa emergere con chiarezza.
L’esperienza delle Ceb
Una possibile incarnazione (o “ricezione”) di tale teologia sono state, secondo l’autore, le CEB. L’analisi della loro parabola esistenziale – la nascita, l’apice e la situazione molto precaria attuale, le tensioni con Roma – svolta tramite i principali documenti della Chiesa latinoamericana (Medellín e Puebla, tra altri; è questa una scelta metodologica di Cugini), ci porta inevitabilmente a riflettere anche sulla nostra esperienza di Chiesa italiana (come abbiamo recepito il Vaticano II?) e sulle nostre parrocchie. Non per trasferire un’esperienza da un Paese all’altro, ammonisce l’autore: «Il risultato di una simile operazione di trasferimento sarebbe quello di forzare un contesto, snaturando l’origine dei modelli e provocando reazioni negative in chi si sente costretto a viverlo» (p. 331). Piuttosto, la riflessione è utile per pensare a quali percorsi avviare nel nostro Paese: l’esperienza delle CEB aiuta almeno a sognare e sperare una Chiesa possibile. Cugini mostra anche con efficacia quali siano i rapporti tra CEB, politica e movimenti carismatici e pentecostali più recenti: anche queste sono dinamiche che, in modo diverso, si sono innescate nelle nostre parrocchie.
Le nostre parrocchie
Riflessione indispensabile visto anche il recente – e contestato – documento “La conversione pastorale della comunità parrocchiale”: ci sono alcune convergenze, mi pare, tra questo documento e le riflessioni portate avanti nel testo (la chiesa missionaria e sinodale, ad esempio) ma anche molte distanze: si pensi all’incomprensibile timore di affidare la gestione della parrocchia ai laici (che ancora traspare al par. VIII.h.).Il documento richiama “l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II” (n. 1 e n. 122) ma senza esplicitarla. Forse perché, di fatto, non ne esiste solo una, come il libro di Cugini fa emergere chiaramente.
Personalmente, mi sono trovato davvero ingaggiato dalla sfida di pensare a cosa desideriamo che siano le nostre parrocchie. Cugini indica, tra le altre, la via della “comunità di comunità” (che si ritrova anche nel documento summenzionato), sicuramente appropriata per la realtà europea, dove ormai i membri delle parrocchie, soprattutto se giovani, tendono ad essere meno legati al territorio. Ci si può chiedere, tuttavia – non in forma polemica, ma come dialogo con l’Autore e come prova della fecondità del suo lavoro – se la descrizione della parrocchia come «luogo dell’amore fraterno e il rispetto reciproco» (p. 39) non sia troppo idilliaca. Vero è che Cugini indica le parrocchie anche come «luogo del perdono» (ibi), cioè luogo del superamento delle controversie, ma questo andrebbe forse sviluppato ulteriormente.
Il luogo dell’incontro dell’umano
Chiunque ha frequentato una parrocchia l’avrà scoperta «luogo dell’umano», delle sue bassezze e infermità. Luogo trasformato in una piccola chiesa in quanto, nonostante le piccolezze dei suoi membri, è amata e perdonata da Dio. Del resto, Cristo ha scelto Pietro, dalla grande fede, ma anche il peggiore degli apostoli: una scommessa sull’umano così com’è, debole ma graziato e sostenuto da Dio.
Allora, mentre nelle nostre società ci si chiude in cerchie confortevoli di “simili ed eletti” (e possibilmente perfetti…), la parrocchia dovrebbe restare il luogo dell’incontro di tutto l’umano, nella sua inalienabile fragilità, che pure Dio ha amato. Luogo dove tutti i reietti si possono sentire a casa.
La bellezza della parrocchia – che la rende come un sacramento – sta nella presenza amata dell’umano così com’è, non di un umano “selezionato”. Conseguentemente, luogo di mediazione del conflitto: la pace, la liturgia ce lo ricorda, non è l’assenza di conflitto, ma è la presenza di Gesù. Nella parrocchia si vive quotidianamente la povertà dell’umano, che pur è sostenuto da Cristo e si trova, per un momento settimanale, nella pace della liturgia: dopo le lotte – incancellabili – ci si trova a pregare insieme invocando la grazia e la pace (che solo da Dio procede) su di sé e sugli altri.
La gestione del conflitto
In questa luce, può diventare ancor più fondamentale l’analisi svolta da Cugini del metodo di Bergoglio della gestione del conflitto (p. 251), che ha molta affinità con il pensiero nonviolento. Per Bergoglio il conflitto non va evitato, ma neppure ci si deve lasciar imprigionare da esso, perdendo di vista l’orizzonte. Il conflitto va compatito, trasformato in un anello di una catena di sviluppo, che porta a una sintesi non sincretistica. La società, oggi, sembra invece incapace di gestire fruttuosamente il conflitto: lo evita o lo inasprisce, non lo gestisce.
Anche nella Chiesa pre-Francesco, a essere onesti, c’era poco spazio per la mediazione del conflitto: esso veniva ricusato, visto con sospetto, mal sopportato e quindi brutalmente soppresso, perché deturpava l’anestetico idillio di una Chiesa gloriosa e compatta.
Nella prospettiva della Chiesa come popolo di Dio, invece, il conflitto è parte naturale del percorso di maturazione della Chiesa stessa nella storia, e viene visto come fermento, vitalità e possibilità di miglioramento. La Bibbia, del resto, è la storia di macro e micro conflitti risanati, totalmente o parzialmente, dalla grazia di Dio. In questa Chiesa, gli scomodi profeti e i sacerdoti più stabilizzatori, i ribelli e i mediatori, il carisma e l’istituzione (tema che si trova nel libro), convivono nella difficile arte di trovare una sintesi che non li annulli.
L’ecclesiologia di Francesco
E si viene così all’ultima parte del libro, quella deputata a mostrare le radici del pensiero di papa Francesco, le risonanze nei suoi documenti recenti e la proposta ecclesiale del papa. La parte III del libro aiuta davvero a comprendere il papato di Francesco (o almeno a farci capire perché non lo capiamo!) e il perché delle resistenze che trova in parte della gerarchia. La sua vita, ricostruita da Cugini, è stata segnata dalla spiritualità ignaziana attenta al discernimento e da quella che viene definita teologia del popolo, una teologia della liberazione senza marxismo (dal quale Bergoglio ha sempre preso le distanze), nonché dal pensiero polare di Romano Guardini, che cerca pazientemente (il tempo è superiore allo spazio) l’unità nell’ineliminabile diversità e polarità che segna la condizione umana.
A volte ci sorprende quanto il papa sappia essere sereno di fronte agli attacchi e alle divisioni attuali della Chiesa. Il suo background culturale e l’esperienza di vita maturata, ben esposti dall’autore, ci aiutano non poco a capire: «Le tensioni polari indicano processi che devono essere accompagnati perché, più che soluzioni immediate, esigono la sapienza del discernimento, e questo più che la soddisfazione del momento esige tempo» (p. 242). Come non vedere in queste righe l’opera sapiente di riforma delle strutture e della mentalità della Chiesa che Francesco sta attuando?[1]
Accompagnare, discernere, integrare
Le strane vie della Provvidenza: il modello di Chiesa come popolo di Dio ha attecchito in America Latina, mentre è soffocato nel resto dell’Occidente, eppure il Concilio è tornato a Roma attraverso il papa che viene dalla fine del mondo e che ha visto con i suoi occhi (e senza nostalgie) la fine di un mondo, quello pre-conciliare. Bergoglio è il primo papa completamente conciliare, cresciuto in un terreno in cui il Concilio è fiorito spontaneamente. Tanto che, nei documenti di Bergoglio, i testi del Vaticano II sono poco citati, ma emergono implicitamente molto spesso (pp. 256-259).
La Chiesa di Francesco che si delinea nei suoi documenti, ricorda Cugini, ha delle caratteristiche evidenti: è missionaria, consapevole della necessaria inculturazione, una Chiesa che vive l’opzione fondamentale per i poveri, la sinodalità, una Chiesa della misericordia, inclusiva, capace di “accompagnare, discernere, integrare”, capace di dare priorità alla coscienza e importanza ai laici (e laiche!). Sono aspetti che Bergoglio mutua dalla sua formazione e dalla particolare ricezione che il Concilio ha avuto in America Latina. Ed è il modo di Francesco di riproporre e interpretare la Chiesa come popolo di Dio.
La questione ecclesiologica della Chiesa come popolo di Dio, infine, investe anche la teologia morale. Partendo da una rinnovata attenzione al ruolo della coscienza (pp. 303ss) Cugini evidenzia il legame tra essa e il sensus fidei, tra accoglienza e discernimento. La Chiesa come popolo di Dio è una comunità che integra (p. 322) e quindi è ben consapevole non solo della famosa “legge della gradualità”, ma anche, si spinge a sostenere l’autore, la “gradualità della norma” (p. 322). Questo, conclude Cugini, comporta un parziale superamento della Veritatis Splendor, che la Chiesa di Francesco sta effettuando attraverso il recupero di un’antica tradizione ravvivata dal Concilio.
È evidente dunque la ricchezza contenutistica di questo volume – in queste poche righe molti temi affrontati non sono stati esposti! – nonché l’importanza di una sua lettura per comprendere meglio alcune dinamiche della chiesa contemporanea.
Damiano Migliorini
Paolo Cugini, Chiesa Popolo di Dio. Dall’esperienza brasiliana alla proposta di papa Francesco, EDB, Bologna 2020, p. 392.
Recensione ripresa da Adista (25/08/2020) https://www.adista.it/articolo/64024
Note – – – – – – – – –
[1] L’autore ci aiuta, indirettamente, anche a capire la posizione di Bergoglio sull’Europa, esponendo le sue posizioni da arcivescovo sulla cosiddetta “patria grande”.