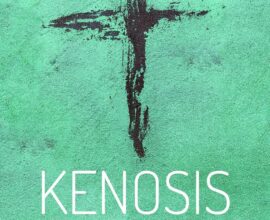LA RINASCITA DEL PENSIERO FEMMINILE
COINCIDE CON L’ALBA DEL MODERNO

È vero: in Italia, il termine “modernismo” ha rimandato a lungo – e persino prima dell’enciclica Pascendi del 1907- a contesti di carattere religioso dove fu configurato come «la sintesi delle eresie», esprimendo invece tentativi di conciliare dottrina cattolica e società moderna, rivelazione neotestamentaria e correnti filosofiche… Ma è altrettanto vero che, nel mondo, dalla sua comparsa negli Anni ‘20 in ambito anglofono, sino a oggi, lo stesso termine è stato interpretato anche in chiave estetica, letteraria, artistica, in relazione alla nozione di rottura con pratiche e stili precedenti, quale dimensione espressiva della modernità.
In questa logica tiene bene insieme i due filoni il nuovo saggio di Fulvio De Giorgi dal titolo Il modernismo femminile in Italia. Una nuova ricerca tutta dedicata, nel solco degli studi di Paola Gaiotti e Roberta Fossati sulle élites femminili, alla loro presenza nel nostro Paese, tra fine ‘800 e inizio ‘900, in diverse reti di relazioni: di tipo personale, familiare, associativo, editoriale, di sorellanza… Ovvero i luoghi dove la dialettica modernista e quella femminista hanno favorito un impegno peculiare declinato su fronti differenti. Da quello educativo particolarmente evidente nell’attivismo pedagogico a quello del risveglio religioso, spirituale, teologico non però in senso tecnico. Da quello letterario-giornalistico e quello caritativo -sociale.
Un cristianesimo al passo coi tempi
Sostando in questi scenari, in particolare, si possono scoprire le riflessioni e il dinamismo di donne di diversa estrazione capaci di attivare fra loro rapporti realmente fecondi. Come? Esprimendo in modo innovativo il bisogno di armonizzare cristianesimo e civiltà moderna; entrando in dialogo aperto con le elaborazioni maschili; sfruttando i margini a loro concessi da una società nei periodi qui di riferimento fortemente imperniata sulla centralità del maschile, spesso pronta specie negli ambienti cattolici – ad osteggiarne le iniziative e a colpire queste “cavalieresse dello Spirito Santo” o “amazzoni del cattolicismo puro” (com’erano definite), attraverso condanne e censure ecclesiastiche.
Come accadde ad Antonietta Giacomelli, figlia di una pronipote di Antonio Rosmini, critica severa del formalismo di tanta religiosità femminile, fautrice del rinnovamento liturgico e del conseguente ritorno al cristocentrismo, in sintonia con le pastorali coeve di Geremia Bonomelli. Oppure a Elisa Salerno, vicinissima alle istanze riformatrici portate avanti attraverso diversi giornali a sostegno di un femminismo sociale, critica dell’antifemminismo nell’esegesi biblica e nella tradizione teologica cattolica. Luisa Anzoletti, legata all’eredità del cattolicesimo risorgimentale e conciliatorista, auspice di un nuovo patto tra la scienza e la religione. Sofia Bisi Albini, scrittrice animata di spirito patriottico, fra le prime italiane ad agitare le questioni femminili. Angela Petracchi Manfroni, interprete di un fröbelismo che voleva staccare dalla pedagogia positivista per avvicinarlo a quella rosminiana, operazione rimasta senza sviluppi.
La categoria di “intermodernismo” come ponte tra due territori
La cifra del loro lavoro e di altre protagoniste su diversi fronti è qui analizzata anche nell’evoluzione di non poche interconnessioni. Ed è affrontando questo tema, oltre l’asse portante della dimensione di genere, che De Giorgi introduce nel suo approfondimento un ulteriore approccio metodologico con la categoria di “intermodernismo”. Ben convinto con Kristin Bluemel che «pensare in termini di tre – “intercrea sempre una connessione o un ponte tra almeno altri due territori». E che «il ponte non è meno importante dei territori». Da qui, per riuscire a connettere nella loro autonoma specificità, femminismo e modernismo, lo studioso – nella sua originale galleria – assegna ampio spazio all’intermodernismo di donne celebri come Maria Montessori o Grazia Deledda. Se la prima «per tutto il mondo riscosse il plauso del suo metodo educativo», e se la seconda «diede vita a tante figure muliebri d’interesse mondiale» – osservava Valeria Benetti Brunelli in una riflessione del ‘33 – lo dovettero «al partecipare, con lo speciale privilegio del loro ingegno, alla nuova rinascita del pensiero femminile italiano».
Recensione di Elisa Roncalli e Marco Roncalli (da Avvenire del 4.01.24)
Fulvio De Giorgi, Il modernismo femminile in Italia, Morcelliana, Brescia 2023, pp. 258