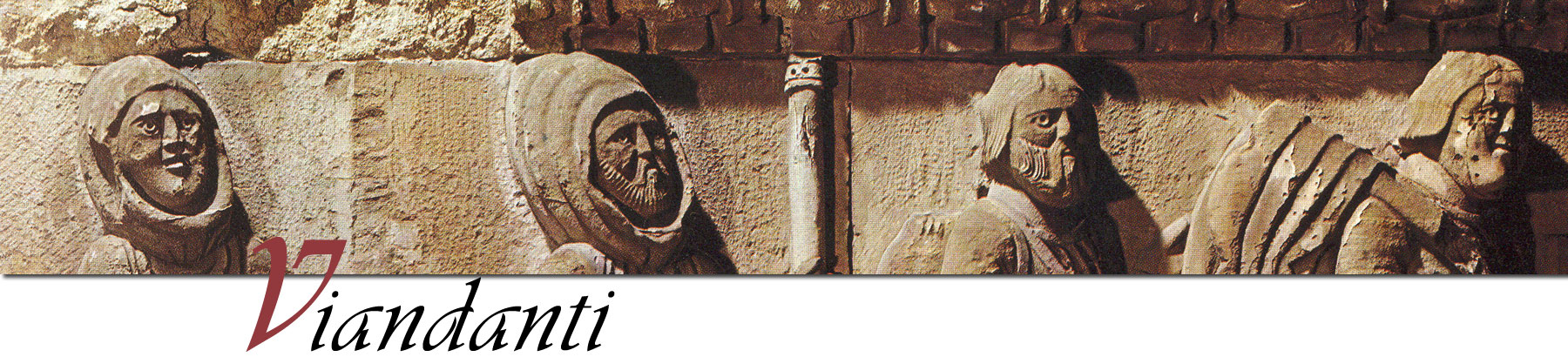LA SOCIETÀ DELL’ANALGESICO
Rick DuFer
Perché mai non dovremmo tutti desiderare un’anestesia eterna che ci doni l’incapacità di provare dolore, sofferenza o fatica? Considerata superficialmente, la questione pare indiscutibile: se esiste un modo per eliminare tutto ciò che mi fa soffrire, perché mai non dovrei buttarmici a capofitto?
Se davvero esiste un “lubrificante universale” in grado di eliminare tutti gli attriti, gli spigoli e le asperità dell’esistenza, a chi devo dare tutti i miei soldi per averlo?
Un fraintendimento
Chi la pensa così fraintende due cose fondamentali: la prima è la funzione del dolore, la seconda è il rapporto tra la mente e la realtà. Sono due cose sulle quali bisogna soffermarsi un po’, per comprenderne le implicazioni.
In una società in cui l’analgesico è sempre a portata di mano e il benessere è riuscito a penetrare ogni anfratto della vita, è molto facile fraintendere la natura e la funzione del dolore.
L’idea che soffrire sia una malattia e non il sintomo di una malattia ha convinto molti che intervenendo sul dolore si riesca a debellare la malattia.
In alcuni casi è vero, e lo stesso vale per una delusione d’amore, il tradimento di un’amicizia, la morte di un parente: in tutti questi casi, la sofferenza che consegue al fatto potrebbe essere letta come un puro effetto collaterale e perciò meritevole di essere soppressa.
Come un analgesico non andrà a inficiare la guarigione, altrettanto un antidepressivo non ritarderà l’elaborazione del lutto.
Anzi: essi potrebbero facilitare, in una certa misura, la ripresa di una normalità che è stata messa in pausa da quell’inconveniente. In altre parole, il significato di quel dolore ci risulta già manifesto, e non ha altre funzioni se non quella di segnalare quel che già sappiamo.
Ma il dolore, tanto quello fisico quando quello psicologico ed emotivo, non è sempre così. Un dolore all’anca potrebbe segnalare un’ernia, un ematoma, ma anche la presenza di qualcosa di grave, come un tumore; una sofferenza psicologica potrebbe segnalare il disagio per la litigata del giorno precedente, ma anche il sospetto di un tradimento, una fobia latente, un’angoscia che avremmo bisogno di portare a galla. In questi casi, l’analgesico non solo non interviene sulla vera causa della sofferenza, ma nasconde il segnale, impedendoci di svelarne le vere radici.
Risalire alla sorgente
Il dolore, perciò, non è soltanto la conseguenza sensibile di un trauma, sia esso fisico o emotivo, ma anche e soprattutto il segnale di ciò che soggiace a quel dolore. Il lavoro della mente pensante, allora, non è quello di spegnere il segnale appena si manifesta, ma quello di svolgere un reverse engineering della sofferenza, risalendola come il corso di un fiume fino a raggiungere il vero significato, alla sorgente.
Se provo una sofferenza emotiva inaspettata per una foto di famiglia trovata in un cassetto, spegnere quel segnale potrebbe impedirmi di scoprire che, durante la mia infanzia e con le persone ritratte nella foto, è avvenuto qualcosa di brutto.
Se provo un disagio irrazionale di fronte alle immagini di un film horror, tale disagio potrebbe segnalare certi aspetti del mio carattere che fino a quel momento mi erano rimasti preclusi.
E tutti questi segnali, ben lungi dall’essere superficiali manifestazioni di “fratture” recenti, sono briciole di pane sul sentiero della mia vita che, ripercorse a ritroso, mi permetterebbero di trovare aspetti basilari dell’individuo che sono diventato.
Anestetizzare tutti quei segnali perché rappresentano un disagio che mi distoglie dal benessere e dalla spensieratezza significa precludersi la possibilità di conoscere aspetti fondamentali della mia esistenza, “segregando” una parte di me nelle profondità dell’inconscio; prima o poi essa riemergerà per chiedermi il conto.
Una cultura feconda
Da questo punto di vista, il cristianesimo ha avuto, storicamente, una funzione fondamentale nel produrre una cultura sana e feconda del dolore. Una delle idee alla base della dottrina cristiana, infatti, è proprio quella di non fuggire dal dolore e, al contrario, considerarlo un indizio di ciò che si nasconde dentro l’anima.
La dialettica della sofferenza, più in san Paolo che in Gesù, rappresenta proprio l’idea di affrontare il dolore senza volerlo anestetizzare, poiché esso significa qualcosa di più del mio semplice disagio.
“Infatti, vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra; perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte”. [2 Cor, 7, 9-19, ndr]
Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio; anzi, quante scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione! Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda.
Per il cristianesimo, la tristezza non è fine a se stessa, così come la sofferenza non si riduce al mero fatto di soffrire. Si tratta di segnali che, percorsi a ritroso, permettono di risalire alla sorgente di ciò che l’esperienza materiale del mondo ci nasconde: Dio, nel caso di San Paolo, la conoscenza di sé, per la filosofia.
Anestetizzare tali segnali con “lubrificanti” e analgesici significa spegnere la fioca luce che ci permetterebbe di percorrere il sentiero che conduce a una verità più autentica su noi stessi. Purtroppo, oggigiorno questa è l’arma più poderosa messa in campo dai demoni che vogliono invadere la nostra città interiore. L’anestesia si trasforma facilmente in dipendenza, e la dipendenza si tramuta in zombificazione, rendendoci schiavi di ciò di cui prometteva di liberarci: il dolore e gli attriti della vita.
Un rapporto falsato con la realtà
L’altro elemento fondamentale che l’anestesia ci porta a fraintendere del tutto è il rapporto con la realtà che ci circonda. […] La realtà è una materia spigolosa, e la relazione con essa è fatta perlopiù di ematomi. Fare esperienza del mondo, infatti, non è mai un venire mollemente instradati dall’infanzia all’età adulta lungo un tracciato comodo e lineare: la strada è dissestata, gli inciampi sono continui, ma sono proprio quegli attriti incontrati lungo la via a permetterci di adattarci in modo proficuo all’ambiente, che altrimenti rischierebbe di schiacciarci.
Crescere, insomma, non è una passeggiata.
Non è possibile togliere di mezzo del tutto gli ostacoli, i vicoli ciechi e i burroni, se non a costo di una totale quanto impossibile immobilità. Il mondo non è fatto a misura di me stesso, non è modellato in base ai miei desideri e alle mie aspettative. Anzi, il mondo è proprio ciò che, contraddicendomi sempre, mi impone una costante revisione del modo in cui pongo un piede davanti all’altro. Fallimenti, cadute, ferite, errori, rischi… è attraverso tutto questo che si deve passare per arrivare nella radura dove potremo finalmente riposare, prima di rimettersi in cammino.
Un percorso solitario
Nel ciclo di Re Artù, dove la vita è raccontata come una continua avventura, i cavalieri, a un certo punto, devono mettersi in marcia alla ricerca del Sacro Graal. Prima di partire, il narratore ci dice: “Pensarono che sarebbe stato un disonore partire in gruppo. Così ciascuno si addentrò nella foresta in un punto a sua scelta, là dove era più oscura, e non v’era alcun cammino o sentiero”.
Forse ci sembra una cosa esagerata, un po’ troppo spavalda: perché mai dovrei separarmi da tutti gli altri e addentrarmi nell’oscurità di un sentiero mai battuto?
Nella visione degli autori di questa mitologia, la vita è un percorso solitario lungo un sentiero buio che nessuno ha mai tracciato. Quello che dobbiamo fare, perciò, è abbracciare il carattere avventuroso della vita e comprendere che non c’è alcuna salvezza se non nell’affrontare i rischi e pericoli, nel sopportare gli spigoli imparando dagli ematomi, nel gettarsi a capofitto nell’ignoto senza conoscere gli esiti finali.
Ma se da un lato non dovremmo essere incoscienti e folli come i cavalieri della Tavola Rotonda, non dovremmo neanche essere, all’opposto, immobili e anestetizzati, spaventati dal minimo rumore e terrorizzati dal mettere piede anche nella strada meglio illuminata, solo perché rischiamo di farci male.
Nel passo citato del ciclo di Artù, il Sacro Graal non è altro che la conoscenza di sé, la verità ultima, che permette a chi lo trova di essere finalmente un tutt’uno con se stesso, non più frammentato, non più disperso. […]
Chi cerca l’anestesia, chi non vuole incontrare spigoli, chi desidera rimanere immobile ed assuefatto a ciò che, ormai, gli ha invaso la città interiore, non potrà mai raggiungere il Sacro Graal, poiché i demoni hanno già preso il comando della sua mente, della sua vita e del suo mondo.
Ma, come tutti sanno, l’anestesia è fatta per addormentare: pur permettendoci di non provare dolore quando il chirurgo ci sta operando, al tempo stesso ci toglie qualsiasi movimento, consapevolezza e reazione.
Ora, immaginiamo che al posto del chirurgo ci sia un’orda di malintenzionati che, approfittando della nostra inabilità, tentasse di prendere il controllo della nostra mente e del nostro corpo.
Con questa anestesia stiamo lasciando che i demoni approfittino del nostro desiderio di fuga dal peso dell’esistenza, e questa è la radice di tutti i disagi dell’uomo contemporaneo.
Rick DuFer
Filosofo, divulgatore e performer. Autore del volume Critica della ragion demoniaca. Quali forze sono al comando della tua vita? (Feltrinelli 2024). Rick DuFer (Thiene, 1987), pseudonimo di Riccardo Dal Ferro, porta avanti da anni un progetto di divulgazione letteraria e filosofica sul web attraverso il suo canale YouTube e il podcast Daily Cogito, che si trova su Spotify, iTunes e Spreaker.
Il presente testo è stato ripreso dal blog “Appunti” di Stefano Feltri
[Pubblicato il 20.4.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: https://www.neldeliriononeromaisola.it]