LE DONNE DIACONO: UN SEGNO DEI TEMPI
Giacomo Canobbio
A volte le pratiche precedono le dottrine e queste si modellano in seguito ad alcune intuizioni che hanno poi bisogno di trovare giustificazione e quindi illustrazione. È noto che, a partire dalla fine del primo millennio, nella Chiesa latina il diaconato è stato considerato semplicemente un gradino di passaggio al presbiterato, e solo con il Vaticano II si è aperta la possibilità di valorizzarlo come stato permanente, oltre che come grado del sacramento dell’Ordine.
L’insegnamento del Vaticano II
La Costituzione Lumen gentium, al n. 29, dopo aver descritto quali funzioni i diaconi dovrebbero svolgere, afferma che “il diaconato potrà essere in futuro restituito come proprio e permanente grado della gerarchia”. Le ragioni che hanno portato a questa decisione – per la verità piuttosto debole: si noti il verbo “potrà”, che rispecchia la resistenza di alcuni padri conciliari – vanno cercate in due fattori: a) la riscoperta della figura di Chiesa dei primi secoli da parte della teologia nei decenni precedenti al Concilio portava a riprendere funzioni allora presenti e nella Chiesa latina quasi dimenticate; b) le necessità della missione.
Questa seconda ragione, che già espressa in LG 29, assume un nuovo accento nel Decreto Ad gentes, dove al n. 16 si lascia alle Conferenze episcopali restaurare l’ordine diaconale come stato permanente, riconoscendo funzioni già attuate da alcuni uomini dove si riscontra scarsità di clero. Nella prospettiva di questo Decreto l’imposizione sacramentale delle mani non è per completare l’articolazione del ministero ordinato, bensì per dare un riconoscimento ufficiale al diaconato di fatto già esercitato da alcuni uomini (viri) mediante la predicazione della parola di Dio come catechisti, la guida di comunità cristiane lontane (a questo riguardo merita attenzione che non si usino i verbi praesidere o preesse, bensì moderari; non a caso si scrive che i diaconi svolgono questa funzione a nome del vescovo o del parroco), l’esercizio della carità con opere sociali e caritative.
Nel testo di AG merita attenzione che l’imposizione sacramentale delle mani sia fatta risalire agli Apostoli, benché non si dica che il grado del diaconato sia di origine apostolica. In effetti, in LG 28, quando si introduce la descrizione del ministero presbiterale, non si dice che l’articolazione gerarchica in vescovi, presbiteri e diaconi, sia di istituzione divina, bensì che lo è il ministero ecclesiastico; questo poi “è esercitato in diversi ordini da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi”. Da questo fugace sguardo al Vaticano II si può affermare che il Concilio ha aperto un sentiero, ma non ha segnato il tracciato completo.
La recezione del Vaticano II
Toccherà all’esperienza successiva dare corpo alle intuizioni originarie, sotto l’impulso delle necessità della missione e della riflessione teologica. Questa, oltre che riprendere e sviluppare le ricerche soprattutto storico-liturgiche dei decenni precedenti al Vaticano II, prestava attenzione alla visione delle altre Chiese, soprattutto Ortodosse nelle quali il diaconato era stato conservato.
Gli ambiti di ricerca spaziavano dalla rilettura del Nuovo Testamento, alle pratiche dei primi secoli, alle ragioni dell’abbandono di questo ministero come stato permanente nella Chiesa latina, alla particolarità di questo grado del ministero rispetto agli altri due (episcopato e presbiterato), alla possibilità di riconoscere anche alle donne l’ordinazione sacramentale per il diaconato.
I risultati delle ricerche non sono comunemente condivisi: ne è sintomo il fatto che la Relazione presentata al papa al termine della prima tappa del Sinodo nell’ottobre 2023 parli di “incertezze” relativamente alla teologia del ministero diaconale e dia conto – pur in forma sommaria – di una pluralità di esperienze (cfr. n. 11g.i), per non dire della divergenza di opinioni circa la possibilità del diaconato femminile.
Al fondo delle “incertezze” e divergenze stanno questioni di carattere generale, circa la normatività delle figure di Chiesa attestate nel Nuovo Testamento, il significato di Tradizione, la capacità di prestare attenzione sia alle necessità odierne della missione sia ai segni dei tempi, tra i quali fin dal pontificato di Giovanni XXIII è riconosciuta la consapevolezza delle donne di avere gli stessi diritti dei maschi.
Quale via di uscita?
Per tentare di uscire da queste “incertezze” pare non si possa pretendere di trovare nel Nuovo Testamento indicazioni precise: anche il testo più citato per descrivere il compito dei diaconi come servizio alle mense (cfr. At 6,1-6), a ben guardare, non prova alcunché; di fatto gli unici due “diaconi” dei quali si parla dopo averne enumerato sette, cioè Stefano e Filippo, fanno tutt’altro che servire alle mense.
Questa constatazione potrebbe avvalorare un’opinione, secondo la quale i diaconi nelle Chiese primitive svolgevano un compito missionario: portare il Vangelo oltre i confini delle comunità già stabilite. Quand’anche si accettasse questa opinione – da non scartare facilmente in nome della diakonia, che nel greco ambientale significava appunto servizio alle mense: tenendo conto dei due esempi addotti, il servizio da svolgere è anzitutto quello della Parola che fa vivere; non a caso diakonia è tradotto con “ministero”, e questo nel Nuovo Testamento è anzitutto ministero della Parola – non si potrebbe rendere questa funzione l’unica che il diacono dovrebbe svolgere: nel corso del tempo, infatti, sono state e sono le necessità della missione che configurano le forme del ministero; sicché pretendere che dalla comprensione “dogmatica” del diaconato derivi una sola funzione sarebbe non tenere conto né delle ragioni che a esso hanno dato origine né delle variazioni che lo stesso ha conosciuto.
L’unica acquisizione che pare indiscutibile – stando almeno al Vaticano II e alla recezione di questo – è che il diaconato appartiene al ministero ordinato. Va però precisato che vi appartiene in una forma singolare. Lo si coglie già dall’espressione che si legge in LG 29: «In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali vengono imposte le mani “non per il sacerdozio, ma per il servizio (ministerium)”». L’espressione, con la citazione decurtata delle Costituzioni della Chiesa egiziana, dove dopo ministerium poneva episcopi, per ricordare che nell’ordinazione dei diaconi solo il vescovo impone le mani, vuole precisare che il ministero del diacono non è sacerdotale, come invece quello del vescovo e del presbitero.
La precisazione è utilizzata da coloro che ritengono possibile il diaconato ordinato anche per le donne. La questione attiene alla Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Ordinatio sacerdotalis (22 maggio 1994), con la quale si dichiarava chiusa la questione del sacerdozio alle donne. Ora, se il ministero diaconale non è sacerdotale, si può superare l’ostacolo rappresentato dalla dichiarazione appena ricordata. Può apparire un escamotage, ma si può anche leggere come un modo per affrontare la questione con rigore teologico: la teologia non può prescindere dal Magistero.
Donne diacono?
Ovvio che la ragione per conferire anche alle donne l’ordine del diaconato è di altro genere: attiene alla missione della Chiesa nella condizione attuale. Non si tratta semplicemente di rincorrere le istanze “rivendicative” delle donne, come alcuni ritengono, e quindi di soggiacere agli orientamenti della cultura. Si tratta piuttosto di comprendere come prestare attenzione ai segni dei tempi: non si può dimenticare che la cultura aiuta ad ampliare la comprensione della Sacra Scrittura e che la Tradizione non è ripetizione del passato, bensì sviluppo di questo, in fedeltà creativa.
Va messo in conto che il diaconato femminile, come ogni innovazione, può sembrare rottura: la preoccupazione per la continuità quando sono in gioco questioni fondamentali è segno di sapienza. Va però altresì messo in conto che lo Spirito può aprire percorsi inediti quando si tratta di attuare la missione. Osservando le dinamiche “innovatrici” che il Nuovo Testamento ci attesta, ci si può domandare se dalla vita delle comunità primitive non si possa imparare una fedeltà creatrice piuttosto che una riproposizione di una delle figure che esse ci hanno lasciato in eredità ed è diventata quella maggiormente riconosciuta.
La richiesta di un diaconato femminile manifestata anche durante il Sinodo per l’Amazzonia, oltre che dalla riflessione delle teologhe, va considerata con attenzione e ponderazione, ascoltando anche le esperienze delle altre Chiese cristiane, stante il fatto che a partire dal Vaticano II si è riconosciuto che lo Spirito agisce anche in esse.
Giacomo Canobbio
Teologo e presbitero della Chiesa bresciana, già presidente dell’ATI (Associazione Teologica Italiana) e coordinatore del CATI (Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane). Ha pubblicato recentemente: Un nuovo volto della Chiesa? Teologia del Sinodo (Morcelliana 2023).
– – – – – – –
L’articolo è stato pubblicato sulla rivista “Missione Oggi” (n.2/2024). Si ringrazia la direzione per la gentile concessione.
[Pubblicato l’ 11.6.2024]
[L’immagine che correda l’articolo è ripresa dal sito: https://orthodoxdeaconess.org]







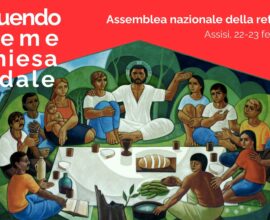
La fedeltà alla tradizione dovrebbe comprendere la fedeltà alla creatività della chiesa nascente che ascoltava lo spirito ed inventava un nuovo modo di vivere la fede.