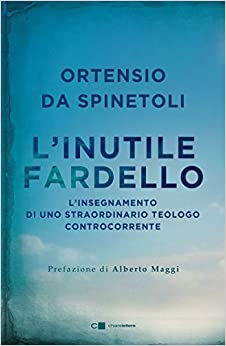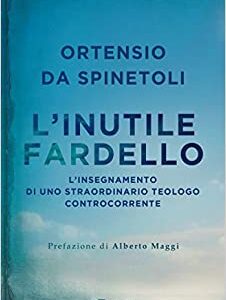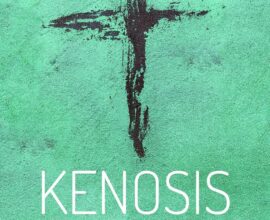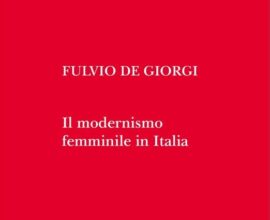L’INUTILE FARDELLO: È PROPRIO COSÌ?
Ortensio da Spinetoli, L’inutile fardello. L’insegnamento di uno straordinario teologo controcorrente, Chiarelettere, Milano 2017, pp. 112.
Recensioni di:
– Simonetta Giovannini
– Antonio Greco
– Silvio Cedolin
Nel libro “L’inutile fardello” edito da Chiarelettere (aprile 2017) è raccolta in un compendio postumo l’eredità teologica del padre cappuccino Ortensio da Spinetoli (1925 – 2015), biblista e teologo di grande preparazione e finezza, perseguitato lungo tutta la sua vita per le sue ardite intuizioni e posizioni, fino alla rimozione dall’insegnamento e all’allontanamento dal suo stesso ordine. L’emarginazione a cui fu condannato non gli tolse tuttavia la fecondità di pensiero ed egli trascorse gli ultimi trent’anni della sua vita in un’intensa attività di studio e approfondimento. Come asserisce padre Alberto Maggi nella prefazione al libro, “il pensiero di Ortensio, come un bisturi doloroso ma vitale, costringe a ripensare importanti concetti teologici che sono ancora un tabù.” Il titolo dice l’operazione di sfrondamento del messaggio di Gesù da quelli che l’autore vede come appesantimenti e inutili escrescenze formatesi in secoli di interpretazioni talvolta fuorvianti.
La premessa da cui muove padre Spinetoli è che leggere e interpretare la Bibbia sia questione di competenza più che di autorità. La competenza include la conoscenza delle lingue e dei contesti, del linguaggio e della mentalità degli autori biblici. In nome di una lettura empirica e sprovveduta dei testi sacri troppe presunte verità prive di fondamento sarebbero state imposte ai credenti.
La “demitizzazione” proposta dall’autore muove innanzitutto dalla figura di Gesù Cristo e da un imprescindibile rinnovamento cristologico che dovrebbe recuperare l’umanità terrena di Gesù, la sua proesistenza a favore degli uomini, in particolare dei più deboli e bisognosi, dei prigionieri, degli oppressi, degli affamati, degli ignudi, dei senza tetto, degli stranieri. La sua contestazione dell’ordinamento ingiustamente costituito (“deporre i potenti dai troni e innalzare gli umili” ) si conclude con il fallimento della croce. I suoi discepoli, che avrebbero dovuto ereditarne la consegna, insieme al carico di sofferenza che essa implica, non l’avrebbero compresa e accolta fino in fondo data la sua indubbia scomodità. La critica che Spinetoli muove alla cristologia tradizionale e in particolare ad alcuni tra i titoli cristologici predominanti presenta dei punti di forza e altri aspetti forse più discutibili. La mistificazione a suo avviso sarebbe iniziata già ad opera della chiesa primitiva e degli autori neotestamentari. Essa si sarebbe fondata sull’identificazione della figura di Gesù rispettivamente con le figure di origine veterotestamentaria del “giusto sofferente” (Luca), del “capro espiatorio” (Paolo) e dell’”agnello pasquale” (Giovanni) e avrebbe comportato lo spostamento dal Calvario, luogo delle esecuzioni capitali, al recinto sacro del tempio. Uno spostamento che l’autore considera un radicale capovolgimento nell’interpretazione della missione di Gesù e del farsi suoi seguaci.
In particolare l’interpretazione di Cristo come redentore, fondata sulla dottrina del peccato originale, lettura indubbiamente dominante nella liturgia e lungo tutta la storia della tradizione teologica e spirituale cristiana, viene respinta da Spinetoli in nome della lettura che vede la creazione come un work in progress, come capolavoro imperfetto del quale Dio attende la maturazione. Visione del resto oggi condivisa da molti teologi “in odore di eresia” che ugualmente contestano il peso attribuito alla teologia del peccato originale.
Connessa a questa tradizione è anche l’interpretazione, risalente alla Lettera agli Ebrei, di Cristo come Sacerdote e contemporaneamente vittima sacrificale, da Spinetoli ugualmente criticata.
Ne consegue anche la critica all’interpretazione dottrinale della messa come sacrificio eucaristico e il rifiuto della dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie del pane e del vino a favore di una prospettiva che ne dovrebbe recuperare, secondo l’autore, il valore puramente memoriale e comparativo, quindi metaforico.
Anche l’ecclesiologia dovrebbe liberarsi delle strutture e dell’impostazione gerarchico monarchica per ritrovare la vera essenza della Chiesa nella communio delle persone – non importa se esplicitamente credenti o meno, o se credenti in altra confessione o fede religiosa – animate dallo Spirito d’amore che è stato di Gesù Cristo.
La domanda che si pone il lettore è: pur concedendo che determinate interpretazioni del ruolo e della figura di Gesù abbiano avuto un peso eccessivo negli ulteriori sviluppi dottrinali, sproporzione che giustamente può essere corretta e compensata da una rinnovata considerazione dell’umanità concreta di Gesù come ci viene presentata nei Vangeli sinottici e da complementari e sottovalutate prospettive teologiche, è davvero necessario buttare a mare come inutile fardello le immagini e i simboli attraverso i quali gli autori del Nuovo Testamento, alla luce dei propri presupposti culturali e teologici, hanno letto il significato della sua missione? Certamente l’enfasi sulla sofferenza e sul sacrificio è stata storicamente eccessiva; certamente anche gli autori del Nuovo Testamento attraverso la cui mediazione conosciamo la figura e il messaggio di Gesù erano già condizionati da precomprensioni e modelli culturali che hanno influito sulla loro percezione e sulla loro presentazione del significato della sua esistenza e missione.
È utile averne consapevolezza per poter ritornare al nocciolo dell’evangelo, ovvero alla consegna dell’amore fino alla disponibilità a dare la vita per il bene dei propri simili. Ma tale disponibilità non è, per l’appunto, leggibile anche come offerta sacrificale di sé, compiuta innanzitutto da Gesù e richiesta a quanti si pongono alla sua sequela? Certamente il richiamo a questa disponibilità dovrebbe essere più forte e vivo, l’interpretazione della fede più adulta e meno consolatoria, benché di conforto abbiano spesso bisogno gli uomini proprio perché imperfetti e in via di maturazione. Il compito assegnato da Gesù agli apostoli nell’ultima cena “fate questo in memoria di me”, dove il fare non è principalmente un celebrare ma un esistere proattivo, un accettare di spezzarsi come pane e di versarsi come vino, di dare se stessi per i fratelli, non può coesistere con la fede nella reale presenza di Gesù nel pane e nel vino? La memoria in questo caso è solo la comune facoltà umana del ricordo o non è anche, contemporaneamente, un farsi presente di Cristo per nutrire e vivificare la comunità di quanti credono in Lui e intendono seguirlo?
Il libro di Spinetoli è stimolante anche perché induce a porci queste domande. Forse non tutto quello che l’autore giudica inutile fardello è propriamente tale. Lo sono di certo peraltro le enfatizzazioni, le interpretazioni unilaterali, spesso intimiste e regressive che ne sono state e ne vengono date.
Certamente in un tempo che torna a polarizzarsi su prospettive inconciliabili e irriducibili e dove la scelta pro o contro l’uomo, pro o contro l’amore e la solidarietà con i propri simili si ripresenta con una modalità radicale, questa lettura ha il pregio di ricordarci quella legge superiore dell’amore (“Amatevi come io vi ho amato”) nella quale in ultimo si riassume e compendia il Vangelo e il senso ultimo dell’incarnazione, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Così come ci ricorda che i confini tra la Chiesa istituzionale e visibile e quelli, noti a Dio soltanto, della Chiesa invisibile radicata nell’amore non sono sovrapponibili che in parte.
Simonetta Giovannini
***
“Non è facile togliere di mezzo i vescovi e gli esponenti dei dicasteri romani, ma se questi potessero provare a tacere, se non altro per il troppo parlare che hanno fatto fino adesso, ne avrebbe senz’altro un gran beneficio tutta la comunità credente.
La bibbia non è un libro qualsiasi, tanto meno da strapazzo come purtroppo lo trattano i nostri pastori con il loro uso disinvolto, quasi distratto, sempre impreparato, bensì uno scritto del tutto singolare, veramente raro: non basta aprirlo e leggerlo per comprenderne il significato” (pag.9).
A due anni dalla morte avvenuta il 31 marzo 2015, gli amici di padre Ortensio da Spinetoli pubblicano per Chiarelettere di Milano, un volume postumo di scritti del grande biblista e teologo marchigiano, dal titolo L’inutile fardello.
Il testo è di appena 80 pagine, molto agile e si legge tutto di un fiato.
La prefazione è di Alberto Maggi, direttore del Centro Biblico “Giovanni Vannucci” di Montefano, che si è sempre dichiarato ammiratore e debitore di padre Ortensio.
Segue una introduzione di Gianfranco Cortinovis, un imprenditore bergamasco, discepolo, amico ed ‘erede letterario’ dell’autore.
Una lettera a un giovane confratello, scritta nel 2014, un anno prima della morte dell’autore, precede e accompagna il lungo fascicolo e indica il destinatario del testo: il “nuovo clero”, che “sembra essere stato protetto, tenuto al riparo dalle arie, ossia dalle correnti innovatrici che nonostante tutto hanno continuato a circolare dentro e fuori la chiesa”.
Nelle premesse, oltre alla necessità del rinnovamento esegetico (“in una panoramica fatta di evoluzioni e trasformazioni, solo la teologia è rimasta statica”) è indicata anche la spiegazione del titolo del libro: “liberare i fedeli dai tanti inutili pesi che i maestri di turno…hanno posto sulle loro spalle”.
Seguono quattro interessanti capitoli: interpretazioni della figura di Gesù; il centro della vita della chiesa: l’eucarestia; equivoci di fondo; le grandi “eresie”. Alla conclusione seguono tre appendici: Lettera a Papa Francesco (“richiesta di un raduno dei “dispersi d’Israele” cioè di quanti nella chiesa hanno subìto incomprensioni, preclusioni, esclusioni, condanne, a motivo non di reati ma delle loro legittime convinzioni teologiche, bibliche o etiche”); una breve biografia dell’autore e una bibliografia annotata delle opere di padre Ortensio da Spinetoli (1925-2015).
L’autore
Ortensio, francescano cappuccino, ha vissuto la sua scelta monastica da persona semplice, fuori da qualsiasi schema religioso, da uomo del dialogo con tutti, con una tenace spiritualità radicata in Gesù, da insegnante libero e da sognatore di un nuovo futuro per la chiesa.
Persona umilissima, “uomo di squisita intelligenza, il suo sguardo acuto aveva la scaltrezza dei contadini marchigiani, da sempre abituati a sopravvivere ai soprusi dei loro padroni”, ha anticipato, “di almeno 50 anni“, afferma Alberto Maggi, l’esegesi evangelica che oggi una sempre più nutrita parte della Chiesa ha fatto sua anche se molta parte di essa è rimasta ferma e ancorata ai pensatori medioevali.
I contenuti del libro
La vera rivelazione o rivoluzione messianica “non è il primato di Dio, che non aveva bisogno di riconoscimenti, bensì quello dell’uomo, di ogni uomo, soprattutto se povero, affamato, ignudo, forestiero, prigioniero (Mt 25, 31-46)”. Gesù “non aveva preannunciato un nuovo culto, né stabilito un diverso giorno per onorare il Signore, ma al contrariosi era grandemente, per non dire principalmente, preoccupato del rinnovamento dei rapporti interumani” (pag. 60).
Antonio Greco
Questa recensione è stata pubblicata dal sito “Manifesto 4 ottobre” (16 aprile 2017), che aderisce alla Rete dei Viandanti.
***
Quando si parla di cristianesimo, di spiritualità, di fede di solito vengono tirati in ballo due concetti: verità e obbedienza.
Io invece penso che ogni discorso sulla fede debba essere accompagnato da due concetti apparentemente opposti: dubbio e libertà.
Ogni scelta di fede, se sincera, nasce da un’urgenza, una ricerca di senso rispetto all’esistenza. Senza dubbio non c’è tensione verso la ricerca, non c’è bisogno di un significato.
Una scelta di fede, poi, non può che essere libera. Essa, infatti, riguarda e coinvolge la totalità della vita e non può essere in nessun modo imposta, se non vuole diventare una menzogna.
Dubbio e libertà, a me sembra, sono stati a lungo compagni di viaggio di Ortensio da Spinetoli, assieme ad un grande amore per Gesù di Nazareth. Un amore talmente libero da non accettare compromessi, né ripensamenti, né opportunismi. Quando gli sarebbe stato, forse, facile conservare una posizione comoda, ha deciso di tirare dritto per la sua strada, con onestà e libertà, affrontando le conseguenze del suo coraggio, “bevendo il calice” fino alla fine.
In questo “inutile fardello”, pubblicato postumo, ritroviamo tutto Ortensio, la sua gentilezza, la sua ferma determinazione, l’incredibile freschezza del suo discorso su Gesù.
Perché quello che più mi entusiasma di Ortensio da Spinetoli, è come sia riuscito a ridare vita al vangelo, spesso coperto di una polvere dottrinale che finisce per tenerne lontane le persone, a impedire che venga letto.
Perché in Gesù c’è una incredibile forza esistenziale, capace di parlare ancora all’uomo di oggi. Una forza però imbrigliata, ingessata, spesso resa innocua da catene concettuali che sembrano fare di tutto per tenerla lontana dalla realtà. Perché Gesù relegato sulla sua nuvoletta dorata è splendido da ammirare, da adorare, ma finisce per essere innocuo per i potenti di questa terra, per quanti praticano e prosperano con l’ingiustizia.
L’insegnamento principale che mi ha dato (e che continua a darmi) il nostro amato Ortensio è che solo sporcandosi con la fragilità, con la debolezza, con la fallibilità di noi uomini e donne Gesù può riuscire a parlarci.
Perché solo se si rivela essere uno di noi può diventare un esempio per tutti noi.
Ecco quindi che le educate parole di Ortensio hanno la forza di picconate nell’enorme cattedrale di cemento e immobilità che sembra essere diventato il cristianesimo in questi tempi di crisi. Dubbio e libertà possono essere strumenti vitali dove l’obbedienza spesso nasconde semplicemente la difesa di una posizione di potere.
Perché io credo che una fede che si rifugia nell’immobilismo, nel rifiuto del dialogo (anche aspro), nella ritualità fine a se stessa sia come una pianta che sta inaridendo.
Perché io spero in un cristianesimo che sia una comunità in cammino che inciampa, sbaglia, cambia strada, piuttosto che un esercito dove una moltitudine di soldati debba cieca obbedienza al proprio generale in bianco.
Perché, anche se illuminato, un sovrano non potrà mai essere un fratello.
Perché senza libertà non può esserci, secondo me, una vera scelta di fede ma semplicemente un arruolamento.
Trovo un vero peccato che Ortensio da Spinetoli sia stato così poco ascoltato, ma le grandi idee, forse, una strada, in qualche modo riescono sempre a trovarla.
Silvio Cedolin
Questa recensione è stata pubblicata dalla rivista “Tempi di fraternità” (n. 4/2020, p. 7), che aderisce alla Rete dei Viandanti.