SE IL SEME NON MUORE…
Il Cardinale Martini
e il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee)
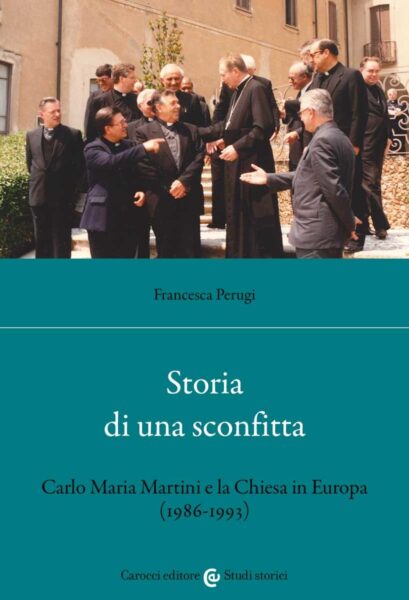
La ricerca della Perugi [1] mette in luce, in particolare, il ruolo svolto all’interno del CCEE (impegnato nella promozione della collaborazione fra le Conferenze episcopali d’Europa) da un gruppo di vescovi che aveva in Martini uno dei suoi punti di riferimento, chiamato “gruppo di San Gallo” (dalla città svizzera sede del Consiglio). Il gruppo, conscio della responsabilità dei vescovi e delle conferenze episcopali d’Europa nell’evangelizzazione del continente, era fortemente impegnato nella promozione, attraverso il Consiglio, di un rapporto tra i vescovi europei “affettivo” ma anche “effettivo” (a guisa della struttura ecclesiastica che collegava i vescovi dell’America Latina -CELAM-, dell’Asia, dell’Africa …).
La Perugi rilegge tutta la vicenda del CCEE, iniziata nel 1965 su proposta del card. R. Etchegaray, arcivescovo di Parigi, ma concentra la sua attenzione sui sette anni, dal 1986 al 1993, in cui l’organismo ebbe come presidente il card. Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano.
La storia della chiesa europea è poco conosciuta, ancor meno la vicenda del CCEE e il perché quest’organismo viene profondamente riformato nel 1993.
La costituzione pastorale Gaudium et Spes del 1965, anche se redatta con un cammino incerto e tormentato[2], aveva aperto la stagione di una prospettiva positiva e ottimistica della storia e di una chiesa non contrapposta alla modernità ma solidale con il genere umano e lievito di giustizia e di pace. Vent’anni dopo[3], si apriva una lunga camminata nel deserto della Chiesa cattolica e trovava sempre più spazio rumoroso la Chiesa dell’anticoncilio, con i tradizionalisti alla riconquista di Roma[4] (per usare il titolo di un testo di Giovanni Miccoli).
Il testo della Perugi studia il collo di questa clessidra ecclesiastica e spiega, documentando, il perché di questo ribaltamento. La ricerca storica è frutto di un dottorato presso il Dipartimento di Scienze religiose dell’Università “Cattolica del Sacro Cuore”. Con una metodologia rigorosa, l’autrice ha scandagliato prevalentemente due archivi: l’Archivio storico diocesano di Milano (Fondo Martini) e quello del CCEE di San Gallo. Le fonti documentarie sono corredate da interviste a personaggi chiave ancora viventi. Fra gli altri: il vescovo Ivo Furer, segretario del CCEE; Camillo Ruini, protagonista del periodo ricostruito; Gianni Cesena, Segretario di Martini.
Ricco di idee, scrittura semplice e avvincente, il testo è accessibile anche a chi non è specialista della materia. L’autrice sembra quasi sorpresa di poter raccontare, con la libertà e senza vincoli, un conflitto fra i più alti livelli della gerarchia ecclesiastica, avvenuto in un tempo non troppo remoto (Per un approfondimento vedere Scheda 1).
Due diverse visioni di Chiesa
L’introduzione al testo si apre con una citazione di Giovanni Miccoli: “Le grandi alternative mancate, il cercare di scoprire la presenza (…) di potenzialità reali che non hanno avuto crescita, che sono emarginate o sconfitte, riassorbite o piegate ad esiti e fini diversi da quelli che si profilavano alle origini. (…) Quando nel corso di una ricerca ci si incontra, o si ha l’impressione di incontrarsi, con uno di tali momenti, è difficile sfuggire”.[5]
Alternative mancate, potenzialità emarginate e sconfitte, esiti e fini diversi da quelli delle origini: è ciò che emerge dai documenti e dalle fonti studiate dalla giovane Perugi. Con coraggio e con parresia, mai con tono apologetico, sempre con rigore critico, la studiosa ha raccontato una battaglia tra due correnti, ciascuna convinta di avere un’immagine di chiesa diversa dall’altra, che si danno battaglia al vertice della piramide del potere della chiesa cattolica: quella rappresentata dal card. Martini e del “gruppo di San Gallo” e quella del card. Ratzinger, poi Benedetto XVI, di Ruini e di quasi tutta la Curia Romana, compreso papa Giovanni Paolo II. “La contrapposizione è reale”, sostiene Perugi. Martini “proponeva effettivamente un’idea di Chiesa diversa rispetto a quella di Giovanni Paolo II e auspicava riforme radicali per realizzarla. La questione è che per i tradizionalisti queste riforme avrebbero concorso a indebolire la Chiesa cattolica, secondo Martini invece erano l’unica risposta credibile di fronte a una società che era cambiata profondamente a partire dal Dopoguerra” (pag. 15).
Le due correnti del conflitto, precisa Perugi, non hanno messo “mai in discussione l’appartenenza ad una medesima istituzione” (19), né messo in gioco l’autorità della chiesa.
Le due diverse visioni di chiesa sono sorrette da due letture culturali profondamente diverse della modernità, della secolarizzazione, del socialismo reale, delle democrazie liberali, dell’Europa e delle sue radici.
“Il CCEE fu comunque il luogo, l’occasione, in cui questi vescovi (il gruppo di San Gallo) si incontrarono e maturarono una serie di posizioni sulle questioni della Chiesa nel mondo moderno diverse da quelle prevalenti nella curia romana” (pag. 29).
Ed è proprio la dimensione culturale dello scontro ai vertici della chiesa cattolica (si veda in proposito la scheda n.1) uno dei motivi più interessanti per leggere il testo della Perugi, anche per chi ha allergia per i temi ecclesiastici.
Storia di una sconfitta?
Con la elezione del nuovo presidente del CCEE nell’aprile del 1993 il gruppo di San Gallo esce di scena. Quello che accadde dopo Basilea, nel sinodo speciale per l’Europa nel dicembre del 1991, e la definitiva riforma del CCEE, voluta dal Vaticano e fatta su misura per escludere qualsiasi possibilità a Martini di parteciparvi, fanno sostenere alla Perugi che quella del gruppo di San Gallo rimase una linea minoritaria, scartata come opzione e ininfluente sul futuro della Chiesa in Europa.
La tesi della sconfitta del gruppo di San Gallo, sostenuta dalla Perugi, appare ineludibile ed è racchiusa nel titolo del libro: “Storia di una sconfitta”. Senza nessuna incertezza, con una sottile melanconia, il titolo afferma che nello scontro tra le due visioni di chiesa, esce sconfitta quella di Martini. La lettura per intero del libro lascia intuire, invece, che si tratta di una “sconfitta” evangelica: “se il seme non muore…”. Lo stesso Martini in una intervista rimasta famosa dell’agosto del 2012, sostenendo che “la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni” (pag. 167), indica, secondo me, anche il tempo lungo in cui il seme del Vangelo, al centro della visione del gruppo di San Gallo, apparentemente caduto e sepolto, sarebbe rimasto nel terreno della storia prima di germogliare. (Per un approfondimento vedere Scheda 2).
Per un concilio di “madri” e di “padri”
Terminata la lettura della Perugi ci si chiede se la storia del gruppo di San Gallo non abbia anche dei limiti. Un limite appare evidente: la esperienza del CCEE è rimasta chiusa negli spazi angusti dei vertici della struttura ecclesiastica e non ha coinvolto per nulla la base del popolo cristiano.
“Una Chiesa trasformata dal popolo”, titolo di un testo di Harvè Lagrand[6], protagonista del gruppo San Gallo, più volte citato nel testo di Perugi, indica la via da percorrere per uscire dalla tempesta che sta attraversando i vertici della chiesa mondiale. Perché questo avvenga occorre capovolgere la piramide ecclesiale, senza retorica, con una profonda revisione delle categorie ministeriali. Ma dove sono “le chiese di popolo”? In Germania, in Francia, in Svizzera, in Italia… sempre più persone voltano le spalle alla chiesa istituzionale, per motivi diversi. La grammatica della secolarizzazione si fa sempre più profonda e nessuno sa che cosa può accadere.
La via del Sinodo del 2023-2024 sulla sinodalità della Chiesa (anche questa via, purtroppo, villanamente sbeffeggiata da un cardinale che ha definito tale Sinodo «un incubo tossico»), avviata da papa Francesco, potrebbe darci qualche bella sorpresa, almeno su temi non dogmatici. Ma se occorre revisionare gli attuali ministeri e se la domanda sul ruolo della donna nella Chiesa è quella decisiva per il futuro (come sosteneva il documento finale dell’assemblea di Basilea) e, comunque, se – come ha recentemente sostenuto Luigi Sandri – spetta alle donne, non ai “padri”, decidere “se” e “quali” ministeri ecclesiali loro possono accogliere o rifiutare, “tutto porta a ritenere che, al di là del Sinodo, occorre un Concilio di “padri” e di “madri”( si veda in proposito la scheda n.2) per affrontare temi dottrinali irrisolvibili stando al magistero vigente. Impresa asperrima che graverà su più pontificati.”
Antonio Greco
Membro del Gruppo Manifesto4ottobre di Brindisi, aderente alla Rete Viandanti
Francesca Perugi, Storia di una sconfitta, Carlo Maria Martini e la Chiesa in Europa 1986-1993, Carocci, Roma 2022, pp. 176
[1] Francesca Perugi, cultrice della materia in Storia del cristianesimo nel Dipartimento di Scienze religiose dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, collabora con la Fondazione Carlo Maria Martini ed è membro del Consiglio d’indirizzo dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Si occupa di storia del cristianesimo contemporaneo e nel 2021 ha vinto il premio biennale Lorenzo Bedeschi per la migliore tesi di dottorato sul riformismo religioso in età con contemporanea.
[2] Il risultato della votazione ufficiale della costituzione fu: su 2391 votanti, placet: 2309; non placet: 75. Cfr. Giovanni Turbanti, Un Concilio per il mondo moderno, Il Mulino, Bologna 2000.
[3] Con la seconda Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, il 24 novembre-8 dicembre 1985, in occasione del ventesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano.
[4] Giovanni Miccoli, La Chiesa dell’anticoncilio, I tradizionalisti alla riconquista di Roma, Laterza, Roma-Bari 2011.
[5] G. Miccoli, Una storiografia inattuale?, in G. Battelli, D. Menozzi (a cura di), Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la funzione civile della ricerca storica, Viella, Roma 2005, p. 17.
[6] H. Legrand-M. Casmdessus, Una Chiesa trasformata dal popolo, Paoline, Milano 2020. Cfr. Recensione in: https://manifesto4ottobre.blog/2022/03/03/la-chiesa-popolo-di-dio-un-richiamo-perentorio/







