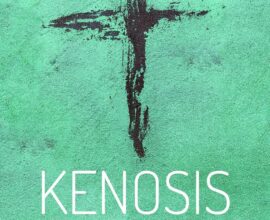UNA FEDE COMPRENSIBILE ALL’UOMO CONTEMPORANEO

Anno della Fede? (Quasi) tutti sono informati, ma che significa “fede”? Qui sorgono i dubbi e i distinguo. Fede sta per “fiducia” in qualcosa o in qualcuno. Parlare di fede significa riallacciarsi ad un “credo”, che per i cristiani diventa “il” Credo, un compendio delle verità su Dio, Gesù Cristo, la Chiesa, l’uomo, il mondo, il presente e il futuro. In altre parole una serie di “verità” che il “fedele” è tenuto ad accettare, quasi una tessera di riconoscimento per ritenersi parte della Chiesa cattolica romana. Eppure dire “io credo” rappresenta ben più di un distintivo da appuntarsi sulla giacca per fissare un’identità, perché abbraccia convinzioni che legano la mente e il cuore. Nessuna meraviglia quindi se può accadere che “la fede finisca per diventare un coefficiente di perturbazioni morali (scrupoli) e psichiche (manie, fissazioni, ossessioni)”.
Sono queste le premesse di fra Ortensio, cappuccino, nel suo ultimo libro di una lunga serie che ha superato negli anni la trentina di titoli. Perché lui, ora frate ultraottantenne, nel suo lungo servizio di biblista – docente agli studi teologici di Loreto e Macerata e poi al Sant’Anselmo di Roma e anche provinciale della provincia cappuccina picena – ha offerto una numerosa schiera di sussidi che aiutano a raggiungere la Parola, distinguendo (è un po’ la sua attenzione caratteristica) tra quella di Dio e le aggiunte, (che occorre riconoscere), degli uomini nella storia.
Le intenzioni che hanno condotto a questo testo le evidenzia già in premessa: “un tentativo di aiutare il credente a liberarsi dalle oppressioni interiori che una fede male intesa può generare nel suo animo”, alla ricerca di una “fede adulta”, lontana da quelle derive, anche patologiche (scrupoli paralizzanti, manie, fissazioni che impediscono relazioni serene anche col prossimo, ecc.) non sempre riconosciute. Perché se la fede diventa adulta (“purificare la fede”), al di là della tradizione o della devozione, se il cristiano ha maturato delle convinzioni proprie, se in ultima analisi, ha deciso lui stesso di “fidarsi”, al di là di ogni condizionamento, allora quella fede verrà sempre più a consolidarsi alla luce della Parola di Dio più che di ogni tipo di “incrostazioni”.
Per stabilire “cosa” si crede (o si dovrebbe credere), i noti “misteri della fede”, punto di partenza diventa il Credo e il Catechismo della Chiesa cattolica che l’Autore analizza in maniera approfondita allargando (e attualizzando) lo sguardo alla situazione della Chiesa cogliendo l’occasione dell’anniversario dei 50 anni dall’apertura del Concilio. E qui l’analisi si complica perché non ci sono sconti se ci si riferisce a quel termine “rinnovamento” di cui parlava Giovanni XXII: “purtroppo i successori invece di progredire sulle strade aperte, trovarono più convincente o conveniente provare a fare passi indietro, in concreto a ricollocarsi sulla linea tradizionale più vicina al Concilio di Trento che a quello da poco concluso”. Un segnale in questa direzione lo trova nella pubblicazione del “Nuovo catechismo” (1993) che “precisasse (!) che cosa i vescovi dovessero insegnare, i parroci ripetere, i fedeli credere, i docenti degli atenei proporre”, ma anche nella “storia dei principi non negoziabili” e di recente “il richiamo al clero sull’assoggettamento obbedienziale, fatto che da oltre mezzo secolo non accadeva più nella Chiesa”. “Forse, ipotizza, l’indizione della celebrazione dell’Anno della Fede non nasce tanto da preoccupazioni pastorali (invitare gli uomini ad esplicitare il loro segreto rapporto con Dio), quanto disciplinari, per richiamare i sudditi nell’unico insegnamento impartito dal papa e dai vescovi in comunione con lui”.
E allora ecco un Catechismo di cui l’Autore analizza intere parti indicando un’interpretazione comprensibile all’uomo contemporaneo, e mostrandone, talvolta, l’incongruenza con la sensibilità di oggi, le regole della comunicazione, le scienze umane (12 numeri che parlano di uomo in genere e nessuno specifico per la donna, ma si parla molto di angeli …, per non parlare della coppia dove non c’è la sposa, ma solo la madre), l’aderenza al testo biblico, le acquisizioni del Vaticano II, cercando di “dimostrare” le affermazioni a partire dai termini originari (ebraici o greci) per segnalare le successive traduzioni o piuttosto le “interpretazioni” o i forse troppo frequenti compromessi teologici.
E tra le pagine emerge il suo concetto di fede che va ben oltre una lettura acritica del Catechismo o una recita ripetitiva del Credo: “la fede è fare, non un semplice sentire, è anche parlare, ma soprattutto agire, costruire cioè il Regno di Dio sulla terra, il luogo dell’uguaglianza, della felicità di tutti e di ognuno”, senza dimenticare quanti non credono, perché “la vita è un dono accordato a tutti e a tutti è data ugualmente la gioia di costruirla nel modo migliore. Certo anche ai “dannati” perché anch’essi sono uomini e sono ugualmente figli di Dio, nati per essere felici nel tempo e nell’eternità”.
“La fede è senza dubbio un rapporto con Dio, ma da “persona a persona”. E’ comunione con la Verità, più che con le verità, con il Mistero invece che con i misteri. E’ presenza e accoglienza, proposta e risposta, autentica, ma informale e concettuale. La fede non si può dimostrare, si può avere e non avere, ma senza adeguate motivazioni, ragioni perché non esistono, né per asserirne l’assurdità, né per invocarne la necessità. La fede è un atto di coraggio e insieme di umiltà, un riconoscimento del proprio limite di fronte al Tutto, un’accettazione dell’Altro anche se mai visto, mai incontrato, mai ascoltato, come si incontra, si vede, si ascolta un compagno di viaggio.
La fede è la capacità di risalire al di là delle stelle e di scendere al di sotto del sensibile, di aggrapparsi ad un punto sperduto nell’infinito che non si riuscirà mai a toccare, di cui si può solo sentire molto parlare (dagli altri, da alcuni), di cui si possono avvertire i segni, al di fuori e al di dentro di se stessi (la pace o il tormento), di cui ci manca sempre la conferma o l’evidenza. “Hanno avuto visioni di angeli”, dicono i discepoli di Emmaus al misterioso viandante che si era unito a loro lungo il cammino, “ma lui non l’hanno visto” (Lc 24,23). La fede vive lo stesso dramma: si può avere la “sensazione” di qualcosa, anche la presenza di “Qualcuno”, ma il “Mistero” rimane. Accettarlo è la fede”.
Maria Teresa Pontara Pederiva